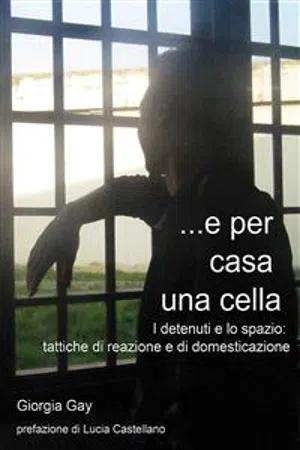
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
E per casa una cella
Informazioni su questo libro
In un contesto di profonda privazione e limitazione come quello carcerario, oggetti che fuori sono di uso quotidiano - come piccoli elettrodomestici, mensole, ferro da stiro - dentro sono vietati. Perciò i detenuti sono costretti a creare da sé ciò di cui hanno bisogno. Probabilmente non esiste posto come la prigione in cui il bricolage è uno stile di vita. Il volume approfondisce il rapporto tra detenuti e spazio in cella, le tattiche di reazione, rivendicazione e personalizzazione messe in atto dalla popolazione carceraria, ma anche gli effetti che la privazione di spazio ha sul corpo e sull'identità della persona.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
PsicologiaCategoria
Storia e teoria della psicologiaBrevi cenni teorici
Antropologia della prigione. Le ragioni di un’assenza inspiegabile
Il campo d’indagine etnografico da tempo si è spostato dalle società lontane, “primitive” - che storicamente sono state al centro del suo interesse - verso le società occidentali, moderne. Così gli antropologi hanno rivolto il proprio sguardo ai quartieri, alle scuole, alle piccole e grandi comunità. In questo passaggio però si sono dimenticati di gettare l’occhio oltre i muri di cinta. I motivi di questo disinteresse non sono del tutto comprensibili, soprattutto se si considera che il “pianeta carcere” di fatto è una comunità in tutto e per tutto «dotata di proprie norme, di propri canali di comunicazione, di un proprio linguaggio, di propri capi e dipendenti, di tutto quanto cioè costituisce la necessaria premessa di un’organizzazione sociale» (Correra M., Martucci P., 2006). È una comunità così vicina eppure lontana, nascosta da un muro di cemento e indifferenza.
In Italia l’antropologia del carcere di fatto non esiste. Per trovare esempi significativi bisogna andare indietro nel tempo, al lavoro di Cesare Lombroso, medico, antropologo, criminologo e giurista di fine Ottocento. A lui si deve la nascita dell’antropologia criminale. Le sue opere si basano sul concetto del criminale per nascita e la sua tesi è che l’origine del comportamento criminale sia insita nelle caratteristiche anatomiche di una persona fisicamente differente dall’uomo normale in quanto dotata di anomalie e atavismi, che ne determinano il comportamento. Sebbene questa teoria sia oggi destituita di ogni fondamento, a Lombroso viene comunque riconosciuto il merito di aver dato avvio agli studi criminologici moderni.
La cecità dell’antropologia risulta ancor più incomprensibile se si considerano le dimensioni della comunità carceraria: agli inizi degli anni ‘90 in Italia contava circa 27 mila persone, diventate 54 mila nel 2001 e oggi salite a oltre 68 mila, con un trend in continuo aumento. Gli istituti di pena sono 206 sul territorio nazionale, disseminati in tutte le regioni. Il carcere, dunque, è sotto gli occhi di tutti eppure l’antropologia finora non ha voluto vedere.
A onor del vero, questo disinteresse non caratterizza solo gli studiosi italiani, bensì è diffuso anche in Europa e in America. Lo dice bene Loïc Wacquant nel suo contributo dal titolo eloquente “La curiosa eclissi dell’etnografia della prigione nell’era dell’incarcerazione di massa” (2002): «Dal 1990 la California si è lanciata a capofitto nella più drammatica espansione carceraria ricordata nella storia». Eppure, in questo contesto, «mentre gli studiosi si sono concentrati su studi di forme nuove di controllo sociale decentralizzato nelle scuole, negli uffici pubblici di assistenza e negli ospedali, hanno eliminato le prigioni dai loro radar». Anche in questo caso il mancato interesse non trova giustificazione nei numeri, dal momento che la popolazione detenuta americana è passata bruscamente dalle 380 mila persone del 1975 al milione nel 1990. Un’espansione che non ha precedenti storici «non solo per la sua grandezza e velocità ma anche perché è accaduta in un periodo in cui i livelli di crimine sono rimasti essenzialmente immutati», precisa Wacquant.
Tuttavia, questo boom detentivo non caratterizzò solo i penitenziari statunitensi: le statistiche riferiscono che la popolazione detenuta di Francia è raddoppiata tra il 1975 e il 1995 e quella dei maggiori stati europei e sudamericani è cresciuta enormemente nelle due decadi passate. Come spiega Lorna Rhodes (2001), «l’espansione del sistema penitenziario è iniziata nei primi anni ‘80, con il più alto tasso di incarcerazione nel mondo».
Viene dunque spontaneo chiedersi le ragioni di questa “eclissi”. Rhodes segnala tra le possibili cause - almeno parzialmente - le difficoltà burocratiche: vincoli, cavilli e difficoltà nel reperimento di informazioni di prima mano costringono infatti a cercare altre fonti, come report giornalistici e altri studi, denunce dei militanti, racconti dei detenuti, produzione accademica e materiali legali e storici. Facendo riferimento al proprio ambito di lavoro (quello statunitense), la studiosa commenta: «L’etnografia della prigione negli Usa non è solo in via d’estinzione, ma è già una specie estinta. Con le scienze sociali che hanno abbandonato la scena, si è costretti a usare scritti di giornalisti e detenuti per conoscere la vita quotidiana nelle celle americane». Questo avviene perché le prigioni sono diventate organizzazioni opache non facili da penetrare, che pongono ostacoli e impediscono in larga misura un’etnografia “tradizionale”, rendendo difficile una vera osservazione partecipante.
Ma sarebbe riduttivo considerare questo come il solo e principale motivo: se così fosse non si spiegherebbe in che modo autori come Fleisher (1989) o Wilson (2004) abbiano potuto condurre le ricerche che sono alla base dei propri lavori. Ci deve essere qualcosa di più. Ecco, dunque, che un ulteriore problema può essere rintracciato, secondo Rhodes, nel disinteresse accademico e nella mancanza di fondi stanziati dalle agenzie governative e dalle fondazioni. «Se un giornalista come Daniel Bergner può stare dieci mesi nella più infame prigione dell’Angola e l’autore freelance Ted Conover è entrato a Sin Sin per un anno come guardia, cosa impedisce a un sociologo o a un antropologo dal fare qualcosa di simile?» si chiede la studiosa. «La risposta è che il Comitato accademico lo proibirebbe. L’oggetto della ricerca gode di uno status inferiore, perché prevede il contatto con una popolazione stigmatizzata».
Non è stato sempre così. Fino agli anni settanta gli Stati Uniti erano leader mondiali nella ricerca sul carcere, solo in parte sfidati dalla Scandinavia, grazie soprattutto alla loro ricca tradizione di scritti dal carcere a opera di detenuti tra cui Claude Brown, Malcolm X, Piri Thomas, Eldridge Cleaver e Angela Davis, che hanno sensibilizzato l’opinione pubblica narrando esperienze personali di detenzione. È inoltre nei penitenziari di Illinois, New Jersey e California che scienziati sociali americani hanno condotto una serie di studi sul campo, diventati il pilastro della moderna sociologia delle istituzioni carcerarie. Come riferisce Wacquant (2002), «questi studiosi erano mossi dal credo scientifico in un miglioramento razionale del controllo sociale e dalle sfide, sorte dai movimenti sociali degli anni sessanta, di stabilire forme di autorità». Nascono così opere come “The prison community” di Donald Clemmer (1940), cui si deve il concetto di “prisonizzazione”, e il lavoro di Erwing Goffman (1961), con le nozioni di “istituzione totale” e “sotto-vita dei detenuti”.
Eppure, tutto questo fermento non era destinato a durare e nell’arco di pochi anni la spinta si è esaurita. Come sottolinea ancora Wacquant, «con l’abbandono della filosofia della riabilitazione e il giro di vite della criminalizzazione della povertà come espressione di una politica sociale mirata al contenimento delle classi inferiori e a stigmatizzare i gruppi etnici, le porte dei penitenziari sono state gradualmente chiuse ai ricercatori e sono state imposte severe restrizioni sulla diffusione degli scritti dei detenuti». Una significativa eccezione è il lavoro di Fleisher (1989) che ha sfruttato il supporto del Bureau of Prison per diventare agente di guardia a Lompoc, penitenziario della California. Il frutto della sua ricerca, durata un anno, è contenuto in “Warehouse violence”, un racconto realistico che si sofferma sull’analisi della specificità del campo di lavoro e approfondisce diversi temi: dal rapporto tra i detenuti alla violenza, dal sesso alla disciplina. L’autore mette in evidenza che le prigioni, come altre comunità umane, sono posti “socialmente complessi” e lamenta la tendenza degli studiosi - i pochi - che si approcciano a questa realtà di focalizzarsi solo su determinati e specifici aspetti del problema, come il sovraffollamento, le gang ecc. Inoltre, critica il mancato ingresso di questi studiosi nei luoghi che intendono studiare, conducendo l’analisi esclusivamente attraverso questionari e interviste brevi formali.
Meno grigia ma pur sempre difficile è la situazione al di qua dell’oceano, dove si contano solo alcuni sporadici ma significativi contributi. Ne dà conto ancora una volta Wacquant, riferendo dell’attività recente di ricercatori inglesi e francesi che hanno investigato l’ambiente carcerario, scandagliando le relazioni sociali ordinarie e culturali che si costruiscono oltre il muro di cinta. Ad esempio, Rostaing (1997), in una ricerca svolta in tre penitenziari femminili francesi, ha mappato la attività di routine e la produzione delle identità dentro e fuori dal carcere. Le Caisne (2000) ha invece esplorato la graduale costruzione del sé durante la detenzione con un lavoro sul campo di due anni nella prigione di Poissy, a nordovest di Parigi. Si tratta pur sempre di eccezioni, al contrario di quanto avviene in altre discipline che si sono interessate al tema in modo più organico e convinto: la psichiatria e la psicologia, la sociologia, la criminologia e in qualche modo anche la moderna filosofia. Anche questi approcci però non sono esenti da problemi e critiche, poiché il loro ingaggio con la prigione, come sostiene Rhodes (2001), «non è altro che ripetitivo, un punto che mette in difficoltà ogni tentativo di criticare o contribuire a tali discorsi. Una minima letteratura cerca un approccio più riflessivo e problematizzante».
Ci sono anche esempi di osservazione partecipante da altri paesi, come lo studio antropologico sulla diffusione della tradizione aborigena spirituale nelle prigioni canadesi da parte di James Waldram (1997) e il ritratto del tempo, del sesso e della morte nelle celle di Sao Paolo a cura di Kiko Golfman (1998). Tuttavia queste monografie rimangono disperse e, con poche eccezioni, disconnesse dal dibattito centrale della sociologia e dell’antropologia, così come appaiono lontane dalla tradizionale ricerca etnografica.
Tuttavia, il mondo della prigione può e deve essere investigato. «I ricercatori sul campo devono preoccuparsi meno di sfidare i termini di un discorso che supporta le prigioni e più di entrare in carcere per avviare un’osservazione intensiva. Il legame della prigione con la storia intellettuale dell’Occidente richiede anche un’esplorazione, attraverso approcci etnografici e di storia orale, verso chi è coinvolto come prigioniero, familiari, educatori, amministratori architetti» (Rhodes L., 2001).
Il carcere “istituzione totale”: Goffman e Foucault
È ormai nota la definizione del carcere come “istituzione totale”, termine che si diffonderà nel corso degli anni sessanta prima nel mondo anglosassone e poi in Italia, dove divenne di dominio comune grazie al lavoro di Franco Basaglia. L’espressione compare per la prima volta nel 1961 in “Asylum” di Goffman: «Un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che - tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo - si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato». Secondo Goffman, l’ingresso in un’istituzione totale comporta una serie progressiva di degradazioni e mortificazioni del sé. In particolare, a causa della barriera che separa la prigione dal resto del mondo, il detenuto finisce con il perdere lo schema del susseguirsi dei ruoli che ricopriva nella vita precedente alla detenzione. Avviene così quella che Correra e Martucci (2006) definiscono «spoliazione dei ruoli».
L’istituzione totale, intesa come complesso unitario e durevole di norme, è considerata da Goffman come un insieme di persone che perseguono determinati fini con mezzi appositi, rapportandosi gli uni agli altri secondo schemi prestabiliti. Suoi elementi costitutivi sono: la struttura del carcere, le persone che vi lavorano o che vi sono recluse, le metodologie, le tecniche e le attrezzature impiegate da esse. Aspetti caratterizzanti, invece, sono lo svolgimento della vita nello stesso luogo, sotto la stessa autorità e a stretto contatto con un ampio gruppo di persone. «A ciò si aggiunge una totale uniformazione dei detenuti e delle loro attività, ma anche dei tempi e dunque delle diverse fasi di vita giornaliere, rigorosamente schedate secondo ritmi prestabiliti, imposti dall’alto da un sistema di regole formali esplicite e da un corpo di addetti alla loro esecuzione» (Aa.Vv., 2010).
Uno degli aspetti sociali fondamentali nella società moderna è che l’uomo tende a dormire, a divertirsi e a lavorare in luoghi diversi, con compagni diversi, sotto diverse autorità. Tutto questo non avviene all’interno di un’istituzione totale, che ha come caratteristica principale, appunto, la rottura delle barriere che abitualmente separano queste sfere di vita. Nelle istituzioni totali, per prima cosa, tutti gli aspetti della quotidianità si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa, unica autorità. Secondo: ogni fase delle attività giornaliere avviene a stretto contatto con un enorme gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose. Terzo: le diverse fasi delle attività sono rigorosamente schedate e le attività sono organizzate secondo un unico piano razionale. Per opporsi a tutte queste imposizioni il carcerato non può creare - come farebbe chiunque in condizioni di normalità - una barriera tra sé e la realtà mortificante. È perciò costretto a cercare modalità diverse di resistenza, rifugiandosi in quella che Goffman definisce «influenza riorganizzativa», un processo di fraternizzazione tra gli internati.
Dove lascia Goffman, una decina d’anni dopo riprende Foucault, con il suo celebre “Sorvegliare e punire” (1975): un’analisi a metà tra sociologia e storia che ripercorre le tappe principali della nascita e dello sviluppo del sistema carcerario, che viene sottoposto a una dura critica. In una delle sue ultime interviste Foucault riferisce che «l’obiettivo del carcere-correzione, il carcere come strumento di riparazione all’errore commesso dall’individuo, non è stato raggiunto. L’effetto è stato invece contrario e la prigione ha piuttosto rinnovato i comportamenti di delinquenza» (Ringelheim F., 1990). E aggiunge: «La prigione che non ha avuto effetti correttivi, è invece servita come meccanismo di eliminazione». Nell’analisi di Foucault la prigione è una forma usata dalle “discipline”, un nuovo potere tecnologico che può ritrovarsi anche nelle scuole, negli ospedali, nelle caserme e che materializza una “società pan-ottica” per i propri membri. Il riferimento è al Panopticon (“che fa vedere tutto”), il carcere ideale progettato nel 1791 dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham considerato da Foucault come modello e figura del potere nella società contemporanea.
L’idea di fondo di Bentham era che, grazie alla forma radiocentrica dell’edificio e a opportuni accorgimenti architettonici e tecnologici, un unico guardiano potesse osservare tutti i prigionieri in ogni momento. Dal canto loro, i prigionieri non dovevano essere in grado di stabilire se fossero osservati o meno. «Ciascuno, al suo posto, rinchiuso in una cella, è visto di faccia dal sorvegliante; ma i muri laterali gli impediscono di entrare in contatto con i compagni. È visto, ma non vede; oggetto di una informazione, mai soggetto di una comunicazione. La disposizione della sua cella, di fronte alla torre centrale, gli impone una visibilità assiale, ma le divisioni dell’anello, quelle celle ben separate, implicano una invisibili...
Indice dei contenuti
- Cover
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Prefazione
- Introduzione
- Brevi cenni teorici
- È tutta una questione di spazio…
- La sottile arte del fai-da-te in cella
- Il corpo, unico vero spazio personale
- Aria, scopino, cicala… il gergo dei detenuti
- Valori, relazioni e affettività in carcere
- Conclusioni
- Riferimenti bibliografici
- Ringraziamenti
- L’autrice
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a E per casa una cella di Giorgia Gay in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Storia e teoria della psicologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.