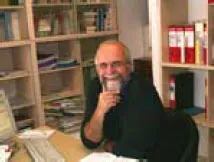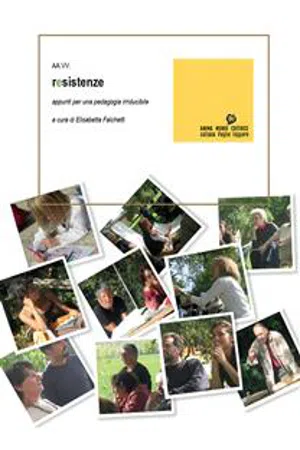![]()
UNA NOTTE, PER LE STRADE DI GENOVA…
Giorgio Matricardi
Mirko (è un nome di fantasia, ma rappresenta un alunno di una scuola primaria genovese in carne ed ossa) mi guarda con un’espressione mista tra l’astuzia e la presa in giro sorridente: la testa un po’ piegata di lato, l’aria di chi la sa lunga. Io tengo in mano un branzino acquistato questa mattina al supermercato; lui è circondato dai compagni di classe, dalle due maestre e da una mamma che riprende tutto con una telecamera. Siamo sul terrazzo della scuola, assieme all'intera classe II e stiamo cercando assieme di scoprire la biologia di questo pesce osservandolo direttamente. Si è però presentato un problema: il branzino ha le narici. E a cosa servono le narici a un pesce? Qualcuno ha già avanzato ipotesi: “… a respirare…?” (risposta corale “Ma ci sono già le branchie!), “… a sentire gli odori…?” (dubbio corale “Ma come fa? Annusa in acqua?”). Lui, Mirko, più che un'ipotesi titubante ha una sua risposta: “Il naso al pesce serve per scaccolarsi!”.
Inizia in questo momento la rappresentazione di un dramma: la mamma spegne immediatamente la telecamera, l’allontana quasi da sé con un gesto che esprime tutto il suo silenzioso dissenso morale; le maestre arrossiscono: leggo nel loro imbarazzo il classico “Ma che dice? Ma c’è il professore…”. I compagni sghignazzano più o meno apertamente. La sfida è lanciata e la trovo veramente interessante; un bivio si apre davanti a me: da una parte - chissà perché mi immagino che questa strada pieghi verso destra… - la via più comoda, ma anche un po’ frustrante (sia per Mirko che per me e per tutti gli altri presenti), che inizia con il classico “Dài su, non scherziamo troppo… Allora, il naso al pesce serve...” e prosegue, larga e facile, delimitata dagli alti e solidi muretti in cemento dell'insegnamento tradizionale e disciplinare. Prendo a sinistra - chissà perché identifico la mia decisione con questa direzione... vedo quasi il cartello che indica “per di qua” - con una domanda che coglie un po’ tutti di sorpresa: “Ma come fa un branzino a scaccolarsi il naso?”. Adesso è Mirko che deve scegliere la sua strada; nel silenzio che si è fatto generale nessuno gli suggerisce qualche cosa. Anche per lui, però, la sfida si è fatta interessante: lo vedo dalla luce che improvvisamente si è accesa nei suoi occhi. Anche negli occhi dei compagni si è accesa la stessa luce: tutti sentiamo di essere entrati in un territorio di quelli che ti prendono e ti costringono a guardarti intorno con attenzione, ad annusare l’aria, a toccare tutto quello che puoi, ad assaggiarne i sapori appena ti è possibile e ad ascoltarne i suoni ed i rumori. È un territorio che ti stimola, che ti fa strizzare un po’ gli occhi per capirci meglio e che non ti lascia più tornare indietro finché non l’hai esplorato per bene: qui è la volta che si scopre davvero qualche cosa di nuovo…
Queste immagini scorrono nella mia memoria mentre, alle due di notte, sono in macchina e guido per le strade deserte di Genova; in questa città non c’è mai nessuno in giro, appena passata l’ora di cena… È una sera molto simile a quella in cui, stanco e amareggiato, tornavo a casa dopo aver partecipato ad un'assemblea in una scuola primaria in cui si era discusso della situazione dell’insegnamento con l’entrata in vigore della cosiddetta “riforma Gelmini” e si era decisa la prima occupazione di un istituto scolastico genovese da parte di genitori e insegnanti. Avevo partecipato, o meglio avevo condiviso lo scoramento dell’intero gruppo delle maestre, consapevoli che, “per legge”, non ci sarebbe più stata quella scuola che loro stesse avevano pensato e costruito in anni di lavoro faticoso e appassionante e si chiedevano come, di fronte ai loro alunni, loro stesse avrebbero potuto essere coerenti con tutto quello che era stato maturato negli anni di lavoro tra quelle mura, avendo sempre proposto ai bambini la stessa coerenza con le proprie idee e conoscenze. Avevo condiviso anche l’incertezza dei genitori, che quel modo di fare scuola avevano capito e sostenuto e ora vedevano tutto sfumare in un grigiore intangibile. Avevo anche assistito alla dimostrazione di quanto gli amministratori locali interessati a questi problemi fossero incapaci di dare una risposta alle istanze dei loro cittadini: all’assemblea, praticamente un collettivo allargato dal momento che tra quelle mura le maestre non avevano perso la sana abitudine di ritrovarsi a scuola per discutere e risolvere i problemi assieme, erano presenti anche l’assessore comunale alla cultura e il presidente della “Fondazione per la Cultura” di Genova e dalla loro bocca, oltre alle rituali e generiche dichiarazioni di comprensione e di vicinanza, era uscita soltanto la preghiera di non cancellare l'iscrizione dell’intera scuola ad una manifestazione di divulgazione scientifica a livello nazionale che in quel periodo si teneva a Genova. Non sono proprio riuscito a tacere a quel punto: non mi capacitavo come chi rappresentava le Istituzioni non fosse capace di vedere e capire che quelle maestre e quei genitori stavano proprio chiedendo un aiuto per a poter partecipare, negli anni successivi, alle varie occasioni significative per i bambini e per la costruzione dei loro saperi che il territorio avrebbe proposto. Chiedevano un aiuto concreto, un impegno formale al loro fianco per non essere forzate ad una scuola chiusa tra le sue stesse mura e stavano raccontando quanto fosse sofferta la loro scelta, dal momento che erano ben consapevoli di cancellare, per i bambini, un’occasione preziosa per conoscere la realtà: sapevano di prendere una decisione che avrebbe spento negli occhi degli alunni proprio quella luce che, in tempi e luoghi diversi, si era accesa attorno al naso del branzino da scaccolare…
Mentre guido nelle strade poco illuminate della mia città penso che la luce negli occhi degli alunni è una sensazione che ha accompagnato passo a passo la mia storia di ricercatore “che gioca con i bambini”: è proprio questa la definizione che davano di me alcuni colleghi biologi che non riuscivano a capire come si potesse buttare al vento una carriera di ecologo per dedicarsi a esplorare i modi di insegnare scienze a bambini e adulti. Ho incontrato per la prima volta quella certa luce dello sguardo, che rende gli occhi vivi, penetranti, attenti e forse anche un po’ maliziosi, quando, più di vent'anni fa, sulla spiaggia e con addosso ancora la muta subacquea, mostravo agli alunni di scuole primarie e dell'infanzia ciò che avevo appena raccolto dal fondale; assieme, con attenzione e rispetto, toccavamo animali e vegetali ed esploravamo le loro caratteristiche per capirne i modi di vita e il ruolo che svolgevano nel sistema mare, per poi liberarli di nuovo nel loro ambiente. Più o meno allora mi è stata proposta la definizione di “costruttivista”: mi ero appena affacciato nel mondo sterminato dell’educazione e la mia formazione di biologo ed ecologo non mi permetteva di capire se mi era stato rivolto un complimento o un insulto. Non che una prima e goffa consultazione di siti internet mi abbia aiutato molto: il costruttivismo mi risultava essere un movimento artistico compreso nell’astrattismo e fondato in Russia attorno al 1913 e io non ritenevo di avere nulla a che spartire con pittori russi… Poi ho scoperto che si trattava del mio modo di fare con i bambini; dalle pagine dei suoi libri Jerome Bruner2 mi ha indicato quanto fosse significativo accompagnarli a esplorare la realtà per costruire in prima persona nuove rappresentazioni e nuovi significati del mondo che li circonda e agganciare tutto questo alle conoscenze che già avevano e che potevano essere accreditate dalla scienza o da fonti autorevoli come libri, enciclopedie, siti internet ecc. Ho riconosciuto in questo modo di intendere l’educazione scolastica ciò che ha da sempre motivato il mio personale percorso di conoscenza: essere in prima persona coinvolto nell’esplorazione della realtà e nella costruzione di un nuovo sapere è stata anche per me la chiave per la comprensione, per raggiungere cioè, con il suggerimento di Howard Gardner3, quella capacità di mettere in gioco quanto avevo capito quando mi si presentava un problema nuovo e mai affrontato.
In fin dei conti, essere “quello che gioca con i bambini” è una definizione che non mi sta poi tanto male: giocare, divertirsi, appassionarsi sono caratteristiche che non riesco a separare dai concetti di apprendimento, di insegnamento e di educazione per qualsiasi grado scolastico, ed è per questo che, quella sera di qualche anno fa, ero così amareggiato dall’aver assistito alla penosa risposta istituzionale alle preoccupazioni di maestre che chiedevano aiuto perché la scuola appassionante che avevano saputo costruire in tanti anni di impegno e fatica non fosse buttata via in un attimo. Certo il mio parlare di divertimento tra i banchi di scuola o dell’università ha spesso incontrato l'incredulità degli alunni e una disincantata reazione di compassione mista ad un sorriso un po' imbarazzato in quello stesso gruppo di colleghi biologi che sempre più erano convinti della mia perdizione. La loro espressione mi ricorda quella delle due maestre che guardano Mirko mentre propone che il naso al pesce serve per potersi scaccolare... Però i ragazzi, una volta superata la difficoltà di uscire dalla normalità dello schema “maestro che sa” contrapposto ad “alunni che non sanno” (uno schema assolutamente tradizionale e immutabile nella loro storia scolastica), si sono sempre lasciati accompagnare nell’esplorazione di quel territorio che sta oltre ciò che ci appare come normale e consolidato e che Silvio Funtovicz e Jerry Ravez4, parlando di scienza, hanno definito territorio del post-normale; assieme, ogni volta abbiamo costruito significati nuovi e autentici da attribuire alla realtà che incontravamo nella vita di tutti i giorni5. Al contrario, chi era totalmente intrappolato nello schema normale, ci guardava con occhi privi di luce, disinteressati, spenti, lontani.
Percorrere di notte le strade di Genova mi aiuta a riflettere sul concetto di lontananza e su come esso possa cambiare aspetto a seconda della situazione in cui ci si trova; è un concetto che ha a che fare con il tempo e lo spazio: in questa città notturna, deserta, priva di traffico, il tempo per spostarsi da un luogo all'altro si accorcia, la strada scorre senza intoppi e la testa può permettersi qualche associazione di più. Tutto succede forse perché noi che abitiamo in Genova ed abbiamo qualche stagione sulle spalle, una volta chiusa la parte di giornata occupata dai nostri impegni professionali, non abbiamo l'abitudine a mettere in comune con altri le nostre emozioni e le nostre esperienze, ci chiudiamo in casa appena fa buio oppure, più raramente, ci incontriamo per pochi minuti con qualche amico di sempre. Quindi quando siamo soli, magari in macchina, come ora accade a me, abbiamo improvvisamente a disposizione uno spazio mentale che non è affollato da altre persone o da altre impellenze e i pensieri possono occuparlo senza problemi. Mi ritrovo a pensare che i due personaggi istituzionali che partecipavano all'assemblea in scuola non facevano parte della mia cerchia di amici: avevo conosciuto l’assessore solo in televisione, mentre invece con il presidente della Fondazione ci eravamo incontrati più volte; questi incontri avvenivano, tra il 1999 e il 2004, di nuovo di sera e fino a ora tarda nelle stanze dell’Assessorato ai servizi alla persona del Comune di Genova (lui era, allora, l’assessore).
Attorno ad un grande tavolo stavamo in compagnia di due membri della Giunta Comunale, di alcuni funzionari e di poco più che una decina di cittadini, nominati da una assemblea pubblica tra tutti coloro che in città si occupavano per un verso o per l’altro di educazione, e si cercava assieme di declinare il concetto di “città educativa”6. Erano gli anni del passaggio di millennio e mi ero fatto coinvolgere in questa “partita” - termine calcistico o manageriale molto in voga, purtroppo, negli uffici comunali - decidendo che, per una volta, sarei andato dietro alla regola del “doverci essere” e del “non si sa mai cosa ne possa venire fuori” così comune tra le mura di un ateneo. Il presenzialismo è un tipico modo di pensare da docente universitario che ritiene fondamentale l’essere sempre presente in tutto ciò che, in un modo o nell’altro, abbia a che fare con la disciplina che insegna, in modo da non “perdere occasioni”; è sempre stato un atteggiamento che mi provoca l’orticaria, ma quella volta c’ero cascato e mi ero presentato all’assemblea che mi aveva spedito a quel “tavolo di coordinamento”. Per due o tre anni ci si è visti nelle stanze dell'Assessorato, a fare ipotesi e ragionamenti su come una città potesse divenire un soggetto educante sia per i suoi cittadini (si discuteva di come garantire la loro partecipazione diretta alle decisioni su argomenti che li riguardavano in prima persona) sia per gli amministratori ed i tecnici (si studiava come accompagnarli di nuovo al ruolo di soggetti chiamati a rendere effettive le istanze e le scelte dei cittadini). Nel frattempo, si raccoglievano informazioni su un numero sempre più elevato di straordinari percorsi di partecipazione e di cittadinanza attiva e consapevole di cui la nostra città è ricca ma anche molto gelosa, tanto da tenerli ben nascosti. Pian piano mi ero reso conto che il percorso era lontano dall’essere un esercizio di presenzialismo; se mai, era davvero un’occasione da non perdere per la sua ricchezza educativa e mi si era accesa negli occhi, una volta di più, quella certa luce… Poi, all’avvicinarsi di una consultazione elettorale locale, quel gruppo ormai affiatato ha dovuto sperimentare in prima persona proprio il concretizzarsi di quel concetto di lontananza a cui sto pensando mentre guido, ma in un modo molto diverso e più doloroso, almeno per me: le date di apertura dei seggi si facevano vicine, e così l’assessore ha chiuso ogni spazio di pensiero per chiedere azioni concrete e spendibili in campagna elettorale. L’Istituzione si è di nuovo allontanata irrimediabilmente dai cittadini e tutto quel bellissimo processo di cittadinanza attiva è scappato di mano a chi lo voleva “presidiare” (termine che si adatta meglio a fortezze da difendere, a pattugliamenti militari o magari alla difesa della porta dai goal della squadra avversaria, piuttosto che alla tutela di diritti) anziché promuoverlo e accompagnarlo, ed è tornato a nascondersi nella città.
Accompagnare con la luce negli occhi… Mi scopro a pensare che anche la mia auto, in fondo, mi sta accompagnando a casa alla luce dei fari... Ecco una buona metafora del mio modo di intendere l’educazione. Accompagnare vuol dire fare un pezzo di strada assieme, camminando uno a fianco all’altro: ci si accompagna per tenersi compagnia, una chitarra accompagna un oratore per sottolineare il significato delle sue parole, si accompagna anche per introdurre e poi seguire qualcuno (dei giovani, dei coetanei, degli anziani...) in qualche occasione che si ritiene importante: per me l'occasione è il sapere scientifico. E’ un gesto che ha in sé il concetto di partecipazione e mi fa venire in mente il modo in cui Jerome Bruner7 descrive la scuola: “Un luogo in cui, fra l’altro, le allieve e gli allievi si aiutano a vicenda nell’apprendimento, ciascuno secondo le proprie capacità. È evidente che questo non esclude la presenza di qualcuno che svolge il ruolo di insegnante. Significa semplicemente che l’insegnante non ha il monopolio di questo ruolo, perché anche gli allievi contribuiscono a creare le «impalcature» che servono di supporto agli altri”. E così la classe diviene “Una sottocomunità di persone che apprendono le une dalle altre, dove il docente ha un compito di orchestrazione”. Mi sono venuto a trovare, per scelta oltre che per i casi della vita, nella figura del docente, dell'orchestratore: colui che ha il compito di aiutare i suoi orchestrali a mettere assieme le proprie capacità per costruire la sinfonia, ma lo deve fare mettendoci del suo, partecipando al lavoro col suo carattere e con il suo sapere in modo che ne esca una interpretazione dello spartito ricca e capace di comunicare al pubblico emozioni e suggestioni.
Quando ci si accompagna con qualcuno per strada è inevitabile che si facciano nuove conoscenze; è così che nel mio camminare per la via dell’educazione scientifica mi sono trovato assieme a tanti altri. All’inizio, a chiedermi di fare i primi passi assieme è stata Rita, la responsabile di un laboratorio comunale al servizio delle scuole, che un giorno, assieme ad una collega, si è presentata nel mio studio di ecologo e mi ha proposto di “costruire dei percorsi sul mare, per le scuole”: Rita è una persona per me speciale, che ha saputo reggere alla imbarazzante perplessità di un biologo così impreparato nel campo della didattica da andarsi a lambiccare sulla costruzione di sentieri lungo la costa, chiedendosi cosa c’entrasse la biologia con tutto ciò. Qualcuno si deve essere accorto, allora, che si stava costruendo qualche cosa di speciale tra me e lei, tanto che in un computer del suo laboratorio era rimasta una fiaba della principessa “Rita” e del principe “Giorgio”... e Rita ora è mia moglie. Dalla pazienza di Rita, dalla sua passione e dalla sua genialità è venuto fuori il primo progetto di educazione scientifica a cui io abbia partecipato: il titolo era “Bordesando bordesando” che, in genovese, significa “navigando lungo la costa” ma per noi due si traduce in tre anni di lavoro appassionante, divertente, ricco e pieno di stupore e in centinaia di occhi di bambini e adulti pieni di luce8. Da quel momento, sulla strada che quasi inconsapevolmente avevo imboccato, hanno cominciato a comparire intere classi di bambini di scuole dell’infanzia e primaria che, assieme a Giorgio “il biologo” desideravano capire, sempre con quella certa luce negli occhi, qualche cosa di più dell’ambiente marino. Naturalmente, come succede ad ogni professore dell’università, attorno a me c’erano anche studenti che chiedevano la tesi, e qualcuno di loro si è unito per un po’ alla compagnia, costringendomi, al momento di presentarsi di fronte alla commissione di laurea, a far fare con me qualche passo svogliato e brontolante anche a quei colleghi per i quali ero comunque “quello che gioca con i bambini”... C’erano poi le maestre delle classi, con i loro problemi di approfondire una cultura scientifica quasi sempre del tutto autodidatta, ma che spesso si portavano dietro capacità didattiche eccezionali; non ho mai rinunciato ad ammettere che proprio da loro ho imparato a riconoscere e seguire il miglior percorso lungo la via che avevo imboccato. C’erano poi i funzionari comunali che tenevano in piedi il progetto e che mi presentavano un complesso apparato di saperi pedagogici e di pratiche didattiche.
Hanno cominciato a comparire anche i nomi degli autori di riferimento per quel mondo: Jerome Bruner, Howard Gardner, Jean Piaget, Lev Semënovič Vygotskij, Mar...