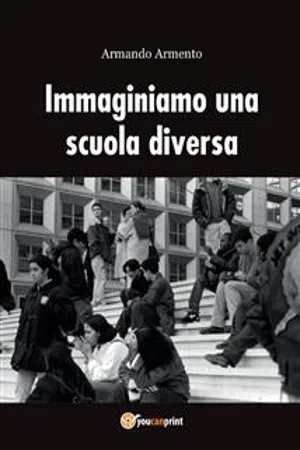![]()
Appendice
Nella prima parte sono state esposte osservazioni, proposte e problematiche in maniera alquanto discorsiva e non si è data evidenza di molte affermazioni. Questa scelta è stata fatta per arrivare in modo più sintetico possibile ad esprimere una visione complessiva del problema scuola. Sembra ora interessante esplicitare più dettagliatamente molti aspetti specifici. Non sarà possibile trattarli tutti per la loro complessità e perché molti di essi devono essere oggetto di dibattito allargato. In questa appendice, senza un ordine specifico ed in forma monografica vengono discussi vari argomenti.
![]()
Analisi del testo
Salvatore Quasimodo – Alle fronde dei salici
E come potevamo noi cantare
Con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.
Cantare - metafora
Piede straniero , sopra il cuore - metonimie
Dura di ghiaccio - metafora
Al lamento d’agnello – analogia + enjambement
All’urlo nero della madre – sinestesia + enjambement
Al triste vento – metafora
Sono sottolineate le allitterazioni della r e della l
Nella pagina precedente è stata riportata una analisi del testo alla ricerca delle figure retoriche presenti in una bella poesia di Quasimodo. Si possono fare alcune domande:
- Quanto aiuta questa analisi a migliorare la godibilità del testo?
- L’Autore le ha scelte razionalmente o fanno parte di una musicalità espressiva a lui naturale?
- Dopo questa “etichettatura” non abbiamo frantumato (oddio, quale figura retorica ho impiegato?) la poesia?
- La capacità di individuarle in una poesia può essere utile ad una migliore comprensione del testo?
- Leggere “l’urlo nero” e percepirne la suggestione è aiutato dal sapere che si tratta di una Sinestesia? O capisco che è una Sinestesia proprio perché ne ho percepito il significato?
Oggi gran parte dell’impegno richiesto allo studente è dovuto alla memorizzazione di dati e informazioni che, tra l’altro, lo distraggono dal vero cuore del problema e da quella affascinante attività che è il capire. Dobbiamo scegliere se vogliamo acquisire capacità di individuare tutte le figure retoriche con i loro strambi nomi nell’Orlando Furioso, oppure ci vogliamo far conquistare dalla sua freschezza, da quell’onda gradevole del racconto, dalle immagini evocate, dal loro significato collocato in un’epoca storica e culturale ben precisa. Si può essere certi che, in questo secondo caso, l’Orlando Furioso sarebbe ancora in grado di affascinare i giovani.
![]()
Latino si / Latino no
Il latino è bellissimo! Salviamo il latino, togliamolo dai licei!
Dopo aver lanciato la bomba, cerchiamo di capirci. La lettura dei classici latini e anche dei classici greci, è una esperienza unica. Poter leggere in lingua originale i grandi autori latini significa arrivare al cuore della cultura sulla quale si fonda l’Europa. Solo leggendo in latino si può apprezzare la prosa concisa del De bello gallico di Cesare e l’armonia grandiosa ed elegante delle orazioni di Cicerone o lo stile caustico delle Satire di Orazio o cogliere il dolce fluire delle bucoliche di Virgilio. Ma, svegliandosi da questa atmosfera magica, ci si può domandare: per godere di tutto questo, quanta fatica devo affrontare?. Sto inseguendo il piacere o mi sto attrezzando per la vita che mi aspetta? E qui si apre la discussione.
Ai miei tempi il latino si studiava per otto anni. All’ultimo anno proprio in pochi riuscivano a tradurre con basso uso del vocabolario ed in modo tale che la ricchezza del testo riuscisse a superare le difficoltà dell’interpretazione. Occorre dedurre che lo studio del latino a scuola non consentirà mai una conoscenza tale da leggere un testo nella lingua originale e tutto questo, come si diceva prima, pur limitandosi alla letteratura dell’età di Cesare.
Si dice che il latino è formativo, aiuta a ragionare. Certamente una lingua ricca e complessa come il latino consente al pensiero di formarsi e snodarsi in maniera completa e quindi di cogliere tutte le sfumature del discorso. Questo è tuttavia più evidente quando ci si muove nel campo delle opere letterarie, giuridiche e storiche con l’impiego di retorica, dialettica, oratoria. Ma il latino non è l’unica palestra per sviluppare la capacità di ragionamento. Forse è più opportuno allenarsi con qualcosa che alla fine è più legato all’attualità delle esperienze.
Si dice che il latino serve ad imparare l’italiano. Certo, il latino è la madre dell’italiano ma la nostra lingua ha la sua grammatica, la sua sintassi che, in aggiunta, si sono sviluppate anche tenendo conto dei cambiamenti culturali che sono intervenuti nel tempo. Non si vede come un corretto studio dell’italiano debba essere dipendente dal latino. Oggi si usano molti modi di dire in lingua latina, tipo “o tempora o mores” oppure “tu quoque Brute, fili mi” e così via, ma questo non c’entra con il nostro discorso.
Si dice che il latino rappresenta i valori fondamentali dell’umanità. Benissimo, ma questo non ha a che vedere con lo studio della lingua latina così come è possibile farla in un liceo.
Vediamo invece il problema da un altro punto di vista.
L’abolizione del latino nei licei riduce in modo sensibile lo stress esercitato sugli studenti che non sono obbiettivamente in grado di apprezzarne le bellezza. Si rende così libera una grande quantità di tempo che darebbe la possibilità alla scuola italiana di superare parte del gap con le altre scuole europee in campo scientifico e di trovare pure il tempo per attività sportive, relazionali, culturali.
La resistenza ad abbandonare il latino ha le sue radici nell’uso che se ne è fatto fin nei tempi recenti. Fino al 1600 il latino ha svolto la funzione che oggi svolge l’inglese. Era la lingua dell’impero romano ma anche dopo la caduta di questo è stata la lingua con la quale gli uomini di cultura europei comunicavano tra loro. Il potere temporale e spirituale della Chiesa ha mantenuto l’uso del latino fino ai giorni nostri proprio in virtù della sua visione globale.
Con la rivoluzione industriale, con lo sviluppo scientifico, la lingua latina non ha più avuto la capacità di rappresentare una realtà del tutto mutata. Non era attrezzata per rappresentazioni di tipo quantitativo o numerico. Non possedeva nel suo vocabolario termini capaci di accogliere gli elementi che caratterizzavano la nuova rivoluzione. Con il tempo la lingua per la comunicazione globale è diventato l’inglese, più pratico nella sua semplicità sintattica, più diretto per affrontare argomenti economici, tecnologici, scientifici. Il latino, ma ancora di più il greco, sono tuttavia rimasti nella radice di molti termini cosa che fa pensare erroneamente che la loro conoscenza aiuti nell’uso delle lingue di oggi.
Il latino per lunghi secoli è stata la lingua nobile della classe egemone e, forse, la classe egemone era tale in quanto alfabetizzata e capace di leggere e scrivere come i Druidi erano egemoni nella società delle Gallie.
Probabilmente nelle varie riforme scolastiche che si sono succedute in Italia l’associazione tra classe dirigente e studio del latino è stato sempre un tabù che solo recentemente è stato superato dando vita al liceo scientifico ad indirizzo tecnologico che non prevede lo studio del latino.
Oggi il latino ed il greco possono e devono essere oggetto di continuo studio da parte di esperti ed appassionati che, per mestiere o per diletto curino quel patrimonio immenso di cultura ricavandone tutti i contributi possibili per la lettura della cultura di oggi. Se questa scelta di impegno si verificasse già in giovane età, la possibilità di coltivarla dovrebbe essere offerta dalla scuola pubblica come opzione facoltativa come scelta individuale per la preparazione a studi ben più impegnativi.
Solo allo scopo di dare un’idea quantitativa dell’impegno profuso nello studio del latino nel corso degli anni, si ricorda che, negli anni 30-40, nel liceo classico le ore settimanali dedicate al latino erano 4 su 25 (16%) e nel liceo scientifico 4 su 26 (15%). Oggi nel liceo classico le ore di latino sono 4 su 28 (14%) e nello scientifico 3 su 30 (10%). Queste ore sono poche per consentire un apprendimento del latino serio ma sono troppe se si considera il carico aggiuntivo di laboriose letture da svolgere a casa.
Come conclusione si potrebbe decidere di sostituire anche nel liceo scientifico lo studio della grammatica e della sintassi latine con un maggiore approfondimento della lettura dei classici ben tradotti recuperando maggiormente il patrimonio culturale alla base della nostra civiltà. Valore aggiunto non trascurabile potrebbe essere un maggiore interesse degli studenti invogliati così a mantenere un contatto con queste culture anche nel resto della loro vita.
![]()
Saper leggere
Su la Repubblica del 13 maggio2016 ho letto due articoli: il primo è del Direttore Ezio Mauro intitolato “I superstiti dell’Apocalisse” sul sistema politico italiano ed i suoi rapporti con la giustizia ed il secondo scritto da Walter Veltroni intitolato “Il nazionalismo e le parole giuste per dire Europa”.
Come si vede, sono due argomenti di altissimo livello di interesse in questo momento storico nel quale sono forti gli interrogativi sull’etica della nostra vita pubblica e sulla evoluzione del lungo ed incerto processo di formazione di un’Europa più vicina a quelle che erano le attese dei fondatori. Non si entra nel merito dei contenuti che peraltro sono sempre presenti nella migliore stampa contemporanea, ma possiamo utilizzarli per dare corpo ad alcune domande.
1. Quanti ragazzi tra i 16 ed i 20 anni sono interessati a leggere gli articoli proposti?
2. Quanti ne comprendono il filo logico del discorso?
3. Quanti conoscono i riferimenti relativi agli avvenimenti ed ai personaggi citati?
4. Quanti si formano una propria opinione sul tema trattato?
5. Quanti riescono ad esporre in maniera argomentata il proprio punto di vista?.
In fondo le domande poste rispondono agli obiettivi di capacità da conseguire per ottenere la maturità.
Al raggiungimento di questi obiettivi si oppongono da una parte una riluttanza della scuola ad entrare con decisione nella lettura dell’attualità e, dall’altra, una lettura della storia frammentata, più attenta ai fatti anche marginali più che al loro significato ed alla loro interconnessione. Solo con questa chiave di lettura si può sviluppare un collegamento tra la storia e l’attualità acquisendo capacità a discuterne. È quindi fondamentale una continua abitudine a discutere opinioni, a scambiare informazioni, a mantenere vivo l’interesse per gli avvenimenti di attualità. Non si vuole creare un clima da dibattito televisivo ma è proprio in questo modo che gli studenti possono imparare a raccogliere dati, ad argomentare, a rispettare le idee degli altri, a stabilire un rapporto sociale costruttivo.
Una osservazione che forse viene oscurata dalla nostra secolare abitudine a far coincidere la “cultura” con il mondo classico è la sproporzione tra l’impegno dedicato ai secoli passati e l’estrema semplificazione con la quale trattiamo la contemporaneità. In questo siamo anche perseguitati dall’idea che trattare la storia recente sia pericoloso in quanto finisce con il condurci sulla politica con la p minuscola. D’altra parte non possiamo studiare sui testi classici che la politica è l’attività più nobile dell’uomo e poi escluderla perché finalmente abbiamo scoperto che dovrebbe esserlo anche oggi. Finché si studia, parliamo di Politica, quando si fa sul serio, la politica è tabù.
La frattura tra quanto propone la scuola e quanto richiede la nostra partecipazione alla vita civile è in continuo aumento perché i rapporti sociali divengono sempre più complessi con lo sviluppo demografico, con la maggiore partecipazione di classi sociali prima escluse, con uno sviluppo scientifico che continuamente fornisce risposte agli interrogativi ed ai bisogni dell’uomo, che interagisce con i comportamenti ed i valori della società.
Dall’altro canto, gli studi classico/umanistici vengono proposti con una loro finalità intrinseca di piacere, di godimento, pur legittima, ma assolutamente priva di connotazioni connesse agli attuali bisogni dell’uomo. Letteratura, storia, arte, vengono raccontate in maniera analitica, quasi maniacale, ma con poca enfasi sul loro contributo allo sviluppo della nostra civiltà ed alla loro funzione fondante di quello che siamo oggi. È così che per tanti e lunghi anni i ragazzi studiano avvenimenti, personaggi e opere che sembrano privi di significato mentre l’attualità viene rabberciata in qualche modo all’ultimo anno di liceo.
Viene qui opportuno sottolineare che è sbagliato rispondere a questi problemi con la solita questione da salotto “classico o scientifico?” come se gli studi scientifici potessero modernizzare la scuola. Il problema è nel modo in cui si affrontano gli studi uma...