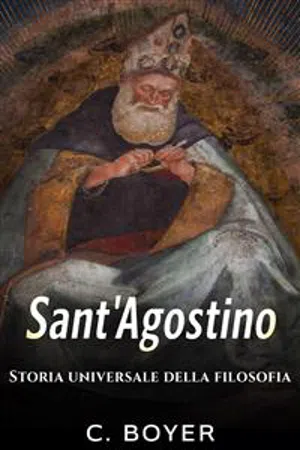CAPO IX - LA DOTTRINA MORALE
- 1. I PRINCIPI.
Ci ricordiamo che sant'Agostino tra tutti i filosofi preferì i platonici perché' questi “avendo conosciuto Dio trovarono dove sia la causa che creò l'universo, la luce che fa percepire la verità, e la fonte a cui si beve la felicità”. Così indicava le proprie conclusioni nelle tre parti della filosofia. Nella morale, a cui ora arriviamo, due parole che significano una stessa realtà saranno continuamente ripetiate: Dio, felicità.
Se il nostro Dottore dipendeva prima di tutto, e principalmente nei problemi etici, dalla dottrina cristiana, nel modo però di ordinare -i concetti e di presentare i problemi egli seguiva i filosofi antichi, cioè, come sempre, i platonici, e poi Cicerone, moralista egli stesso e storico delle scuole greche. Per lui, come per l'autore del De finibus bonorum, il problema morale è il pro, blema del fine, cioè quello del sommo bene che finisce e completa il nostro bene, facendolo perfetto, il bene dunque che è voluto per se stesso e per cui sono voluti gli altri beni.
Qualunque passo in morale suppone però alcune nozioni primitive, di bene, di dovere, di legge, di obbligazione, di merito, di valore ed altre. Il sommo Bene è un bene; la felicità è un valore. Come si sono formate queste idee, senza cui neppure la questione del sommo Bene potrebbe sorgere?
Le prime nozioni morali hanno nella dottrina agostiniana la stessa origine delle altre idee primitive: sono in noi il risultato di un'illuminazione naturale, una partecipazione alla medesima Verità. Sciolto il problema metafisico con la dottrina della creazione, e sciolto conseguentemente il problema gnoseologico con la dottrina dell'illuminazione, segue di necessità la posizione ed anche la soluzione fondamentale del problema morale; seguono, cioè, l'esistenza e la conoscenza del dovere in generale.
Sant'Agostino infatti, tra le evidenze naturali a cui si appella sia per convincere gli scettici, sia per iniziare qualche dimostrazione, mette sullo stesso piane delle altre quelle di ordine pratico che sono i primi principi della moralità: si deve vivere bene, le cose superiori si devono preferire alle inferiori, si deve stimare i beni eterni più dei passeggeri, ecc.. Principi astratti, è vero, molto generici, ma nei quali sono incluse le nozioni morali fondamentali.
C'è di più: le stesse nozioni non sono soltanto implicate nei dettami della ragione pratica, ma si trovano presenti ed operanti in un moto naturale della volontà, il desiderio di essere felici. Questo desiderio è comune a tutti gli uomini; è necessario e si ritrova alla radice di ciascuno dei nostri atti. Il desiderio della vita beata è dunque comune ai filosofi ed ai cristiani. “Ciò che è in discussione, ciò che divide è di sapere dove sta quella cosa da tutti amata. Ma volere la vita beata, ambire la vita beata, ricercarla, proseguirla, questo è, come credo, di tutti gli uomini”. Agostino è convinto che non vogliamo mai niente, neppure la virtù, neppure la morte, se non per amore della felicità. Ora la volontà è solo di ciò che in qualche modo si conosce. Col desiderio della felicità c'è dunque una certa nozione naturale del nostro bene, e in quest'inclinazione insopprimibile l'indicazione del termine a cui dobbiamo giungere. Come nel campo speculativo, non tutto è da trovarsi e da dimostrarsi, ma i lumi fondamentali ci sono dati con la nostra natura, così nel campo pratico della morale, non tutto è da scoprirsi; le basi e le grandi linee direttive stanno già costituite in ogni mente umana. È una prima trascrizione della legge eterna nella nostra ragione, che la riflessione poi e l'esperienza e la rivelazione completeranno ed applicheranno ai casi singoli. Già con essa sappiamo che i nostri atti hanno una regola e che questa regola c'impone di conseguire il nostro bene. Alla scienza della morale appartiene di determinare quale sia il nostro vero bene, da quale autorità scenda la legge scritta in noi, •quali sono gli atti conformi a questa legge e utili al conseguimento del nostro fine.
Da queste premesse si vede già che l'etica agostiniana sarà un eudemonismo, ma si vede anche che sarà un eudemonismo etico. Vero è che in esso il termine dell'azione morale è la felicità, ma sia nella legge che indirizza verso il termine, sia nella natura stessa della felicità la ragione è pienamente soddisfatta. È un'attività secondo la ragione, ma appunto per essere secondo la ragione è un'attività tesa verso la ricerca o immersa nel possesso del Nero bene dell'agente.
Vediamo prima col nostro Dottore quale sia il sommo bene dell'uomo. Varrone aveva fatto il calcolo delle opinioni possibili su questo punto e ne aveva contato 288. Ma egli stesso le riduceva poi a dodici e finalmente a tre: o il sommo bene consiste nei 'doni di natura, o nella virtù, o nelle due cose insieme. L'Ipponense rigetta tutte e tre queste soluzioni.
La felicità che sazia il cuore dell’omo non può essere quella del corpo. Sarebbe mettere il corpo al di sopra dell'anima, il sensibile sopra l'intelligibile, il corruttibile sopra l'immortale. Dire il contrario è una vergogna, sebbene serva a sedurre il volgo ignorante e sensuale ed a portarlo alle sedizioni. Ma neppure le gioie dello spirito bastano all'uomo: ci vuoi tanta fatica per arricchirsi la mente ed è sempre così limitato il risultato che si ottiene! E poi, se si guarda ai fatti, quanti impedimenti ostacolano la permanenza o l'uso dei beni terreni, tanto del corpo quanto dell'anima: Malattie, disgrazie, contrasti, ecc.!
Potrà forse la virtù dirsi il sommo bene dell'uomo? Qui bisogna fare qualche distinzione per non travisare il pensiero del nostro Dottore. Se si considerasse la virtù nel suo termine, quando s'identifica coll'atto stesso della contemplazione e dell'amore di Dio, allora sì, si dovrebbe dire il fine dell'attività morale. Anche considerata solo nel suo esercizio presente e terreno, la vita virtuosa sarebbe da preferirsi al suo contrario. Ma se si prende la virtù come la possiamo praticare in questa vita, è forse capace di darci la felicità e di saziare i nostri legittimi desideri? L'hanno sostenuto gli Stoici, ma si sono confutati essi stessi quando hanno permesso al loro eroe, al sapiente, di ricorrere al suicidio in certi casi. Che felicità è questa a cui è da preferirsi la morte?. La virtù quaggiù è duro combattimento contro le cattive inclinazioni. Può essere l'arnia per conquistare il sommo bene; ma il sommo bene, essa di certo non lo è.
Quanto a mettere insieme i beni terrestri con la virtù, ciò non toglie le lacune delle due specie di beni. È dunque chiaro che la felicità a cui aspiriamo, l'uomo non la trova in se stesso. La troverà sopra di sè.
Anche qui, ciò che abbiamo detto della conoscenza ci può istruire assai. L'uomo non basta a se stesso per vedere la verità, ma la (leve ricevere partecipando alle ragioni eterne che sono la Verità sussistente. Così la verità deve venire all'uomo dall'alto per partecipazione della pienezza divina.
Si possono distinguere nei testi agostiniani tre ragioni principali per dimostrare che Fuorao non trova che in Dio il bene che egli desidera. La prima è che niente di limitato e di passeggero ci soddisfa pienamente; ora, Dio solo è eterno e perfetto. La seconda è che essendo quello che amiamo quaggiù soltanto un riflesso ed una lontana imitazione della divina perfezione, quanto più naturale e saziante deve essere per noi l'amore del perfetto esemplare! L'esperienza stessa ci dà un'ultima conferma del nostro alto destino. Chi cerca altro che Dio vive bell'irrequietezza e nell'insoddisfazione. Chi arriva a conoscere ed a trovare Dio s'accorge di aver trovato il suo centro e la vera pace. È il detto celebre: “Signore; ci hai fatti per te ed il nostro cuore è irrequieto finchè non si riposa. in te”. Non si potrebbe forse dire che la fortuna di queste parole è come una testimonianza dell'umanità che vi riconosce la propria esperienza?
I Platonici arrivavano fin qua, e mettevano nell'unione con la divinità il fine supremo ed il sommo bene dell'uomo. A quel punto però introducevano dei particolari che guastavano la dottrina e che Agostino con grande cura confutò. Volevano che le anime beate, dopo un tempo molto lungo, sentissero di nuovo il desiderio di tornare su questa terra e riprendessero un corpo per una altra vita quaggiù. Ma come capire che le anime immerse nella gioia divina vogliano scambiarla con le miserie di questo mondo? Come possono godere in pace la loro felicità se sanno che dovrà finire; e se non lo sanno, quest'ignoranza è una infelicità di più.
Se nella nostra mente e nel cuor nostro dobbiamo avere un giorno il bene che ci perfeziona e che ci sazia pienamente, possederemo Dio, conoscendolo come egli è, vedendolo in un'unione immediata con lui. “Quale è il fastigio della fabbrica che stiamo costruendo? Fin dove arriverà la cima dell'edificio? Lo dico senz'altro fino alla visione di Dio. Pensate quanto è sublime, che grande cosa è, vedere Dio. Chi lo desidera capisce e ciò che io dico e la cosa che egli sente. Ci è promessa la visione di Dio, del Dio vero, del sommo Dio”. Come appare in questo testo, Agostino fa ricorso alle promesse divine, perché altra cosa è che siamo desiderosi della visione divina ed altra cosa è che ci venga concessa. Che Dio si sveli al nostro intelletto per comunicarci la sua felicità, Agostino l'ha certamente tenuto per un dono assolutamente gratuito, risultante dalla libera adozione che Dio ha fatto di noi come di suoi figlioli, realizzando così un ordine soprannaturale. Le creature intellettuali sono capaci di ricevere questo dono; ma sono creature così alte che anche lasciate in uno stato molto inferiore, avrebbero assai da lodare e da ringraziare il loro Creatore. Poichè però sono fatte per Dio, qualunque fosse il loro stato, il loro fine e il loro bene sarebbe sempre di conoscere e di amare Dio secondo il miglior modo a loro concesso.
Conosciamo adesso la via vera della felicità: è quella che conduce a Dio. La via della ragione non è altra: che il bene sia amato, che il miglior bene sia perfetto, che il sommo Bene sia unicamente voluto, quest'è l'ordine è la giustizia. Ora la via della ragione è la via del dovere. Il dovere, è vero, aggiunge alla nozione di ragionevole quella di obbligazione. Ma appunto l'ordine della ragione non si presenta a noi come fatto dalla nostra mente è illuminata, l'abbiamo visto, dalla Mente divina, di cui ci trasmette l'eterna legge, cioè “la divina disposizione che comanda il rispetto dell'ordine naturale e proibisce di turbarlo” (14). In Dio, l'ordine delle nature e in particolare la relazione- della natura umana al suo fine, il possesso di Dio, è costituito dal divino intelletto ed è amato dalla volontà divina che ne vuole il rispetto; in noi, il medesimo ordine è conosciuto ed è manifestato dalla ragione come oriundo dalla divina ragione e voluto dalla divina volontà, e dunque come imponendosi alla nostra volontà. In Dio è legge di natura, non superiore, ma identica al suo soggetto; in noi è legge ricevuta, imperativa, a cui la volontà ha l'obbligo di obbedire; e quest'obbligo, questa dipendenza sono contenuti nella stessa legge eterna; come di tutte le altre relazioni, il nostro lume naturale ne vede la ragionevolezza, ma non la fa. Cioè, a dire che in S. Agostino, la moralità è fondata sopra un assoluto e però la nostra volontà non è autonoma, ma dipendente. Siamo lontani dal Kantismo, e ne siamo lontani anche perché l'imperativo di cui parla il santo vescovo non è una forma vuota, ma, risultando dall'essenza divina e dall'ordine ontologico delle altre essenze, ha per contenuto il bene degli esseri ragionevoli.
- 2. LA CARITÀ.
- I.
Dal detto fin qui potrebbe sembrare che nell'etica di sant'Agostino l'attività morale sia tutta orientata verso un fine d'interesse individuale, come lo sarebbe in un utilitarismo bel calcolato. Le ragioni universali appaiono in fin dei conti ordinate dalle persone singole alla loro propria felicità. L'ultima parola del sistema pare clic sia un egoismo superiore.
Il senso però della morale agostiniana è tutt'altro. Certo, essa dirige l'azione verso il sommo bene dell'agente. Ma la natura del sommo bene è tale che invece di un gretto egoismo risulta da quella relazione il più universale degli ordini e il più puro degli amori. Diciamo subito perché: è perché l'atto con cui si ricerca e si possiede il sommo Bene non è un atto di amore di sè, ma un atto di amore di Dio. Così l'ordine etico non si compie nell'indefinito degli universali astratti, ma nella concretezza del più reale degli esseri, il quale, essendo l'ente necessario e fonte di ogni bene, è il Bene comune di tutti e il fine dell'universo.
Si osservi prima che nell'amore interessato, l'oggetto dell'amore non è amato per se ma come mezzo e per avere un'altra cosa. Invece l'amore di Dio finisce a Dio stesso: non si ama Dio per avere un'altra cosa: “Lo si ami e lo si lodi gratis. Che significa gratis? Lui stesso per se stesso e non per altra cosa. Se !odi Dio affinchè egli ti dia un'altra cosa, non ami Dio gratis. Ti vergogneresti se tua moglie te amasse per le tue ricchezze e se, diventato povero, pensasse all'adulterio. Tu dunque, eh,. vuoi essere amato gratis da tua moglie, amerai Dio per altra cosa? Quale ricompensa riceverai da Dio, o avari.? Non è la terra, ma è se stesso che ti riserva Colui che ha fatto il cielo e la terra”. Ora, ordinare l'amore di Dio alla propria felicità come a qualche cosa d'altro, non sarebbe amare Dio gratis.
In verità, l'amore di Dio, quando è perfetto, non è ordinato a nessun altro amore, neppure all'amore di sè. Secondo una distinzione prettamente agostiniana, Dio è l'ente di cui si gode e si gioisce; tutto il resto, messo in paragone di lui, è ciò di cui ci serviamo. ( Se ben ci si pensa, l'uomo non deve gioire di se stesso, perché non si deve amare a causa di se stesso, ma a causa di Colui, di cui dobbiamo gioire. Allora infatti l'uomo è ottimo, quando con tutta la sua vita tende verso la vita immutabile e ad essa con tutto il cuore aderisce”.
Il vero amore di se è dunque l'amore di Dio. L'apparente contradizione di questa dottrina si dilegua riflettendo che l'amore di Dio, la carità, è la perfezione dell'anima e la sua felicità: “Come diventeremo belli? Amando Colui che è sempre bello. Quanto cresce in te l'amore, tanto cresce, la tua bellezza: è la carità che è la bellezza dell'anima”. Ed ecco insieme espresso chiarito il paradosso: “Non so in che modo inspiegabile; chi ama se stesso e non ama Dio, non ama se stesso; e chi ama Dio e non se stesso, ama se stesso. Colui infatti che non può vivere da sè, muore di certo amando se stesso: dunque non si ama, poichè.si ama per non vivere. Ma quando uno ama Colui da cui si vive, si ama di più non amando se stesso, poichè se non ama sè, è per amare Colui da cui si vive”.
Con la carità, si cesserebbe forse di amare se stessi?
In nessun modo, ma l'amore di se viene riferito all'amo, re di Dio. Amiamo in noi stessi il riflesso di Colui che sopra tutto amiamo. Insomma, ritorna la dottrina della partecipazione. Possiamo di noi e di Dio fare una certa unità ordinata, che è il termine del nostro amore, perché tutto ciò che può stare in noi di perfezione è immagine di Dio. Lo stesso amore può terminare all'immagine e al modello, ed è per amor del modello che si ama l'immagine.
In questo bel modo appare l'equilibrio della dottrina agostiniana sui fondamenti della morale. Egli raccoglie attentamente i dati dell'esperienza, scrutando le intuizioni ed i desideri dell'anima umana; e sale poi fino all'assoluto della ragione e della volontà divina. Egli riconosce quanto l'amore di noi stessi ci è in qualche modo consostanziale, e però lo sa condurre fino al puro amore di Dio. Non è d'altronde da meravigliarsi se tra gli interpreti non tutti seppero sempre ricomporre tanta armonia e se, insistendo su una serie di testi senza considerare abbastanza anche l'altra, alcuni, come Bolgeni, non videro che l'amore di concupiscenza, mentre altri, seguendo lo Scoto vollero un amore di Dio senza amore di sè. Divergenze simili s'incontrano quasi ogni volta che si domanda a un autore antico di far da arbitro in una controversia, di cui forse egli scioglie il nodo, ma che non ha considerata esplicitamente.
Trovato il fine obbligatorio dell'uomo, si è trovata la regola della sua condotta, e la virtù consisterà nell'inclinazione a vivere costantemente secondo questa regola. Sarà dunque la ricerca di Dio ed il compimento della sua volontà manifestata dalla nostra ragione. Così la virtù principale e in qualche modo la virtù unica sarà la carità, ossia l'amore di Dio. a Per dire brevemente il mio concetto della virtù nella vita morale, la virtù è la carità, per cui si ama ciò che si deve amare”. E ancora: “La carità principiante è la giustizia principiante, la carità crescente è la giustizia crescente, la grande carità è la grande giustizia, la carità perfetta è la perfetta giustizia”.
La carità verso Dio contiene l'amore delle immagini di Dio che sono le creature intelligenti, non solo l'amore di se stesso, come abbiamo visto, ma l'amore di tutti gli uomini. Agostino formula e precisa il dovere dell'amore verso i prossimi con le parole sacre che esprimono i due comandamenti, somma della Legge e dei profeti, e a cui già Cristo ha dato un senso universale: Amerai il Signore, tuo Dio, e il prossimo come te stesso. Ma la fratellanza di tutti gli uomini si armonizza bellamente con la sua filosofia.
Il primato della carità non sopprime le altre virtù, ma queste, in qualche modo, sono le sue determinazioni, i suoi istrumenti. Se consideriamo le quattro virtù elencate dalla morale antica, vediamo che non sono altro che la carità in diversi campi di attività: “La virtù consiste nell'amore di ciò che deve essere amato: sceglierlo, è la prudenza; non lasciarsene distogliere dalle difficoltà, è la fortezza; nè dalle seduzioni, è la temperanza; nè dalla superbia, è la giustizia”. Anzi queste virtù persevereranno in qualche modo nella carità, quando il termine della visione di Dio sarà raggiunto. La regnerà la sapienza, la quale “si potrà chiamare prudenza, perché con ottimo avvisamento si attaccherà al bene che non si perde; forza, perché aderirà fermamente al bene da cui non si distaccherà mai; temperanza perché aderirà costantemente al bene in cui non si corromperà; giustizia, perché aderirà rettamente al bene in cui conviene che si sottometta”.
Si vede con ciò come la concezione agostiniana della attività umana, tanto nel suo sviluppo terreno, quanto nel suo termine nell'al di là, comporta una significazione strettamente morale.
Ma ecco che si affaccia un grande problema: se la carità è così necessaria alla vita morale, laddove mancherà la carità, sarà possibile qualche virtù? E il problema è reso più grave, quando si tiene, come fortemente lo teneva il vescovo d'Ippona, che la carità si ha solo per dono di Dio e che suppone già un altro dono, quello della fede. Certo Dio poteva distribuire questi doni anche fuori delle istituzioni in cui si trovavano normalmente, cioè, prima di Cristo, fuori del popolo giudaico, e dopo Cristo, fuori della Chiesa cattolica. Agostino ne conosceva degli esempi: quello di Giobbe; quello di Cornelio. Questi però sembravano eccezioni. E allora, che cosa pensare della moralità di tanti pagani? Che -cosa pensare anche di quei cristiani che hanno la fede, ma che hanno perduto la carità? Lasciando da parte, in questa esposizione della filosofia di S. Agostino, i suoi argomenti di ordine teologico, vediamo i principi filosofici a cui egli si ispira in questa importante questione.
Che cosa dunque pensare delle virtù tanto celebrate di alcuni pagani, per esempio degli eroi, come Catone, Fabio, Scipione, Regolo, o dei filosofi, come Socrate, Platone, ecc.? Si dice alle volte che il santo vescovo le abbia chiamate “splendida villa”. L'espressione non si trova nelle sue opere, e non risponde esattamente al suo pensiero. Egli non nega la bontà delle virtù esercitate, per esempio, dai Romani: temperanza, amor patrio, fortezza di animo; egli va fino a chiamarle “dona Dei”, come ogni cosa buona; sono degne di una ricompensa, sebbene soltanto terrena; ma tale bontà è soltanto relativa. Si consideri la questione come si poneva tra Pelagio e Agostino. Pelagio sosteneva che l'uomo può possedere la giustizia senza la grazia di Dio, e la giustizia significava la piena rettitudine morale; come esempi di uomini virtuosi, egli adduceva i grandi uomini della storia di Roma, come se, diceva Agostino, avesse voluto intimidire il suo avversario con la maestà del senato romano. Il Dottore della grazia non intendeva negare ogni moralità a quei grandi uomini, ma soltanto quella. giustizia che loro si attribuiva. La giustizia richiede anzi lutto che l'uomo riconosca e onori il vero Dio, e quei cultori delle divinità pagane mancavano a questo dovere, malgrado la testimonianza che danno delle perfezioni invisibili di Dio le perfezioni create, come attesta S. Paolo: “Ìnvifibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae fatta sunt intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas, ita ut sint inexcusabiles”.
Mancando poi l'orientamento fondamentale della volontà verso Dio, le virtù di quegli uomini non potevano essere senza difetto e una virtù difettosa non realizza il concetto di virtù, non è una vera virtù, in morale non basta considerare l'azione che si fa, ma si deve attendere all'intenzione con cui si fa. L'azione perfettamente morale è quella che si compie per amore di Dio. Vero è che quest'intenzione non può sempre essere attuale ed è perciò che lo stesso Agostino ammette che anche i peccatori, senza rinnovamento interno, possono fare alcuna di virtù, si parla di una disposizione permanente rettamente ordinata. Chi 'non serve il vero Dio non ha una tale disposizione.
A quest'argomento generale, lo storico della città di Dio aggiungeva la conferma dei fatti. Dagli scritti di Orazio, di Virgilio, di Cicerone, di Sallustio, egli ricavava la prova che il motivo per cui i grandi Romani superarono molti vizi e praticarono delle virtù, era l'amore sregolato della gloria. a Reprimendo per quel solo vizio, cioè l'amore della lode, l'attaccamento al danaro e molti altri vizi”. Tutto ciò Che veniva compiuto con quest'intenzione era viziato, essendo quest'amore della gloria amore di se senza il necessario riferimento a Dio. Altro è però una virtù viziata da un difetto ed altro è un vizio. Agostino non ha confuso le due cose. La sua dottrina sulle virtù dei pagani manifesta quanto per lui era necessario alla vera moralità l'adempimento dei doveri verso Dio. Quali roventi pagine avrebbe egli scritto contro i moderni laicizzanti!
Passiamo a quegli uomini che credono nel vero Dio ma che non hanno per lui un amore sufficiente, cioè 'non hanno tanto amore che basti per far loro evitare il peccato. Possono però avere già il timore di Dio e dei suoi castighi e per questi sentimenti si astengono dal fare il male. Quale è il valore morale di un tal timore e degli atti che ispira? I testi del nostro autore non sono di facile interpretazione. Anche nel passo principale, in cui egli tratta la questione direttamente e con magnifica eloquenza, in un sermone sulla prima epistola di S. Giovanni (28), non è facile determinare in che senso egli approvò il timore dei castighi che ritrae dal peccato ed in qual senso lo biasimò. Bisogna seguire l'esposizione nel suo intero movimento prima di ridurla alle distinzioni degli odierni moralisti.
Diciamo prima che vi è un timore che Agostino, con la S. Scrittura ch...