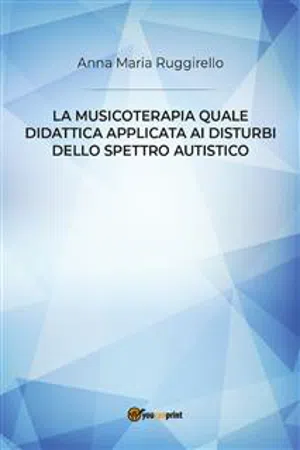
eBook - ePub
La musicoterapia quale didattica applicata ai disturbi dello spettro autistico
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La musicoterapia quale didattica applicata ai disturbi dello spettro autistico
Informazioni su questo libro
Il presente lavoro parte dal tentativo di delineare un quadro generale dell'autismo per poi cercare di spiegare come si possano in qualche modo arginare le difficoltà che questi soggetti così spesso incontrano attraverso la relazione che la musica e il suono mediano.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La musicoterapia quale didattica applicata ai disturbi dello spettro autistico di Anna Maria Ruggirello in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Disturbi dello spettro autistico. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1 - L’AUTISMO
1.1 Inquadramento della sindrome
L’autismo è un complesso disturbo del comportamento che insorge entro il terzo anno di vita. L’esordio della malattia è graduale: i bambini fin da piccoli non mostrano il desiderio di essere cullati o tenuti in braccio, e quando piangono trovano più spesso consolazione nel rimanere soli che nel contatto con i genitori. In genere, però, il momento in cui i genitori realizzano la presenza del problema è intorno al secondo anno di vita, quando il ritardo di linguaggio del bambino diventa evidente. In circa un terzo dei casi, peraltro, l’autismo ha un decorso “regressivo”: i bambini imparano correttamente a parlare ma poi, in modo repentino, perdono la capacità di linguaggio e tendono ad isolarsi.
Sebbene sia stato suggerito che nelle forme regressive l’autismo derivi esclusivamente da fattori ambientali che sono intervenuti danneggiando un bambino altrimenti nato sano, l’analisi retrospettiva condotta su filmati dei bambini affetti sembra indicare che invece anche in questi casi esistessero segni clinici precoci, seppur minimi, della patologia. In circa un quarto dei casi, i bambini con autismo riescono col tempo a sviluppare capacità di linguaggio e ad essere inseriti, a diversi livelli, nell’ambiente scolastico. Nei rimanenti casi, nonostante un certo miglioramento col passare degli anni, le capacità di autonomia e di inserimento sociale sono minime. Per poter definire un bambino come “autistico” è necessario che siano presenti tre specifici tipi di anomalie del comportamento: anomalie della interazione sociale, difetti della comunicazione e comportamenti ripetitivi e stereotipati.
1) Anomalie della interazione sociale: i bambini affetti da autismo vivono in un caratteristico isolamento rispetto alle persone che li circondano, con le quali evitano ogni tipo di contatto. I bambini autistici tendono a stare da soli e a trascorrere lungo tempo intenti in attività spesso ripetitive, nelle quali non coinvolgono i genitori o i fratelli. I giocattoli sono visti come oggetti privi di alcun riferimento alla realtà: modellini di automobili, bambole, soldatini, non sono usati per simulare situazioni della vita reale, ma come oggetti qualsiasi. Nell’ambiente scolastico, i bambini autistici non creano rapporti di amicizia, e non frequentano i coetanei.
2) Difetti della comunicazione: i bambini con autismo non sono in grado di instaurare comunicazioni reciproche di tipo verbale o gestuale. Il linguaggio è fortemente compromesso. I bambini autistici presentano peculiari stereotipie del linguaggio quali la ecolalia, le inversioni dei pronomi, e l’uso di inflessioni e intonazioni inusuali.
3) Comportamenti ripetitivi e stereotipati: possono essere presenti stereotipie motorie quali muovere in continuazione le dita, sfogliare ripetutamente le pagine di un libro, leccare. Questi movimenti possono proseguire per ore. I bambini autistici possono sviluppare rituali precisi per una serie di attività giornaliere, quali la richiesta ai genitori di una precisa sequenza di eventi per alcune attività, o di una esatta sequenza di parole per esprimere un concetto o una richiesta. Quando i genitori non seguono queste indicazioni, si possono avere da parte dei bambini crisi inconsolabili di urla e pianto.
Insieme a questi comportamenti caratteristici, che sono presenti in tutti i bambini con autismo, diversi altri sintomi possono manifestarsi in una elevata percentuale (ma non nella totalità) degli affetti. Tra questi ricordiamo: – La iper- o ipo-sensibilità ai rumori e al contatto fisico: rumori non particolarmente forti o il contatto con determinati tessuti possono risultare insopportabili ai bambini con autismo, mentre stimoli normalmente dolorosi (ustioni, ferite) possono essere ignorati; – Comportamenti stereotipati riguardo al cibo: il tipo di alimenti e la loro disposizione nel piatto devono essere limitati e specifici; – Anomalie del sonno: assenza di sonno notturno, risvegli in ore avanzate della giornata; – Comportamenti auto- od etero-aggressivi; – Anomalie dello sviluppo motorio; – Totale assenza del senso di pericolo;
Alcuni autori di matrice anglosassone parlano di spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) per indicare l’estrema variabilità individuale che si cela sotto l’etichetta diagnostica di “autismo” (Wing, 1996). Le classificazioni internazionali (ICD-10: Disturbo pervasivo dello sviluppo) e (DSM IV: Disturbo generalizzato dello sviluppo) focalizzano entrambe l’attenzione per le direttive diagnostiche su tre criteri di base:
1. Alterazione della capacità di interazione e reciprocità sociale
2. Anomalia grave a livello dei processi comunicativi e del linguaggio
3. Presenza di modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati.
La evoluzione della malattia è difficilmente prevedibile. Tuttavia, esistono alcuni segni che possono essere considerati come indicatori di una cattiva prognosi, nel senso di una incapacità di recupero di capacità di integrazione nella vita sociale. Questi segni sono: – Bassi valori di QI: circa il 50%-70% dei bambini con autismo presentano bassi valori di QI in età prescolare. Questi casi presentano statisticamente un rischio maggiore di mantenere limitate capacità cognitive nel corso della vita, mentre i casi che non presentano basso QI hanno maggiori probabilità di inserimento nella vita scolastica e sociale. La diagnosi di autismo non è clinica.
Poiché la maggioranza dei segni specifici di questa anomalia interessa il comportamento dei bambini affetti, per potere con certezza diagnosticare la presenza di autismo è necessario utilizzare specifici test, che sono compilati in parte dal paziente e in parte dai genitori. Tra questi test ricordiamo il CARS (Childhood Autism Rating Scale), l’ABC (Autism Behavior Checklist), il GARS (Gilliam Autism Rating Scale).
Esistono alcune varianti di autismo le quali, per le loro peculiari caratteristiche, sono classificate come entità a sé stanti. Tra queste la sindrome di Asperger, che presenta i segni tipici dell’autismo con la importante differenza che lo sviluppo del linguaggio è normale. In questa sindrome, il segno principale è dato dai disturbi della interazione sociale. E’ ancora dibattuto se la sindrome di Asperger rappresenti una estremità dello spettro autistico, o rappresenti una entità clinica a parte, causata da specifiche anomalie genetiche.
La reale incidenza del disturbo autistico nella popolazione è stata a lungo discussa. In origine, si riteneva che la frequenza di tale disturbo fosse di un caso ogni 10.000 nati, inserendo pertanto l’autismo nel novero delle cosiddette malattie rare. In realtà, studi più recenti hanno dimostrato che l’incidenza dell’autismo è molto maggiore, arrivando a 22 casi su 10.000 nati per l’autismo propriamente detto e di 60 su 10.000 per tutti i disturbi dello spettro autistico. E’ stata anche avanzata l’ipotesi che in realtà l’incidenza dell’autismo nella popolazione sia aumentata negli ultimi anni addirittura di oltre il 200%, facendo sospettare la presenza di fattori ambientali coinvolti nella genesi di questo disturbo.
Circa il 90% dei casi di autismo hanno una origine “idiopatica”, ossia non è possibile identificare una causa specifica che giustifichi la comparsa della malattia. Nel 10% dei casi, al contrario, l’autismo è dovuto alla presenza di anomalie cromosomiche, mutazioni di singoli geni o cause ambientali (autismo “secondario”).
Tre le cause ambientali di autismo è prevalentemente chiamata in causa la esposizione durante la vita uterina a sostanze tossiche (acido valproico, talidomide) o a virus (rosolia). Per quanto riguarda la vita postnatale, grande rilievo è stato dato negli ultimi anni alla ipotesi che alcuni vaccini, contenenti mercurio, possano essere responsabili di autismo. Va però sottolineato come tale ipotesi, che ha portato negli Stati Uniti allo scatenarsi da parte della opinione pubblica di campagne di opposizione alla vaccinazione infantile, con immaginabili ricadute di tipo sanitario, non sia mai stata definitivamente accreditata dal punto di vista scientifico. Negli ultimi anni, grande interesse è stato rivolto allo studio delle cause genetiche di autismo. La componente genetica dell’autismo è al momento abbastanza ben definita nell’autismo secondario, molto meno in quello idiopatico. Per quanto riguarda l’autismo secondario, diverse patologie genetiche sono caratterizzate dalla presenza di autismo quale uno dei segni clinici riscontrabili:
– Sindrome di Down: nei soggetti con sindrome di Down, l’autismo ha un’incidenza maggiore rispetto alla popolazione generale (7%). L’autismo non può essere considerato una diretta conseguenza della trisomia 21, in quanto comunque la maggioranza dei soggetti con sindrome di Down non presentano segni di autismo, ma questa maggiore incidenza rispetto alla popolazione generale fa supporre che l’anomalia cromosomica possa in qualche modo abbassare la soglia di suscettibilità all’autismo. – Sindrome di Martin Bell (o dell’X-fragile): la presenza di tratti simi-autistici è un riscontro molto frequente nei pazienti con sindrome di Martin Bell. Circa la metà degli affetti infatti presenta segni tipici dell’autismo quali l’avversione allo sguardo fisso, il ritardo nello sviluppo del linguaggio, i comportamenti stereotipati, i disturbi del sonno, i comportamenti autoaggressivi, la irrequietezza, la disattenzione e la eccessiva sensibilità ai suoni. Per tale motivo, si ritiene da più parti che il test per la diagnosi della sindrome di Martin Bell vada condotto in tutti i pazienti con autismo apparentemente idiopatico. L’importanza di tale test è stata già trattata nel capitolo dedicato alla sindrome dell’X-fragile nell’ambito dei ritardi mentali su base monogenica. Segni clinici di autismo si trovano in diverse altre patologie genetiche. Tra queste, cito solo la sindrome di Rett. Molto più complesso è il quadro della genetica dell’autismo idiopatico, che rappresenta la stragrande maggioranza dei casi di autismo. Sebbene esista un accordo generale sul fatto che anche l’autismo idiopatico abbia una base genetica, la identificazione dei geni responsabili di questa condizione è risultata fino ad ora una impresa difficilissima. Sono stati condotti numerosi studi di linkage e di associazione, che hanno portato a dati discordanti e in certa misura addirittura conflittuali tra loro. Almeno trenta geni diversi sono stati chiamati in causa come potenziali candidati allo sviluppo dell’autismo.
1.2 L’autismo nel corso della storia
La storia dell’autismo, anche se relativamente breve, è stata oggetto di numerose ricerche che hanno dato il via ad una vasta letteratura su questo argomento. In poco più di cinquant’anni si sono trovate alcune risposte al perché di questo disturbo dello sviluppo ma si è dato anche il via a numerosi miti che continuano a fondare le convinzioni di molti professionisti che si occupano di persone affette da autismo. Gli autori che si sono cimentati in descrizioni varie dell’autismo, con ipotesi e teorie più o meno serie, non si contano. Per evitare di dare delle interpretazioni anacronistiche dell’autismo bisogna quindi situare in un contesto storico l’evoluzione delle ricerche in questo settore (G. Bernasconi 2001).
La prima persona a parlare specificatamente di autismo o più precisamente di Disturbo autistico fu Leo Kanner nel 1938. Kanner pubblicò il suo articolo intitolato “Disturbi autistici del contatto affettivo” nella rivista “Nervous Child” “a partire dal 1938 – scrive infatti Kanner - è venuto alla nostra attenzione un certo numero di bambini la cui condizione differisce in modo cosi netto da qualsiasi altra cosa…che ciascun caso merita…di essere considerato in modo dettagliato nelle sue caratteristiche affascinanti”. Kanner passò poi a presentare dei vividi quadri di undici bambini affetti secondo lui da tale condizione (U. Frith 1989).
Nel 1943, adottò ufficialmente il termine di autismo per indicare la Sindrome da lui osservata in questi bambini che chiamò autismo precoce infantile.
Kanner descrisse i suoi piccoli pazienti come tendenti all’isolamento, "autosufficienti", "felicissimi se lasciati soli", "come in un guscio", poco reattivi in ambito relazionale. Alcuni apparivano funzionalmente muti o con linguaggio ecolalico; altri mostravano una caratteristica inversione pronominale (il "tu" per riferirsi a loro stessi e l’ "io" per riferirsi all’altro), facevano cioè uso dei pronomi personali così come li avevano sentiti.
Molti avevano una paura ossessiva che avvenisse qualche cambiamento nell’ambiente circostante, mentre alcuni presentavano specifiche abilità molto sviluppate isolate (memoria di date, ricostruzione di puzzles, ecc.) accanto però ad un ritardo generale (L. Kanner 1943).
Kanner fece delle riflessioni anche attorno ai genitori dei bambini con autismo, che gli sembrarono freddi, intellettuali e poco interessati alle persone. Quasi contemporaneamente, anche Asperger utilizzò un termine simile, autistichen psychopathen, per descrivere altri pazienti da lui osservati sorprendentemente simili anche nella sintomatologia a quelli descritti da Kanner.
Come Kanner ma del tutto indipendentemente da lui Asperger suggerisce che vi sia un “disturbo di contatto a qualche livello profondo degli affetti e/o degli istinti”. Entrambi mettono in evidenza le caratteristiche della comunicazione e le difficoltà nell’adattamento sociale dei bambini autistici, entrambi prestano un’attenzione particolare alle stereotipie dei movimenti e al quadro sconcertante assolutamente non uniforme dei loro successi intellettivi. Entrambi sono colpiti da momenti di eccezionale prodezza intellettiva in aree ristrette.
Egli notò tuttavia tre importanti differenze rispetto a Kanner :
1) riguardo il linguaggio la presenza di un eloquio scorrevole;
2) riguardo la motricità la difficoltà nell’esecuzione di movimenti grossolani e non di quelli fini come affermava Kanner;
3) riguardo la capacità di apprendere, Asperger definiva i pazienti "pensatori astratti", mentre secondo Kanner essi apprendevano meglio in maniera meccanica. (F.Nardocci 2003).
A causa di ciò si configurarono due quadri diagnostici differenti: l’autismo di Kanner e la Sindrome di Asperger. (che oggi viene considerata come una vera Sindrome con caratteristiche ben precise e differenziate rispetto ad altre dello spettro autistico).
Tra gli autori che hanno seguito l’ipotesi avanzata da Kanner, sulle cause psicogene dell’autismo, Bettelheim fu senza dubbio uno di quelli che impostò il suo lavoro basandosi principalmente su questa interpretazione. I deficit della persona con autismo, per Bettelheim, non erano quindi organici ma venivano innescati come reazione alla mancanza di amore e di attenzione che i genitori portavano al figlio. Questi bambini si ritiravano allora in una forma di isolamento che li proteggeva dalle influenze esterne. Bettelheim ha molto influito nel promuovere questa teoria coniando il termine di “madri frigorifero” per designare la freddezza e il distacco con cui le mamme di bambini autistici si occupavano dei loro figli.
Nel 1967, anno in cui Bettelheim scrisse “La fortezza vuota”, la mancanza di ricerche e di metodi scientifici per comprendere l’autismo avevano contribuito al diffondersi di numerosi libri farciti di interpretazioni un po’ ingenue e prive di fondamento. Già nel medioevo quando nasceva un bambino deforme o con evidenti problemi, la colpa veniva data alla donna che, secondo le credenze dell’epoca, aveva“peccato” prima della gravidanza.
Bettelheim ed altri autori di quel tempo hanno in fondo riproposto una teoria che ricorda il modello medioevale. In una società prevalentemente maschilista era naturale che le cause di un disturbo dei figli venisse attribuito ad una interazione con la madre. Bettelheim sostenne che il proprio figlio avrebbe percepito nella madre un desiderio reale o immaginario di annullamento nei suoi confronti, o perlomeno che non fosse mai esistito.
Questa percezione avrebbe fatto precipitare il bambino in una paura di annientamento totale da parte del mondo, rappresentato interamente per il bambino piccolo proprio dalla madre: l’autismo scaturirebbe come meccanismo difesa da tutto ciò (B. Bettelheim 2001). Pur restando sempre alla base del modello psicodinamico, questo concetto subì delle modifiche in relazione ai sempre crescenti indizi che sembravano implicare un substrato di tipo biologico nella Sindrome.
Già nel 1959 Goldstein propose infatti di considerare l’autismo come un meccanismo di difesa secondario ad un deficit organico, paragonabile a quelle reazioni di pazienti cerebrolesi che sembrano espressione di meccanismi di protezione messi in atto passivamente allo scopo di salvaguardare l’esistenza del malato in situazioni di pericolo e di angoscia insopportabili. A partire dagli anni ‘60 il modello psicodinamico fu sempre più accusato di colpevolizzare ingiustamente i genitori dei bambini con autismo.
Questi ultimi, infatti, non mostravano tratti patologici o di personalità significativamente diversi dai genitori di bambini non affetti da autismo. Fu Rimland, direttore dell’Autism Research Institute, il primo a sostenere in modo sistematico che la causa della Sindrome autistica non fossero i genitori, ma che il disturbo avesse piuttosto una base organica. (Lanzi e Zambrino 1999). Ne scaturì l’approccio organicista, che cercava d’individuare alterazioni morfologiche e funzionali alla base della Sindrome.
Nonostante la varietà di elementi raccolti congruenti con quest’ipotesi, non ne è stato ancora isolato uno in particolare che possa essere considerato come caratteristico di tutte le forme di autismo, tanto che attualmente si è portati a credere che non esista un "unico autismo", ma che in questa categoria siano invece comprese diverse patologie e manifestazioni sintomatiche provocate da diverse cause organiche. Il concetto di autismo ha subito nel corso di mezzo secolo notevoli modifiche, come il passaggio da un’unica Sindrome, che poteva variare lungo un continuum di gravità crescente, ad uno spettro di disturbi indicante manifestazioni di sintomi molto diverse.
Ma il cambiamento più rilevante lo si può vedere confrontando le categorie di classificazione del disturbo utilizzate attualmente dai manuali diagnostici con le precedenti versioni. Precedentemente l’autismo infatti era compreso tra le psicosi precoci (ad insorgenza prima dei tre anni). Nella nuova classificazione internazionale, invece, l’autismo è compreso nei disturbi dello sviluppo, con una componente organica altamente probabile. Data l’alta variabilità delle manifestazioni comportamentali ad esso associate, la classificazione del disturbo è divenuta più generale. Nel 1987 per questo motivo già nel DSM III-R, in relazione al modello di Wing e Gould, venivano distinte tre principali aree di alterazione comportamentale: interazione sociale, comunicazione e repertorio di interessi. Ancora oggi l’eziologia dell’autismo resta comunque perlopiù sconosciuta ed è per tale motivo che i due manuali diagnostici più utilizzati seguitano a basare i criteri di riconoscimento su indicatori comportamentali (R.Grassi).
1.3 Modelli esplicativi dell’autismo
Gli ultimi decenni di ricerca hanno chiarito che all’origine dell’Autismo vi è un disordine, di varia natura, della organizzazione del Si...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1 - L’AUTISMO
- 2 - ALCUNI ASPETTI TEORICI
- 3 - L’ ATTENZIONE CONGIUNTA IN MUSICOTERAPIA
- 4 - UN POSSIBILE INTERVENTO IN MUSICOTERAPIA
- Conclusione
- Bibliografia