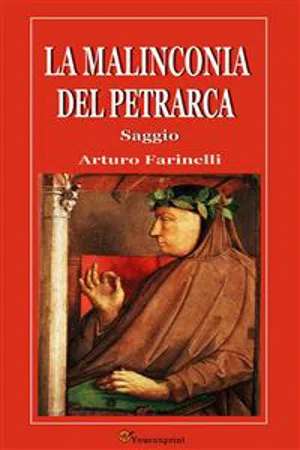![]()
LA MALINCONIA DEL PETRARCA1
L’estrema, morbosa sensibilità, la debol tempra dello spirito, irresoluto sempre, “solo nell’incostanza mirabilmente costante,” l’incontentabilità naturale, la natìa mitezza e tenerezza, l’esplorazione continua della propria coscienza, l’abito della riflessione, che atterra i fantasmi non appena evocati e condisce di veleno ogni piacere, hanno generato nel Petrarca una malinconia sua particolare, ignota fino allora all’anima del mondo poetico dell’età media.
In verità la Fortuna a pochi fu larga de’ suoi doni quanto al Petrarca. Per un po’ di durezza e rigidezza che esperimentò da una donna amata, vagheggiata e idealizzata senza fine, quanti favori non ebbe egli mai in una lunga vita ch’egli, quasi a risarcire la sorte della generosità sua, volle colmare d’affanni e di angosce. Desiderava amore, e fu come quant’altri mai amato ed accarezzato. Desiderava la gloria, e salì in tanta fama da essere considerato poco meno che una divinità in terra. I Romani lo coronano in Campidoglio. Da quell’alto seggio dove i contemporanei l’avevan posto, non lo smuovono i posteri, non avvizzì la morte l’alloro che imperituro gli posa sul capo. Per secoli, e dovunque, le sue rime d’amore sono l’amoroso codice che ogni vate consulta. In patria e fuori il Petrarca non trovò alle mire sue l’ombra di un contrasto. Come su Laura piovevano fiori dal cielo, piovevano sul suo capo tutti gl’imaginati beni di fortuna. Quelle acute spine che hanno insanguinato il cuore di Dante, il grand’esule infelice, non lo feriscono mai; quand’egli si avvicina ad esse, d’improvviso e come per incanto, torcono la punta e si vestono di rose. Alcune poche e non gravi malattie ad anni inoltrati, gli acciacchi della vecchiaia, moderati anch’essi, alcune perdite d’amici diletti – d’altre afflizioni del mondo esterno non poteva dolersi. La morte l’estinse soavemente.
*
* *
Eppure dall’infanzia alla morte è un gemere, un sospirare continuo, un accusare l’infelicità e le miserie infinite d’una misera esistenza. A tratti, quasi immemore dell’obbligato suo lamento, gli esce detto che non è tutta amaritudine la vita: “Ho corpo sano, ho libri in abbondanza, ho amici, godo dell’universale benevolenza…, ho per me quanto suol dirsi che basti alla vita;” confessa una volta che fin dal nascere gli tenne dietro, senza suo merito alcuno, “un non so quale favor della sorte.” Ma subito si ravvede e torna alle lacrime, ai sospiri. In vita sua non ha che crucci e travagli. “Da poi ch’io nacqui in su la riva d’Arno, | cercando or quella ed or quell’altra parte, | non è stata mia vita altro che affanno.” Similmente piange e s’addolora in altra favella:
Si meminisse velis, postquam genitricis ab alvo
Nudus, inops, querulus, miser et miserabilis infans
Emergens, tremulo vagitus ore dedisti,
Et labor, et lachrymae, et gemitus, et tristia curae
Pectora torquentes habitarunt corde sub isto:
Nulla fuit tibi laeta dies, qua posset anhelus
Spiritus innumeris finem posuisse querelis.
Torquato Tasso, fratello nello spirito al Petrarca, farà suoi questi lamenti:
Ohimè dal dì che pria
Trassi l’aure vitali, e i lumi apersi
In questa luce a me non mai serena,
Fui de l’ingiusta e ria
Trastullo e segno, e di sua man soffersi
Piaghe che lunga età risalda appena.
Pare al Petrarca di vivere in perpetua irrequietudine, in un pelago iniquo; gli par che la Fortuna, volgendosi sull’instabil rota, di lui non curi, oppur curandolo l’insulti, lo ferisca mortalmente per ogni dove, gli trafigga l’anima; gli pare un brutto carcere la sua terrena dimora, una buia casa di lutto; dice che gli sono negati tutti i piaceri, che ha esperimentati tutti i mali. “Qual Dio regge il mio destino,” si chiede, “chi volge per me stelle sì avverse?” (Quis agit mea fata Deus – quis sidera volvit Noxia?). La vita è un letto “disagiato e duro” per il Leopardi, per il Petrarca è un letto duro, iniquo, immondo, spinoso, tale da fiaccar le membra più sane. Ad altri, sofferenti e pazienti di tutto, può avvenire di porvisi morbidamente a giacere, riposati e contenti, lui non ci trova che perpetua molestia. Dall’amore, poi, ha tutte le torture, battaglia ben più “forte e aspra e dura” di quella deplorata da Dino Frescobaldi. Di tanti infelici è lui il più misero. La stanca vecchierella pellegrina, l’avaro zappatore, il pastore, i naviganti, i buoi persino, riposano la sera dopo le fatiche sofferte, obliano “la noia e il mal della passata vita.” Lui non ha pace nè riposo, nè di giorno nè di notte; il dolor lo strugge senza tregua. Mancandogli le sciagure reali, egli tutte se le crea nell’imaginazione accesa, perchè se ne dolga e ne faccia il suo pascolo abituale. Cammina per rosei sentieri ed egli, non vi spiegate come, ne ritrae insanguinato il piede. Il lamento gli è condizione di vita. Dal fondo del cuore, mentre sta per esultare, una voce gli grida: Reprimi la gioia, tu sei nato al dolore. Ogni festa della vita è larva fugace. Ogni fortuna tua è illusoria. – È un perpetuo dissidio entro di lui, un tumultuare di contrarie aspirazioni, e se il fisico regge, non regge lo spirito. Il sentimento scoppia, trabocca. E le presenti cose e le passate e le future ancora gli daranno guerra. E che sarebbe stato di lui se alle procelle suscitategli dall’animo suo, si fossero aggiunte le procelle del mondo esteriore, se gli fosse toccata in sorte la deformità fisica del Leopardi o la severità e rigidezza di una madre, l’obbligata dimora e quasi prigionia di Recanati, o la povertà, l’esilio di Dante, o altre sciagure ancor peggiori? “A gran torto mi doglio,” esce a dire una volta, ma è sì presto soffocata questa debol voce della coscienza. La fortuna, che infelice nol volle pei casi esterni della vita, gli acuì il sentimento del dolore, lo rese incapace d’ogni vero godimento. Godeva così a sbalzi, a piccole, fugaci intermittenze, sminuzzando tutti i piaceri, rifacendosi altri fantasmi sulle rovine de’ suoi ameni inganni. “Nè mai stato gioioso | amore o la volubile Fortuna | dieder a chi più für nel mondo amici, | ch’i’ no’l cangiassi ad una rivolta d’occhi.” Godeva, quasi per ripigliar forza a nuovamente addolorarsi e per assaporar meglio i disinganni suoi. Artista più raffinato di lui nel crearsi tutte le possibili ed imaginabili diminuzioni del piacere, non fu certo in Italia e appena l’eguaglia il Leopardi. Se tu sei ora felice, pensava, passerà quest’istante, verrà tempo in cui ti sarà amaro, crudo il ricordo della passata felicità. Così turbava, distruggeva quel suo simulacro di godimento e, anticipando il futuro, ripeteva mentalmente il “Nessun maggior dolore” di Francesca. T’aspettano cose liete per l’avvenire. Ma chi può dire gli ostacoli che si frapporranno al pensier tuo. Considera “la pena dell’aspettazione, affannosa quant’altra mai, e la diminuzione del piacere che, anticipatamente delibato e sfiorato, illanguidisce e si consuma già prima di giungere, per il desiderio e la speranza.” Sognatevi, poveri mortali, la vostra felicità e raddolcitevi con questa chimera la vita. Non v’ha gioia che i flutti del tempo non travolgano, non v’ha piacere dove non vi si annidi il dolore, non v’ha speranza senza trepidazione e timore.
*
* *
V’è una piaga nell’anima del Petrarca alla quale tutti i rimedi si applicano e tutti i rimedi, come impotenti, si rigettano. Si confessa lui medesimo malato, persino febbricitante. Ammalato, frale di forze, sbattuto qua e là ognora dall’onde infide dell’animo proprio, vive in tempi di sfrenata, indomita energia. È un’anomalia nel medio evo cadente. Aspira alla pace, alla tranquillità, alla serenità suprema, e trova eterna guerra; si affissa nelle luci paradisiache, ma subito ritrae l’occhio affranto e si sgomenta della tempesta che gli regge in cuore. Sempre fra terra e cielo, e di fibra sì delicata, sì tenera! Sono in lui due coscienze, due ideali, due mondi opposti tra loro, ed è follia voler conciliarli. La lotta dell’animo forte ci darebbe la tragedia, la lotta del Petrarca ci dà l’elegia. Spossato, diffida di sè medesimo, de’ suoi propositi, delle sue speranze, non vi sarà chi lo liberi dall’interno conflitto. Come il Tasso, che sì “intempestivo senso” ebbe agli affanni, come gli illustri malati de’ tempi moderni, sentirà immenso il distacco tra il pensiero e l’azione, tra il volere e il potere. “Con la morte allato | cerco del viver mio novo consiglio, | e veggio il meglio, ed al peggior m’appiglio.” Non avrà la visione netta di ciò che è bene e ciò che è male; ogni sua indecisione gli sarà fonte di nuove amarezze, di nuovi fastidi e lamenti. (Sentio inexpletum quoddam in praecordiis meis semper).
Simili nature sono presto lanciate fuori dal mondo reale, per farvi rapidi e dolorosi ritorni, costrette ad improvvisare nell’imaginazione un mondo fittizio ed a riporvi tutti gli affetti e le sensazioni che naufragarono nell’altro. Effonderanno quivi la loro anima tenera e con l’alternare di nuovi inganni inganneranno la vita. Togliete al Petrarca questo mondo e toglierete il pregio, l’incanto maggiore della sua lirica. D’altronde, o realtà o sogno, che importa? È un soffio la vita. Nell’al di là, che tutti ne aspetta, tutto si dissolve. Noi vedremo il poeta trasportarsi sulle ali rapide della fantasia, in quella re...