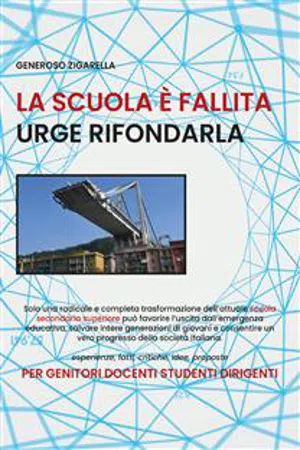![]()
Capitolo 1/I
UN SISTEMA INUTILE E DISEDUCATIVO
CAUSA DI CORRUZIONE, DI DEGRADO MORALE
E DI DISUGUAGLIANZA
L’educazione è l’arma più potente
per cambiare il mondo
Nelson Mandela
So bene che esistono nella scuola secondaria superiore italiana docenti seri e bravi e studenti altrettanto seri e bravi. Ma questo non basta a coprire la sua grave e generale crisi, a nascondere l’emergenza educativa della quale hanno pure parlato con preoccupazione varie autorità morali ed istituzionali, ad oscurare giudizi negativi formulati da qualificati organismi internazionali, a distrarre dalla sofferta e preoccupata percezione negativa che ne hanno le famiglie italiane. Né si può impedire a chi nella scuola ha lungamente e variamente operato di rappresentarne profili e contesti poco edificanti, che, come tali, sono spesso oscurati da una retorica interessata e corporativa. Anzi solo una completa e realistica rappresentazione dell’attuale situazione della scuola italiana può ancora consentirne la salvezza, al fine di renderla davvero utile ai giovani ed a tutta la società italiana.
Con questo libro vorrei tentare di rappresentare la vera scuola secondaria superiore italiana, della quale non si parla o, per meglio dire, è difficile anche parlarne. A tal fine proverò ad immaginare una passeggiata dentro una serie di fatti, di notizie, di regole, di norme, di leggi, di disposizioni, di direttive, di circolari, di prassi, di comportamenti, di esperienze e di attività, guardandoli e giudicandoli soprattutto per la loro inutilità e ricaduta educativa, o diseducativa.
In realtà la scuola secondaria superiore italiana sembra un’auto di grossa cilindrata col motore sempre acceso e col cambio sempre a folle; consuma tanta benzina, fa anche tanto rumore, ma è sempre ferma.
Ma c’è di più; si potrebbe pensare che, così come una macchina ferma col motore acceso, consuma, sì, benzina ma alla fine non produce danni, non consuma le ruote, non fa incidenti stradali, non ammazza nessuno, anche la scuola secondaria superiore italiana consuma, sì, ricchezza, ma non produce danni, se non quello dello spreco. No, non è così, perché quella macchina ferma, che consuma tanti soldi, produce anche tanti tanti danni, alla cultura, alla morale, alla dignità dell’intero corpo sociale. La corruzione, che sempre più dilaga in questo paese Italia, è anche e, forse, soprattutto conseguenza dell’inarrestabile processo di decadimento della scuola, della scuola secondaria superiore in primo luogo.
La corruzione nel mondo professionale, nel mondo imprenditoriale, nel mondo giudiziario, nel mondo burocratico, nel mondo militare e della sicurezza è, sì, conseguenza di soggettive ed individuali deviazioni dai valori etici fondamentali, ma è anche e soprattutto conseguenza della mancata educazione ai valori morali e civili, che si acquisiscono nell’adolescenza nei banchi di scuola, e della mancata acquisizione di adeguata cultura e professionalità, cui, nella competizione della vita, si cerca alla fine di sopperire con mezzi illeciti e non ortodossi.
Se un medico, un ingegnere, un imprenditore è consapevole di possedere le capacità e le competenze che gli fanno meritare, senza aggiunte e senza ingerenze, un incarico o un riconoscimento, non ricorre a sistemi oscuri ed illeciti; egli difende i propri diritti fino a denunziare quanti illecitamente li contrastano, fino a svolgere, insieme alla sua professione, anche una più generale funzione morale e civile.
Così la scuola, che pur dovrebbe essere strumento per affermare uguaglianza sociale, è essa stessa causa di maggiori disuguaglianze.
Secondo l’OCSE- Pisa, che ha esaminato i dati della stagione 2014-2015, “più di 150 punti separano la valutazione media del 25 per cento più bravo dal punteggio raggiunto dal 25 per cento più svantaggiato”. “La metà degli studenti meno abbienti frequenta il 25 per cento delle scuole più svantaggiate del Paese.” “Solo il 6 per cento viene iscritto negli istituti prestigiosi”. L'OCSE lo chiama "livello di segregazione". “La percentuale di studenti svantaggiati, che dichiara di "sentirsi nel suo ambiente" a scuola, è diminuita, tra il 2003 e il 2015, dall'85 per cento al 64 per cento”.
![]()
Capitolo 2/I
-LA “BUONA SCUOLA“ -
SOLO UN ACCANIMENTO TERAPEUTICO SENZA DIAGNOSI
Tutti coloro che sono incapaci di
imparare, si sono messi ad insegnare
Oscar Wilde
Che la cosiddetta riforma della buona scuola sia stato un fallimento, tanto che non solo non ha cambiato in meglio la scuola italiana ma l’ha addirittura peggiorata mi sembra che sia un dato ormai largamente condiviso sia dagli operatori scolastici sia dalla più generale opinione pubblica. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fu promotore e sostenitore, la ha annoverata tra gli errori del suo Governo.
A questo punto si potrebbe dire: evviva la sincerità. Potrebbe addirittura significare che, stante buona fede ed onestà intellettuale dei nostri governanti, prima o poi ci sarà un’altra riforma che, finalmente, farà uscire la scuola italiana, soprattutto superiore, dalla crisi e la farà assurgere ai più alti livelli della cultura mondiale.
Eppure, sono convinto che, fino a quando un’analisi, vera e severa, della scuola italiana continuerà ad essere carente, se non addirittura assente, così come lo è stato per tutte le riforme, che, tutt’altro che poche, pur si sono succedute negli ultimi decenni, qualsiasi riforma sarà priva di effetti migliorativi; anzi peggiorerà sempre di più, proprio come avvenuto con la “buona scuola”.
E ciò me lo fa temere non solo il contesto istituzionale, organizzativo ed amministrativo della vigente “buona scuola”, ma anche lo stesso contesto politico-culturale che ad esso si oppone, tanto è carente di analisi e concreta conoscenza del mondo scolastico italiano.
La “buona scuola” ha sostanzialmente richiamato, sin nell’oggetto e nelle finalità, quanto già nel 1999 venne previsto dal Decreto del Presidente della repubblica n.275, giustamente all’epoca definito come decreto sull’autonomia scolastica. A mio parere l’attuale legge della buona scuola provvede, ora, a meglio precisare di quella riforma, in sostanza, soprattutto alcuni specifici percorsi formativi ed organizzativi.
Quella riforma del 1999, però, è stata in tutti gli anni successivi, gattopardescamente, tradita, boicottata e violata proprio da chi, per dovere politico ed istituzionale, avrebbe dovuto attuarla. Basta chiedersi, ora, come e perché sia avvenuto tutto ciò, per capire che, per la scuola italiana, non bastava né basta affermare, finanche con una legge del Parlamento, dei pur giusti obiettivi e principi per poterli attuare.
Se chi ha elaborato la buona scuola avesse cercato di capire cause, moventi, interessi e responsabili del già consumato delitto rispetto alla riforma del 1999, non avrebbe sottoposto la scuola italiana ad un ulteriore inutile stress, che, proprio come avviene per un malato terminale quando gli si somministrano cure sbagliate, ha finito per ulteriormente indebolirla. Anzi forse è il caso di riconoscere alla ”buona scuola” proprio il merito di avere ulteriormente dimostrato, ancora meglio e di più, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che è possibile costruire in Italia una scuola vera e moderna soltanto se si smantellano radicalmente vecchi, inutili ed illegittimi apparati di potere e di privilegi, che non si sono mai chiesto che cosa dovevano fare per la scuola, come pur era loro unico ed esclusivo dovere, ma che sono stati mossi soltanto da ciò che la scuola poteva fare per loro.
![]()
Capitolo 3/I
DALL’OCSE-PISA I DATI DI UN DISASTRO
Se gravi ed inquietanti, perciò, sono i dati PISA-OCSE, ancor di più lo sono i commenti e le prese di posizione che ne sono seguiti, sia da parte dei vari responsabili istituzionali, sia da parte del mondo mediatico ed intellettuale, che cerca di soffermarsi più sui “distinguo” dei commenti che sulla gravità dei dati.
Che la scuola italiana fosse, da tempo, caratterizzata da una grave crisi di credibilità e di fiducia è non solo largamente avvertito e condiviso da gran parte della società, ma anche misurato e confermato da varie indagini di enti pubblici e privati, tra le quali soprattutto quelle effettuate dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con vari programmi PISA (Programme for International Student Assessment) . Queste indagini mirano a valutare soprattutto la capacità di adolescenti scolarizzati di utilizzare conoscenze ed abilità, apprese anche e soprattutto a scuola, per affrontare problemi e compiti analoghi a quelli che si possono incontrare nella vita reale. Tali indagini, periodicamente effettuate e pubblicate dal 2000 ad oggi, costantemente confermano che le prestazioni e le competenze degli studenti italiani nella lettura, nelle scienze e nella matematica raggiungono sempre un punteggio medio costantemente al di sotto della media internazionale, tanto da collocare la scuola italiana al di sotto di nazioni, che, come Hong Kong, la Corea del Sud, la Finlandia, la Germania ed i Paesi Bassi, occupano i primi posti della classifica, ed anche al di sotto di varie altre nazioni quali l’ Estonia, la Nuova Zelanda, la Polonia. Per le competenze matematiche, ad esempio, rilevate da un’indagine effettuata tra gli anni che vanno dal 2000 al 2010, l’Italia occupava il 31° posto su 40 paesi esaminati, presentando un 18,7% di studenti che si collocavano al livello 1 (quello più basso) ed un 13,2% che non raggiungevano neanche questo livello 1, ossia che non riuscivano a rispondere neanche ai più semplici quesiti dell’indagine. Addirittura, dalla ricerca emergeva che il 50,9% degli studenti italiani non sarebbe in grado di capire neppure il minimo di un brano di lettura che gli venisse sottoposto.
Il Ministro dell’Istruzione dell’epoca, richiamando quei dati, così dichiarava il 10 giugno 2008 nella commissione cultura della Camera dei Deputati: Nelle comparazioni internazionali i nostri studenti risultano tra i più impreparati d’Europa. Le indagini OCSE-PISA, che misurano le competenze in ambito matematico e scientifico, la capacità di lettura e di soluzione dei problemi da parte dei quindicenni, collocano l’Italia ai livelli più bassi della classifica… Negli ultimi sei anni siamo scivolati ...