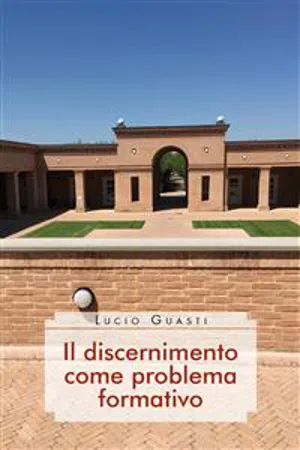![]()
Qualche reazione agli stimoli
1. La formazione e gli “esercizi spirituali”
Sono stato a Roma per partecipare al convegno “Spiritualità Ignaziana e metodo trascendentale in Bernard Lonergan” 4. Ho ascoltato i relatori, tra i quali Robert Doran, considerato il più raffinato studioso di Lonergan. Quando, nel momento delle domande, ho chiesto ai relatori e a Doran, in particolare, perché Lonergan non avesse sviluppato una riflessione sugli “Esercizi spirituali” analoga o diversa da quella di Ignazio di Loyola, lui mi rispose in modo sintetico e asciutto: “Insight”. Non ha aggiunto altro e mi ha fissato con aria sicura, come qualcuno che afferma una certezza senza esitazione di sorta. Poi, a fine incontro, nel momento del saluto, gli ho detto che ero d’accordo con lui, ma che avevo l’impressione che gli esercizi fossero stati pensati per i religiosi; lui mi rispose ancora sinteticamente: “per i cristiani”.
Ha così indicato in Insight 5, trattato che non è certamente nato con questo scopo, il nuovo testo base di futuri esercizi spirituali, quasi a dire che è su questo documento che se ne può impostare una nuova forma. Lonergan non lo dice espressamente, ma Insight è rivolto a tutti non solo ai teologi cristiani, è un testo di teoria della conoscenza che tutti possono applicare alla propria vita. La finale conversione religiosa può non esserci; i temi trattati sono molto più ampi di una proposta cognitiva perché riguardano la coscienza individuale e collettiva dell’uomo e della sua umanità.
In sostanza, si tratta di affrontare il tema da due angolature: Insight per i soli cristiani o Insight per tutti gli uomini, esercizi per i cristiano-cattolici o invece per tutti? Si può anche operare un’altra distinzione: gli esercizi per i religiosi e gli esercizi per i laici cristiani. Oppure una forma di esercizi per i laici cristiani e per i laici non cristiani. Si può pensare che ci possano essere differenze, modelli diversi e che la nuova evangelizzazione possa anche passare attraverso la soluzione di questi problemi?
Un argomento che merita una riflessione potrebbe essere calibrato primariamente sul laicato e indicare una forma di ‘esercizi’, più o meno lonerganiani, per i laici. Credo che si possa ormai pensare a esercizi per laici e ad esercizi per religiosi. Non ad esercizi per religiosi che poi diventano una forma ridotta per i laici. I famosi tre giorni di esercizi che vengono proposti ai laici si presentano come una specie di “Bignami” spirituale di origine ignaziana.
L’effetto della cultura presente negli “esercizi spirituali” di Ignazio è presente anche nella visione metodologica del discernimento. Anzi, si può dire che il discernimento ha la sua logica formativa nella struttura degli esercizi ignaziani. Pertanto risulta evidente che la maggior parte dei sostenitori del metodo proposto da papa Francesco siano i gesuiti ed è anche evidente che ciò che si dice degli esercizi valga anche per il discernimento.
Intanto definisco il discernimento un metodo generale o, se non ci si vuole impegnare con una definizione, un approccio generale ad un modello di formazione. Riguardo al discernimento vanno stabiliti due rapporti: uno verso gli “esercizi spirituali” e Insight, l’altro verso il MEG: Metodo Empirico Generale o, come all’origine, al MET: Metodo Empirico Trascendentale.
2. Complessità culturale e discernimento
Esiste ormai un’evidente complessità culturale nella nostra società ma, anche nella chiesa, ci troviamo di fronte allo stesso fenomeno. Si pone il problema di come sia possibile coinvolgere i fedeli praticanti nella conoscenza e nel possesso di questi elementi. C’è, di fatto, un’impossibilità di coinvolgimento della base dei credenti in questo mondo di nuove conoscenze; esiste un problema pastorale che non riguarda il messaggio ma le interpretazioni che se ne possono dare in relazione alla sua collocazione nelle dinamiche antropologiche e sociali di oggi in vista del futuro.
L'espressione “interpretazione infinita” di Pasquale Giustiniani è emblematica 6 , esprime bene la situazione, ma anche la complessità del disegno: “Così procedendo dalle intellezioni illustrative alla intellezione nell’intellezione, <dalla struttura conosciuta del proprio conoscere> sarà possibile derivare sia una metafisica che un’etica: <come dalla struttura conosciuta del proprio conoscere viene derivata una metafisica, così dalla conoscenza della struttura composita del proprio conoscere e fare risulta un’etica>. (58) E ancora: “Conoscere intelligibilmente l’essere proporzionato all’intelletto umano, non garantisce, insomma, un fare che sarà attuato in coerenza con esso. Si dà, cioè, pur sempre l’eventualità, la <possibilità di incoerenza tra il conoscere e il fare umani” (65).
In presenza delle frammentazioni etiche contemporanee e anche di fronte alla teorizzazione di un relativismo morale inevitabile, l’affermazione che esista una <necessitante coerenza tra il conoscere e il fare del soggetto umano, appare interessante in presenza del magistero di “Papa Francesco che, pur nella riaffermazione di un’etica ontologica, cerchi di fare spazio al diverso peso esercitato dalla soggettività morale (…) dalle situazioni storico-culturali, rispetto ad una medesima oggettiva decisione malvagia o non coerente con il quadro etico-ontologico di riferimento”. (66)
In presenza di questa pluralità di orientamenti, mi chiedo se sia realmente possibile mettere l’ampia società dei credenti nella condizione di possedere lo strumento interpretativo per tutto ciò che si incontra nei diversi campi del sapere e dei comportamenti. E’ il momento di offrire al criterio dell’infinita interpretazione qualche strumento utile di supporto, oppure un diverso punto di vista.
Credo però che sia opportuno ricordare che proprio in questo periodo si sta assistendo ad una crescente critica della linea pastorale del Papa concentrata sulla tesi della non dogmaticità formale delle sue affermazioni perché collocate tutte nell’ambito di una pastorale distinta dalla fondazione dogmatica e aperta ad una diffusa antropologia frutto dell’esistenzialismo e dell’ermeneutica che conducono il pensiero cattolico verso forme di progressivo avvicinamento alle posizioni luterane. Mi riferisco in particolare alle tesi esposte in modo continuo e molto sistematico dal teologo Antonio Livi 7 il quale non ha nessun dubbio a classificare Kasper, Rahner, Marx, Ravasi, Martini, Paglia, Bianchi e altri fra gli eretici. Accumuna tutti nel campo ipotetico “dell’umanesimo ateo”.
Voglio ancora ricordare che Livi cita Lonergan 8 quando discute di “senso comune” e, in particolare, di Insight dichiarando di non condividere la sua posizione tesa a “dimostrare che il senso comune non svolge alcun ruolo nella ricerca della verità ma ha solo una funzione pratica nella vita ordinaria. In tal modo, pur riconoscendo al senso comune una qualche utilità (cfr 1.2.1), lo si svaluta dal punto di vista alettico 9 che è quello che più conta”.
3. Primato del metodo e discernimento
Sembra che il discernimento metta di fronte il campo culturale ecclesiale ad un primato del metodo; se non è un primato è una condizione procedurale: prima il metodo/discernimento. Se è un metodo, l’interrogativo operativo sarebbe il seguente: nei percorsi che si costruiscono, si deve ripetere un modello di metodo già elaborato o si deve inventare un metodo durante il processo? Si deve applicare un metodo o accettare più metodi, oppure si tratta di mettere ognuno nella condizione di “inventare” il suo metodo lungo il percorso? Quello di Lonergan è un modello metodologico che si presenta con due dimensioni: la prima è trascendentale e quindi stabile e definita ma comunque dinamica, mentre la seconda, quella che affronta concretamente le questioni della vita, è mobile, aperta, adattabile, ecc; questa potrebbe essere una base operativa e formativa ?
Se si legge il testo di Richard Liddy 10 sul come Bernard Lonergan ha cominciato a riflettere da giovane studente ed è giunto all’elaborazione della sua visione del metodo, occorre dire che ha sperimentato direttamente come si costruisce un disegno di conoscenza e di formazione. In questo disegno si ha l’indicazione di un metodo generale e l’individuazione di tutti gli elementi che sono necessari per dare corpo a tale modello; lui è giunto al risultato completo anche senza tutti gli elementi formali.
La conversione al trascendentale è frutto di una serie di operazioni concettuali che lo hanno portato a formulare la sua tesi. Ma, oggi, Lonergan chiederebbe di fare allo stesso modo, di attivarsi responsabilmente nella costruzione di percorsi metodologici per affrontare la realtà oppure direbbe di applicare il suo metodo? Ciò non varrebbe per il metodo generale ma solo per i metodi disciplinari? C’è evidentemente un rapporto che va preso in considerazione tra stabilità e mutamento, tra struttura e invenzione.
Se il discernimento fosse un metodo, di fatto si avrebbe, a questo punto, il primato del metodo; se invece è un atteggiamento generale allora si ha qualcosa di più globale e indefinito che lascia lo spazio ad un insieme di componenti a loro volta complesse.
4. Genesi di un’idea o di un dogma e discernimento
Nel racconto del periodo di formazione di Lonergan, Liddy riprende la storia di Agostino per mostrare come sia giunto alla conversione e alla costruzione della sua dottrina; l’affermazione del “peccato originale” è stata un punto di arrivo con conseguenze rilevantissime per la teologia e per tutta la storia successiva fino ai nostri giorni.
La conseguente domanda: quanto tempo e quale tempo ha impiegato per arrivare a questa conclusione e a quella conseguente riguardante la trasmissione di questo peccato mediante le forme della diffusione del seme generativo dell’uomo? E’ stata un’operazione di discernimento che ha prodotto il vero, cioè un risultato vero? Se non è vero, quali sono stati gli elementi che non hanno reso autentico quel processo di discernimento? E’ una storia che mette in primo piano il tema della complessità del discernimento.
Liddy riprende il tema e propone un interessante articolo di Lonergan pubblicato nel lontano 1943 quando si era ancora distanti dal Concilio Vaticano II 11.
La biologia contemporanea pensa diversamente da quella aristotelica e agostiniana e giunge a sostenere che ci sono due campi o due sistemi diversi che presiedono il rapporto tra fecondità e sessualità. Ed è la finalità, l’idea di finalità, che orienta alla visione della presenza di due percorsi, quello della generazione e quello della sessualità. Sulla base di questa distinzione, l’approccio formativo si presenta in modo molto diverso rispetto al passato. È Lonergan che affronta il tema e che sostiene la tesi della distinzione delle finalità.
L'argomento affrontato è molto interessante, merita una riflessione o, come si chiede adesso, un "discernment". Quifinality ha certamente il valore di "finalità" perché si riferisce alla visione dell'uomo e della sua logica ascendente, "ascendent" con relativi "levels" della persona (physical-chemical-biological, sensitive psychological, and intellectual), schema che corrisponde agli ordini stessi dell'amore umano "love": sexual attraction, friendship, human and divine love. Di conseguenza, rispetto al matrimonio, si ha una convergenza sul piano orizzontale dei livelli iniziali sia nella prima ascendenza (fisiologica) sia nella seconda (sessualità). Si ha così una "convergenza" - concomitantly - orizzontale e una "finalità" verticale. Ma la cosa più interessante da discutere viene ora: la finalità sta...