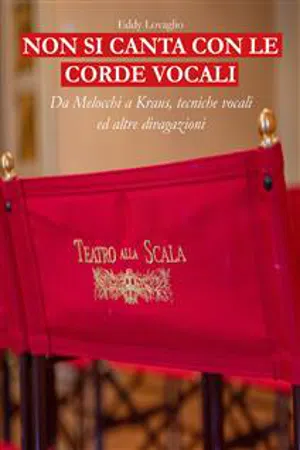![]()
ARTURO MELOCCHI
e la sua tecnica di canto
Arturo Melocchi, scomparso a Pesaro il 25 ottobre 1960, in condizioni economiche non buone, colpito da un male incurabile, viene seppellito nel cimitero di Pesaro, dove giace nel Tempio degli Illustri.
Era nato a Milano, ottant’anni prima, e aveva studiato pianoforte al Conservatorio della sua città dimostrando diligenza, profitto e doti di serio musicista.
Agli studi di pianoforte affiancò quelli di Armonia principale e di Contrappunto e fuga, per poi approdare alla classe di Canto che lo porterà fino al diploma di licenza e magistero conseguito il 13 novembre 1907 con una votazione eccellente, acquisendo così l’abilitazione all’insegnamento del Canto nelle Scuole pubbliche del Regno.
Durante la permanenza a Milano conseguì ulteriori competenze in materia di canto: frequentò, infatti, il corso di Laringoiatria all’Università degli Studi di Milano.
La sua voce è quella di baritono, ma un problema di eczema al naso gli crea problematiche respiratorie e gli impedisce di iniziare una promettente carriera di cantante lirico. Oltre a questa difficoltà, si va ad aggiungere anche una sua connaturata timidezza che – per sua stessa ammissione – si concretizza nella cosiddetta “paura del palcoscenico”. Queste difficoltà gli impediscono di intraprendere la carriera di cantante lirico ma facilitano il suo indirizzo verso l’insegnamento.
La definitiva sistemazione del Melocchi a Pesaro avvenne il 24 dicembre del 1911, a quei tempi l’attuale Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro era un Liceo musicale, fondato nel 1882 per volontà di Giochino Rossini stesso. Si trasformerà in Conservatorio solo nel 1940.
Fra gli allievi, che seguivano le sue lezioni, si costruì un’aurea mitica su “Arturo Melocchi e la sua tecnica di canto”, alimentata forse anche dalla grande fortuna artistica di alcuni dei suoi maggiori allievi: Mario Del Monaco, Franco Corelli, Gastone Limarilli, Gianfranco Cecchele, e solo per citarne alcuni.
Ogni voce ha le sue caratteristiche timbriche, e ogni epoca ha avuto determinate tipologie di canto preferiti ad altri, perciò è impossibile definire un metodo universale per l’apprendimento e l’esecuzione.
Il canto è come un bel vestito cucito da un bravo sarto: deve essere fatto su misura, sobrio ed elegante. Ma sono indispensabili il bravo sarto (l’insegnante) e la stoffa di qualità (la predisposizione e l’educazione dell’apparato fonatorio), oltre a chi lo indossa con eleganza (il bravo cantante), perché il bel vestito risulti tale.
Arturo Melocchi era senza dubbio un “sarto” d’eccezione, che sapeva valutare la qualità della “stoffa” e non si apprestava a “tagliare” l’abito se non era convinto di quel che aveva fra le mani. Questo ha contribuito a fargli ottenere una grande stima fra tutti i suoi allievi, oltre alla tecnica impartita, frutto dei suoi studi, delle sue conoscenze e competenze, non dimenticando che l’alchimia che passa tra maestro e allievo è qualcosa di impalpabile ma di indispensabile.
L’espressione acustica del canto viene percepita diversamente dal maestro, che la sente attraverso il suo apparato uditivo, e dall’allievo che canta, che la sente attraverso il suo orecchio interno.
Anche le sensazioni propriocettive che si hanno cantando sono ingannevoli ed estremamente soggettive, e quando il maestro le suggerisce all’allievo per facilitargli la comprensione di ciò che sta spiegando in realtà indica ciò che lui percepisce, che non è detto che corrisponda a quello che percepirà l’allievo. E tutto questo non sempre permette di risolvere il problema.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studenti di canto che su internet citano il “metodo Melocchi” come una panacea, un’eccellente soluzione per risolvere le loro difficoltà di voce. E, come accadeva ai tempi di Melocchi, molti altri intervengono per mettere in guardia i primi rispetto ai rischi che correrebbero le corde vocali con l’applicazione di tale metodo. Ciò è dovuto soprattutto al “fai da te”, alla sperimentazione di metodi e tecniche delle quali si è sentito parlare ma di cui non si conoscono bene le fondamenta e i dettagli.
Oggi parlare del “metodo Melocchi” è diventata una moda, un “mito”, ma quasi sempre lo si fa con poche conoscenze e con informazioni di terza mano. Proprio per questo è meglio fare chiarezza e approfondire l’argomento, capire in che cosa consiste la tecnica vocale insegnata dal M° Melocchi, analizzare quali obiettivi vantaggi e svantaggi può portare a chi la utilizza, valutare la sua attualità nel contesto delle conoscenze fisiologiche e tecniche odierne.
![]()
Arturo Melocchi e l’affondo
Melocchi in qualche modo raccoglie l’eredità di Enrico Caruso (1873-1921), il tenore verista per eccellenza, dalla voce grande, maschia, calda, con alle spalle uno studio ancora improntato a criteri ottocenteschi in quanto a tecnica vocale.
Negli stessi anni in cui Melocchi insegna a Pesaro iniziano a dilagare in tutt’Italia le scuole che sostengono la “tecnica dell’affondo”. Questo termine verrà utilizzato in epoche successive per designare un tipo di scuola di canto che trovava il suo fulcro d’attenzione sull’affondare il suono. Le caratteristiche di questo metodo sono lo sfruttamento delle piene potenzialità del diaframma, in quanto a gestione di una grande potenza di fiato, e la ricerca della massima larghezza possibile a livello della glottide. I cantanti che affondano hanno come obiettivo quello di ottenere una voce di grande volume e di grande espressività, che sia in grado di superare il “muro” dell’orchestra.
I meriti principali di Melocchi sono quelli di avere perfezionato la tecnica dell’affondo che spadroneggiava nei primi decenni del Novecento, facendo leva anche sulle conoscenze fisiologiche dell’apparato vocale derivategli dagli anni di studio in Laringoiatria, e di aver portato questa stessa tecnica al massimo grado di potenziale di utilizzo.
Il fatto poi di aver avuto come allievi cantanti illustri contribuì a creare attorno alla tecnica vocale che egli insegnava l’idea che si trattasse di un metodo innovativo e unico nel suo genere.
Possiamo affermare con certezza che Melocchi insegnava la sua tecnica per cantare principalmente opere veriste o romantiche, senza pretendere di impartire dettami belcantistici o barocchi. Tra i suoi allievi per la maggior parte, infatti, troviamo una tipologia vocale circoscritta: baritoni e tenori lirici, lirico spinti o drammatici; non troveremo mai un soprano leggero, soprattutto per il requisito fondamentale di “robustezza vocale” che serviva per affrontare gli esercizi che Melocchi assegnava.
Il suo metodo venne in ogni caso ostracizzato, sia durante gli anni di iniziale insegnamento, sia nei decenni seguenti, forse a causa proprio di quella “bel canto renaissance” e del conseguente alleggerimento delle voci o forse a causa della paura che la tecnica Melocchiana potesse arrivare a spaccare le gole.
Queste sono state accuse gratuite e infondate perché la tecnica di Melocchi non ha mai rovinato la voce a nessuno, anzi molti allievi hanno ricevuto il dono della longevità vocale proprio grazie al fatto che alla base ci fosse un grande allenamento muscolare.
![]()
L’importanza della conoscenza teorica dei meccanismi della fonazione e del canto
Uno dei meriti di Arturo Melocchi come didatta è sicuramente quello di aver posto i suoi allievi, fin dalla prima lezione di canto, di fronte alla consapevolezza del proprio organo vocale e del suo funzionamento. Dai racconti degli allievi sappiamo che Melocchi durante le sue lezioni parlava molto non solo del canto in generale ma anche della sua fisiologia, e illustrava con pluralità di esempi e spiegazioni la corretta emissione della voce.
La conoscenza della struttura anatomica e del fisiologico funzionamento del sistema respiratorio e fonatorio, sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista pratico, dovrebbe essere prioritariamente approfondita e discussa, possibilmente con l’impiego di disegni e animazioni, con il confronto tra atteggiamenti fonatori giusti ed errati e con l’utilizzo di esempi sonori, prima ancora dell’utilizzo di esercizi specifici.
Un altro problema inoltre è quello dell’orecchio. Tutti i cantanti sono abituati ad ascoltarsi con il proprio orecchio interno, le cui percezioni non sempre corrispondono a quelle di un orecchio esterno. Passo importante e molto delicato nell’apprendimento della tecnica è quindi anche quello di educare l’orecchio interno dell’allievo a riconoscere un suono giusto, e a sapere a quale risultato esterno corrisponda.
La tecnica vocale insegnata da Arturo Melocchi, da questo punto di vista, può essere considerata come un sistema ragionato, che doveva servire a creare negli allievi una consapevolezza fisica del canto non solo finalizzata all’emissione di suoni, vocalizzi, frasi, ma anche a riprodurre il tutto autonomamente rispetto alla presenza o meno dell’insegnante.
Questo aspetto non è da sottovalutare all’interno della preparazione di un cantante che si appresta ad una carriera. Saper imitare i suoni infatti è una cosa, saperli riprodurre in seguito a ragionamenti sul come questi vengano prodotti è un’altra cosa. Questo vuol dire sapersi gestire, avere tutte le carte in regola per affrontare un palcoscenico che come sappiamo è ricco di insidie per la voce.
Il corso di canto pesarese del Melocchi era diviso in due momenti: un corso inferiore di tre anni e uno superiore di due. Se leggiamo con attenzione il programma ci rendiamo conto che è presente una grossa disparità fra i primi tre anni di studio e gli ultimi due: se il corso inferiore è preposto ad una ferrea preparazione tecnica di base, quello superiore si occupa soprattutto di imbastire un repertorio, dopo aver ottenuto nel triennio precedente le congrue basi per destreggiarsi con un’aria d’opera (durante il quinto anno era previsto perfino lo studio di “almeno quattro opere teatrali”).
Addirittura notiamo che nel corso del triennio l’apprendimento del canto è diviso in una parte pratica e una parte teorica.
Primo anno: non c’è il minimo accenno ad un cantare con parole, Melocchi scrive solo di emissione del suono, di spiegazioni in merito all’apparato vocale (con spazio dedicato anche alla voce parlata e ai vari registri canori) e di raccolte di solfeggi cantati.
Secondo anno: incentrato principalmente sull’articolazione sillabica e sulla corretta pronuncia delle parole, da vocalizzi con semplici vocali all’introduzione di consonanti e di abbozzi di parole.
Terzo anno: la pratica comincia a includere solfeggi con parole e melodie, finalmente si arriva allo studio di alcune arie antiche; da notare, per quanto riguarda la teoria, l’insistenza ancora una volta sulla fisiologia dell’organo vocale e delle varie casse di risonanza, con relativo accenno all’igiene (cosa di assoluta importanza e troppo spesso ignorata), a fianco di un excursus sull’ultima parte dell’apparato fonatorio: lingua, palato, mascella.
Risulta evidente che Melocchi pretendeva dai suoi allievi, giustamente, un’attenta conoscenza del proprio strumento e di tutte le particolarità del suo utilizzo. Tra le righe il Maestro detta anche una grande lezione: non si arriva a cantare arie da subito, bensì dopo un percorso preparativo di alcuni anni, che risulta del tutto sovrapponibile agli anni di allenamento degli atleti sportivi, tutto incentrato sulla tecnica.
![]()
La fisiologia della respirazione in funzione del canto
La via più facile e logica per comprendere la tecnica di canto che fu insegnata da Arturo Melocchi è sicuramente quella che analizza la meccanica del processo fonatorio. A questo scopo è opportuno scindere il processo vocale nei suoi tre momenti salienti, che corrispondono ai tre apparati coinvolti nella fonazione, e cioè la respirazione, l’uso della laringe e delle corde vocali e l’uso delle risonanze alte.
Alla base di tutto troviamo certamente il fiato, cioè la colonna d’aria che dalle vie aeree inferiori, attraverso i bronchi e la trachea, raggiunge le vie aeree superiori per uscire poi all’esterno attraverso la bocca. E questo vale per tutti i cantanti. L’esempio per capire la fondamentale importanza di questo elemento è il funzionamento di un’automobile. Questa, infatti, sia essa una Cinquecento, sia essa una Ferrari, ha bisogno della benzina per muoversi. Analogamente il cantante, sia che abbia una voce piccola e leggera, sia che abbia una voce grande e potente, ha bisogno del fiato, e non può prescindere da un corretto uso e controllo di esso per la buona riuscita vocale.
L’uso e il controllo del fiato sono permessi dal sapiente utilizzo di alcuni muscoli semivolontari: tra essi soprattutto il diaframma, i muscoli intercostali e i muscoli addominali.
Durante l’inspirazione il diaframma, che separa orizzontalmente gli organi del torace da quelli dell’addome, si contrae e si abbassa, passando da un’iniziale forma a cupola a una forma piana. Con questo movimento si determina l’allargamento della base polmonare in senso latero-laterale e soprattutto postero-anteriore. L’azione del diaframma permette da sola l’entrata di più del 75% del volume dell’aria che penetra nella gabbia toracica, rimanendo il resto garantito dai muscoli intercostali esterni, intercartilaginei parasternali e, in misura minore, dai muscoli inspiratori accessori, come gli scaleni (anteriore, medio e posteriore, che sollevano e fissano le coste superiori) e gli sternocleidomastoidei (che sollevano lo sterno).
Possiamo quindi dire che la fase inspiratoria (che può essere volontaria se la persona vuole effettuare un’inspirazione più o meno profonda, oppure involontaria, se essa respira senza pensarci) è dovuta principalmente ad un attivo movimento di contrazione dei muscoli diaframma e intercostali esterni.
Anche la fase espiratoria può essere involontaria o volontaria. Nel primo caso sarà sufficiente il semplice rilasciamento dei muscoli diaframma e intercostali interni, unito al ritorno elastico del parenchima polmonare, e quindi della gabbia toracica, con una modesta componente di contrazione dei muscoli intercostali interni per ridurre il volume d’aria presente nelle vie aeree attraverso l’emissione del fiato.
Nel secondo caso sarà necessario e fondamentale il supporto attivo e volontario, più o meno vigoroso, della contrazione dei muscoli toracici (intercostali interni e sottocostali) e dei muscoli addominali (muscoli retti, obliqui esterni e interni, trasversi) per accelerare e/o rinforzare l’espirazione.
La fonazione, e dunque anche il canto, avvengono entrambi durante l’espirazione, nel momento in cui il diaframma si trova in fase passiva. L’attenzione maggiore per apprendere una buona tecnica di canto dovrà perciò essere rivolta in modo particolare a quei muscoli che governano la risalita del muscolo diaframmatico.
Occorre sottolineare che, da un punto di vista fisiologico, la corretta respirazione di un cantante deriva dall’equilibrio della messa in azione di muscolature antagoniste.
Lo scopo del cantante, ed in particolare del cantante lirico, è economizzare il più possibile il fiato per mantenere la colonna d’aria sufficiente alle necessità della frase musicale che sta eseguendo in quel momento.
Questo scopo è raggiunto tramite il controllo della pressione che l’aria contenuta nella trachea esercita sulle corde vocali, eliminando inutili sprechi e dannose forzature dei muscol...