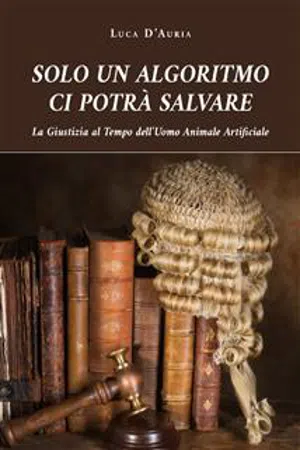
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Solo un algoritmo ci potrà salvare
Informazioni su questo libro
Il coronavirus ha sconvolto e cambiato il mondo intero. Non esiste Paese che non abbia dovuto fare i conti con il contagio e con il conseguente lockdown come unica forma di protezione contro la diffusione del virus.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Solo un algoritmo ci potrà salvare di Luca D'Auria in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Teoria e critica storica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
CAPITOLO VI
Lo scacco della giustizia.
Il bisogno di una filosofia della giustizia per restituire senso alla filosofia del diritto
Il bisogno di una filosofia della giustizia per restituire senso alla filosofia del diritto
La giustizia si realizza nella costante tensione tra due poli tra loro legati da una teleologia ontologica inscindibile: da un lato il diritto e dall’altro la sua applicazione, il fare giustizia o jusdicere. Non è immaginabile un diritto che produca norme e regole che non si declinino nella loro applicazione pratica (cioè il fare giustizia) e una giustizia che non sia lo specchio fedele della regola giuridica e a questa si riferisca. La moralità dell’operazione giudiziaria sta proprio nella piena affermazione e nella sintesi virtuosa di questa duplicità.76
È possibile affermare che il significato dell’una si estrinsechi nel significante dell’altre e, di converso, accada il contrario modificando il rapporto dialettico tra questi due formanti, cioè la legge (o diritto) e lo jusdicere (o pratica giudiziaria).77
Indubbiamente questa reciproca tensione tra l’operazione del fare giustizia e la legge astratta ha sempre rappresentato il terreno su cui fondare le scelte, anche tra loro radicalmente divergenti, di politica legislativa. Tutto quanto in uno sforzo progressivo volto a rendere il processo un luogo sempre più certo e sicuro rispetto al suo fine, cioè la ricerca di un vero aderente alla verità fenomenologica e reale, così da offrire alla collettività una clausola di fiducia verso le regole statuali e la loro applicazione.
Il panorama delle scelte di politica legislativa che si sono susseguite nei secoli è quanto mai variegato e segna la storia della cultura Occidentale e della filosofia del diritto nelle diverse epoche. Tradizionalmente l’evoluzione giuridica – in specie con riferimento al processo penale – è stata tutta tesa a migliorare la forma dell’accertamento, con ciò intendendo le regole che disciplinano il procedimento positivo per giungere alla verità (e, di conseguenza, alla dichiarazione di colpevolezza o innocenza dell’accusato). Si è passati dall’ordalia - o giudizio di Dio - al processo inquisitorio, per approdare a quello misto, sino all’avvento del modello accusatorio in cui il giudicante può essere incarnato da giudici togati o da una giuria di laici. Da qualche decennio, l’avvento della tecnica e il suo uso sempre più massiccio in ogni ambito sociale, ha trasferito la scommessa per un processo giusto dal campo della forma procedimentale alla prova. Con accenti differenti nei vari ordinamenti si è così avuta una vera e propria conquista del terreno dell’accertamento processuale da parte della categoria definita delle prove tecniche o scientifiche, di cui il DNA esprime il prototipo più dirompente e fortunato e questo per il principio scientifico ad esso sotteso e cioè il fatto che il codice genetico sia una sorta di targa personalissima e unica per ogni essere vivente.78
Nonostante questi avvicendamenti strutturali e culturali nel rapporto tra diritto e giustizia applicata, appare ancora irrisolvibile il grande tema circa i fondamenti della certezza del decidere e dunque della concreta ed effettiva possibilità di realizzazione della declinazione processuale del principio del libero arbitrio che porta il nome di libero convincimento del giudice.79
Nessuno ha saputo meglio esprimere questa incertezza gnoseologica del fare giustizia di un noto magistrato che ha dichiarato: “c’è un’abissale differenza tra i motivi di una decisione e la motivazione di una decisione. La motivazione è una spiegazione razionale messa per iscritto. I motivi stanno nella testa del giudice e non li conoscerà mai nessuno”.80
Questa limpida affermazione, valida per ogni decisore umano, porta in medias res tutta la drammaticità del rapporto tra diritto astratto e giustizia applicata, imponendo una riflessione profonda sulla reale possibilità che questi due poli della dialettica giudiziaria riescano realmente a compenetrarsi come dovrebbero, assicurando che la legge e la regola siano le guide finali dello jusdicere e che quest’ultimo “si pieghi” ai desiderata del diritto.81
È dunque, quanto mai necessario, scrutinare le ragioni per le quali possa non realizzarsi, in ambito giudiziario, questa sinergia (proprio nel senso etimologico di syn energheia e dunque di potenza reciprocamente condivisa) anche qualora la norma giuridica positiva sia preveduta dall’ordinamento e questa sia chiara e netta. Peraltro, nell’ordinamento italiano, il giudice è un togato ed è dunque perfettamente conscio della necessità di adeguarsi alla previsione normativa. La prova di ciò risiede nella stesura della motivazione che è rigorosamente aderente al dettato normativo anche se, talvolta, è manifesta la complessità nel restituire il volere della regola al convincimento del giudice. La domanda finale sull’operazione giudiziaria è dunque il motivo per il quale il giudice possa scollegare le motivazioni dai motivi e cioè la regola giuridica dalla cognizione e dalla gnoseologia processuale.
Tale interrogativo non può che rimandare ad una serie di ulteriori questioni decisive: [i] se il sistema legislativo sia adeguato per assicurare che, sul fronte della sua applicazione, la legge possa effettivamente offrire un modello utile per assicurare la cognizione del giudicante; [ii] se l’opzione probatoria e cioè la scelta di affidarsi alla prova scientifica per risolvere il maggior numero delle controversie di giustizia criminale sia effettivamente una prospettiva efficiente; [iii] se la falla di sistema sia, piuttosto, da ravvisarsi aliunde rispetto al sistema delle regole giuridiche e della prova e cioè in qualche forma di carenza sul piano cognitivo del giudicante il quale, del tutto naturalmente e non per pregiudizio, potrebbe soffrire di condizionamenti cognitivi simili a quelli dell’uomo comune e, in parte, specifici della sua appartenenza allo jusdicere.82
Quanto alla prima questione: la filosofia del diritto ed in specie la sua branca processual-penalistica, ha avuto il merito di innovarsi nel corso dei secoli, passando, come accennato, da modelli a forte tasso di superstizione (la citata ordalia) a sistemi assai sofisticati costruiti intorno a forme di logica induttiva, deduttiva e abduttiva, che impongono al giudice percorsi cognitivi assai circostanziati in cui il libero convincimento è, di fatto, ingabbiato in uno statuto di regole fortemente deterministiche capaci di fare proprie le più adeguate norme dell’epistemologia scientifica.83
Certamente un confronto del modello delle garanzie tipiche del processo penale (come l’obbligo per l’accusa di esporre per prima le sue tesi mediante la formulazione del capo d’accusa e la proposizione delle prove a sostegno di questo, prima di ogni intervento della difesa) potrebbe far sobbalzare uno scienziato della cognizione in quanto, ciò che per il giurista rappresenta una garanzia etica del processo, verrebbe giudicato come un pericoloso pregiudizio gnoseologico per il giudice. A questo proposito deve essere evidenziato come le scienze della cognizione, come la psicologia cognitiva, considerano decisivo e determinante, in sede di apprendimento, l’ordine con il quale viene propalata una informazione. È un fatto indiscutibile che la prima fonte sia cognitivamente quasi indistruttibile e abbia una valenza assai superiore rispetto alle successive nella formazione delle reti neurali con riferimento a un determinato evento fenomenologico. Purtuttavia, a prescindere da futuribili riforme e utopistici revirements da parte dei giuristi, inattuali e assai complicati da veicolare nella cultura giuridica, è indubbio che il processo e la filosofia del diritto abbiano saputo modellare un sistema di regole che rappresenta una buona garanzia di tenuta della gnoseologia processuale.
Quanto alla seconda questione: anche la prova scientifica può non rappresentare una certezza e ciò in quanto la fonte probatoria può risultare inficiata da condizioni specifiche in grado di minarne la validità (in specie rispetto al principio che ne regge il fondamento). L’esempio offerto dalla prova del DNA è il più esemplificativo: nessun essere umano al mondo condivide con chiunque altro il proprio codice genetico ma la traccia di confronto (quella rinvenuta sul luogo del delitto, da compararsi con il DNA dell’indagato) può aver subito degradazioni, contaminazioni o altre forme di “infestazione” capaci di far scemare, anche grandemente, la reale portata dimostrativa dello strumento accertativo. Va inoltre detto che, usualmente, la prova scientifica, nella sistematica del codice, è classificabile come un indizio ed è dunque regolata dall’articolo 192 comma II del codice di rito.84 Questo sistema normativo esige dal giudice un ragionamento deterministico che è capace di ottemperare alla necessaria inferenza logica del dato indiziario.
La terza questione risulta invece decisiva per acclarare la verità circa l’impossibilità di assicurare una compatibilità cognitiva tra motivi e motivazione del giudicante.
Dopo aver dichiarato l’imputato colpevole o innocente, il giudice si trova chiuso nella propria coscienza e il sistema impone a costui di redigere una motivazione che deve rispecchiare le regole del processo. La possibilità dell’esistenza di uno scollamento tra motivi e motivazione vuole significare che l’intimo convincimento del giudice sia rispettoso delle regole di diritto e non sia piuttosto il prodotto di un cognitivo trascendentale che, solamente in seguito, al momento della redazione delle motivazioni, viene adeguato alle norme di legge (la ragion pura del diritto).85
È superfluo ripercorrere l’ampia dottrina filosofica capace di lumeggiare come il sapere umano sia un dato trascendentale ben lontano dalla logica pura della ragione. Di contro, la filosofia del diritto, ha sempre vissuto – illusoriamente - nella speranza dogmatica che la legge, quale forma di mente estesa, sia una granitica certezza sull’aderenza del cognitivo del togato alla norma di riferimento. Questa psicologia giuridica ingenua ha impedito il formarsi di una filosofia della giustizia capace di far dialogare la cognizione del giudice con l’astrattezza della legge.
Questo scacco culturale è la causa dello scollamento tra giustizia e diritto ed in specie tra motivi e motivazioni della sentenza.
Oggi è possibile coprire questa grave mancanza. Le scienze cognitive, la psicologia cognitiva e l’intelligenza artificiale possono concretamente accompagnare l’essere umano verso la forma migliore di giudizio e dettare i contenuti di una nuova filosofia, quella della giustizia. Al fine di intendere la necessità di aprire il campo a questa nuova filosofia è importante carpire alla radice il dato irrinunciabile di ogni ipotesi processuale possibile.
Per fare ciò è necessario “mettere tra parentesi” in senso husserliano ogni forma di ideologia sul processo e cogliere la coscienza pura dello jusdicere. In tal modo è agevole constatare come il giudicante non possa approcciarsi alla decisione al pari dell’uomo comune che può attingere ad ogni forma di libero convincimento, anche emotiva o trascendentale. La coscienza pura del processo è rappresentata, al contrario, proprio dalla norma messa originariamente in sospensione. Viene da aggiungere che la coscienza pura della giustizia non vede il prevalere di un sistema logico-giuridico sull’altro (l’inquisitorio rispetto a quello misto o l’accusatorio in relazione a quello misto). Il “tipo” di processo è frutto di una scelta di politica legislativa. Ciò che maggiormente conta è che la regola prestabilita venga applicata (si che si tratti del modello ordalico che di quello adversary all’americana). Con la conseguenza che la coscienza pura del processo, la sua riduzione eidetica e il suo “dono dei vincoli”, cioè la sua invarianza (da intendersi come l’insieme delle caratteristiche irrinunciabili) è proprio la regola ed il suo rispetto nello jusdicere.86 In poche parole: all’uomo comune è consentita ogni libertà di fare e di giudicare e la sua coscienza, personale o relazionale, può essere chiamata ad offrire esclusivamente dei riscontri o dei validi argomenti per essere ritenuta vera o adeguata. Il fare giustizia rimane, al contrario, è spoglio di libertà d’azione e il suo fare deve sottostare ai vincoli delle regole imposte dal diritto. Tuttavia, poiché la natura cognitiva umana è trascendentale e dunque tende a violare i limiti della ragione pura, è necessario istituire una disciplina (la filosofia della giustizia) che analizzi profondamente la forma gnoseologica, epistemica e cognitiva del fare giustizia al fine di trovare i rimedi più adeguati per far coincidere motivi e motivazione. Mutuando una terminologia kantiana è lecito affermare che, contro la dialettica trascendentale della cognizione giudiziaria è decisivo imporre al giudice la ragion pura giuridica.
Questo è possibile costruendo intorno al giudizio e per la fase del giudizio una filosofia forte come quella classica del diritto e della costruzione delle sue regole. La filosofia della giustizia deve assumere a piene mani le conoscenze della filosofia classica e rileggerle in chiave neuroscientifica e scientifico-cognitivista. Queste dottrine insegnano come il cervello sia un gigantesco costruttore di realtà esterne all’io, un fondatore di giudizi universali come prodotto della mera speculazione interiore o sociale e come il contesto di appartenenza del singolo cervello venga sfruttato dalla rete neurale umana per forgiare dei pattern così decisivi da divenire dei veri e propri totem cognitivi.
Questa nuova filosofia della ragione pratica giudiziaria trae la propria fonte costitutiva dalle svariate dottrine del sapere sull’intelletto umano ma anche, e specialmente, dalle più moderne scienze cognitive, che aprono la strada ad un uso massiccio dell’intelligenza artificiale quale forma di ancoraggio radicale della legge al fare giustizia.
In buona sostanza: la ragion pura del diritto deve trovare un proprio autonomo spazio esplicativo e teoretico all’interno di una costruzione culturale costruita sulla fase pratica del momento giudiziario. Diversamente il diritto e la sua evoluzione filosofica rischiano di rimanere un motore virtuale ed incapace di influenzare la ragione pratica, cioè lo jusdicere.
Solamente una filosofia della giustizia che sappia interagire proficuamente con la filosofia del diritto può rappresentare una via salvifica per garantire tale interazione. Kant è stato il primo pensatore a certificare come l’intelletto umano sia costruito per violare i limiti della ragion pura e acconsentire che il decidere cada “nell’abisso della ragione” del pensiero trascendentale. Prima di Kant era stato un filosofo e monaco irlandese a mettere in luce come la realtà sia il prodotto del cervello umano e ciò nel senso che l’oggettività delle cose non può avere un proprio statuto ontologico in quanto trattasi esclusivamente di un oggetto di attenzione ed elaborazione da parte della mente umana che ne forgia le caratteristiche in base alla mente di ciascuno.87 Più recentemente anche il filosofo di tradizione husserliana Merleau-Ponty ha proseguito, nel solco della tradizione del pensiero secondo cui l’io cogitans è determinante nella costruzione della grammatica del reale, sul modello di una rivelazione proustiana dell’interazione io-mondo, fondando la cognizione sul rapporto determinante tra la coscienza soggettiva e l’oggetto della speculazione, individuando un vero e proprio rapporto dialettico tra detti formanti capace di influenzare il risultato dell’operazione di conoscenza.88
Tutto ciò attribuisce un decisivo e determinante coté scientifico-filosofico capace di spiegare perchè vi sarebbe un radicale scollamento cognitivo tra motivi e motivazione nell’ambito della formazione della decisione giudiziaria.
Non è dunque più eludibile la scelta di aprire un campo di studi filosofici prettamente giudiziari che sia in grado di studiare, analizzare e preparare le soluzioni maggiormente adeguate ad assicurare che la fase dello jusdicere possa ritenersi protett...
Indice dei contenuti
- Cover
- Indice
- Frontespizio
- Copyright
- INTRODUZIONE
- CAPITOLO I
- CAPITOLO II
- CAPITOLO III
- CAPITOLO IV
- CAPITOLO V
- CAPITOLO VI
- CAPITOLO VII
- CAPITOLO VIII
- CAPITOLO IX