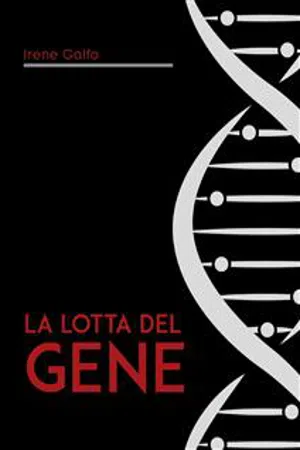![]()
Dawkins e il «gene egoista»
Noi siamo macchine da sopravvivenza – robot semoventi programmati ciecamente per preservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni.126
Ho incontrato la prima volta una citazione de Il gene egoista di Dawkins durante un periodo della mia carriera universitaria. L’opera non faceva parte del mio programma di studi ma, ugualmente, mi promisi di leggerla per la bibliografia della tesi di laurea specialistica. Desideravo presentare un lavoro attraversato dalla prospettiva genocentrica, dalla riconduzione dei vari fenomeni biologici complessi allo studio della funzionalità e operosità dei geni. Il tutto doveva inserirsi in una cornice darwiniana e mendeliana. Mendel e Darwin dovevano costituire i due pilastri, le due assi portanti, le due vie principali da cui si sarebbero diramate le vie successive, più o meno grandi, più o meno lunghe e larghe, ma anche vie isolate, distanti tra loro, vicoli ciechi, ramificazioni solide e altre ancora in via di costruzione.
Del saggio di Dawkins mi aveva colpito anzitutto il titolo, cioè l’associazione di una condotta umana, l’egoismo, a un dato della biologia, il gene. E il prosieguo: «La parte immortale di ogni essere vivente». In effetti mi chiedevo: chi non vorrebbe conoscere il mistero dell’immortalità? Se ci fosse, anche in minima parte, la possibilità di continuare a vivere in qualcosa o per mezzo di qualcosa, chi non sarebbe curioso di scovare quei canali che potrebbero accompagnare la nostra estensione nel tempo? Non conoscevo ancora il contenuto del testo ma, facendomi abbindolare, pensavo che esso riflettesse su qualcosa di simile a noi o di cui siamo fatti, qualcosa di eterno. I geni dovevano far parte di questa riflessione, accompagnati dallo sfondo della teoria della selezione, dell’evoluzione e dello sviluppo, ben ancorati nel contesto ambientale e dell’organismo biologico.
La biologia è una storia ricca di misteri. Gli animali sono le macchine più complicate e perfettamente disegnate dell’intero universo conosciuto.
Nella prefazione all’edizione del 1989 mi ha subito colpito questa parte:
La teoria del gene egoista è la teoria di Darwin, espressa in un modo che Darwin non utilizzò ma di cui mi piace pensare che avrebbe immediatamente riconosciuto e apprezzato l’adeguatezza. Si tratta di una derivazione logica del neodarwinismo ortodosso, espressa però da una prospettiva diversa: invece di concentrarsi sul singolo organismo, guarda la natura dal punto di vista del gene. È un diverso modo di vedere, non una teoria diversa.127
Dunque, lo stesso Dawkins ha interpretato la propria teoria come una variazione della teoria darwiniana, non una teoria diversa, ma una prospettiva ad essa contigua. E un nuovo modo di vedere può dare un contributo originale alla scienza.
Nel primo capitolo intitolato Perché esiste la gente? troviamo le tracce dei meriti darwiniani e alcune critiche ai modi tradizionali di studiare le materie umanistiche che prescindono dal riferimento darwiniano.
Oggi è molto difficile dubitare della teoria dell’evoluzione, ma purtroppo, spiega Dawkins Darwin non è interamente apprezzato e la filosofia e le materie umanistiche vengono ancora insegnate come se non fosse esistito. Lo studioso è comunque fiducioso e ritiene che senza dubbio questo stato di cose cambierà col tempo. Il suo scopo è quello di esaminare la biologia dell’egoismo e dell’altruismo. L’argomento basilare che ritorna più volte nel testo è che noi e tutti gli altri animali siamo macchine create dai nostri geni che sono sopravvissuti per milioni di anni in alcuni casi, sempre in competizione tra loro. La loro sopravvivenza nel tempo ci autorizza a pensare che questi geni dispongano di determinate qualità e una di queste è l’egoismo spietato che devono possedere se vogliono avere successo. Tale egoismo genetico indurrà un egoismo nell’individuo. Però vi sono casi speciali in cui un gene può ottenere i propri obiettivi egoistici favorendo una limitata forma di altruismo nei singoli animali.128
Ma quegli atti che apparentemente appaiono come altruistici, in realtà sono secondo Dawkins manifestazioni di un egoismo mascherato.
Vi è una spiegazione erronea dell’altruismo secondo cui l’evoluzione farebbe sì che le creature imparino ad agire per il bene della specie o del gruppo. Ma noi sappiamo che l’evoluzione lavora per selezione e la selezione porta alla sopravvivenza del più adatto, se non fosse così la creatura in questione inadatta a sopravvivere in determinate condizioni si estinguerebbe e con essa la propria specie. L’evoluzione è un processo cieco. Dawkins ci aiuta a guardare all’evoluzione come ad un processo che avviene al livello più basso possibile, cioè quello dei geni. L’unità fondamentale della selezione e dell’egoismo è il gene, ovvero l’unità dell’ereditarietà.129
Uno dei meriti fondamentali della teoria dell’evoluzione per selezione naturale è la sua capacità di spiegare come dalla semplicità si giunga alla complessità. All’inizio era tutto semplice, ogni cosa si componeva essenzialmente di semplicità. Probabilmente, spiega Dawkins, prima dell’inizio della vita sulla terra si è verificata un’evoluzione di molecole in seguito a processi chimico - fisici. Non dobbiamo necessariamente pensare ad uno scopo. Se un aggregato di atomi in presenza di energia assume una configurazione stabile, tenderà a permanere in questo stato. Così è probabile che ci sia stata una rudimentale forma di selezione naturale di forme stabili a discapito di forme instabili. Ad un certo punto della storia per caso si è formata una molecola particolarmente stabile, il replicatore. Questo avrebbe agito da stampo di se stesso, così avrebbe assicurato il suo protrarsi nel tempo e la sua proliferazione.130 Ma noi conosciamo anche la tendenza dei replicatori a commettere errori di copiatura. Pensiamo ad esempio agli amanuensi che si impegnavano nella trascrizione e copiatura di antichi testi. Essi commettevano degli errori trascrivendo a mano, e questi errori si tramandavano essendo a loro volta ricopiati da altri amanuensi e talvolta finivano per allontanarsi molto dalla forma originale del testo.
Ecco, anche i replicatori originari commisero certamente degli errori, così il «brodo primordiale» dovette popolarsi di forme numerose e variegate di molecole che si replicavano a loro volta e discendevano tutte dalla stessa molecola progenitrice. Alcune molecole erano più numerose di altre, perché più resistenti. Alla loro resistenza si legava di conseguenza anche la loro longevità. I replicatori a lunga vita tendevano a diventare più numerosi e si diffondeva una certa tendenza alla longevità. Altro fattore importante che caratterizzava tali replicatori o almeno alcuni di essi era la fecondità, cioè la capacità di questi ultimi a replicare se stessi in un tempo breve e veloce rispetto ad altri che si replicavano in tempi più lunghi. Questa velocità di replicazione avrebbe favorito la diffusione di una tendenza verso una maggiore fecondità. Altro fattore decisivo sottolineato più volte da Darwin fu la competizione. Il brodo primordiale popolato da diversi replicatori non poteva riempirsi all’infinito, così questi cominciarono a scontrarsi e a competere tra loro. Qualunque errore che avrebbe portato a un nuovo livello superiore di stabilità di un replicatore diminuendo quella degli altri, sarebbe stato conservato e moltiplicato. Questi replicatori hanno percorso un lunghissimo cammino e adesso sono noti sotto il nome di Dna e di geni e noi siamo le loro macchine da sopravvivenza, costruite nel modo migliore possibile per assicurare la loro permanenza e diffusione nel mondo.131
Le definizioni non sono sacre
È conveniente definire una parola nel modo che si adatta meglio ai nostri scopi.132
Secondo Dawkins non è facile e forse neanche necessario decidere dove finisce un gene e ne comincia un altro. Egli usa molte metafore nel riferimento al Dna, ad esempio con «volume» intende il cromosoma, con «pagina» il gene, e non ha scrupoli nell’asserire che non esiste alcun «architetto», in quanto le istruzioni del Dna per costruire i corpi si sono evolute per selezione naturale che è un processo casuale e alla cieca. Il Dna agisce in due modi fondamentali, replicandosi e operando da supervisore per la sintesi delle proteine. Queste a loro volta esercitano un controllo preciso su tutti i processi chimici che avvengono nelle cellule, attivandoli e bloccandoli al momento giusto. I geni controllano indirettamente la costruzione dei corpi. La costruzione di un corpo è un’impresa cooperativa. Un singolo gene avrà molti effetti diversi su parti diverse del corpo. Una data parte del corpo verrà influenzata da molti geni e l’effetto di un dato gene dipende dall’interazione con molti altri geni.
La riproduzione sessuale mescola i geni; la combinazione di geni ha vita breve, mentre i geni hanno una vita molto lunga. Un gene può essere considerato un’unità che sopravvive passando attraverso un gran numero di corpi successivi. Quando due geni sono in competizione tra loro per raggiungere un determinato punto nel cromosoma sono detti alleli l’uno dell’altro, cioè si tratta di geni opposti. Nel caso ad esempio del colore degli occhi, potremmo considerare il color marrone e quello azzurro, come l’uno allele dell’altro. Un gene che viene ignorato si chiamerà recessivo, mentre un gene che riuscirà ad imporsi verrà definito dominante. E di queste acquisizioni tutti noi ringraziamo Mendel.
Noi non abbiamo la possibilità di scegliere i nostri geni perché essi ci verranno consegnati alla nascita indipendentemente dalla nostra volontà. Il sesso mescola i geni. L’immagine che ci fornisce Dawkins per meglio comprendere questi meccanismi genetici è la metafora del raccoglitore. In particolare succede qualcosa di simile al distacco e all’interscambio di pagine da un raccoglitore.
Con Williams apprendiamo che un gene è definito come una qualunque porzione di materiale cromosomico che potenzialmente dura per un numero di generazioni sufficiente a servire da unità di selezione naturale.133 Un gene è un replicatore dotato di alta fedeltà di copiatura. Ma ritornando alla definizione di Williams, poniamoci la questione: quanto deve essere lunga questa porzione? Dawkins si sbarazza della questione dicendo che non deve interessarci la lunghezza di questa porzione, in quanto saperlo o meno non è pertinente ai nostri scopi. Piuttosto a noi interessa definire un’unità genetica come un tratto di cromosoma, fisicamente identico sotto tutti i punti di vista al resto del cromosoma. E dato che si discute di macchine che si caratterizzano con successo proprio per la loro capacità di adattamento e sopravvivenza, apprendiamo che più un’unità genetica è di minori dimensioni e porz...