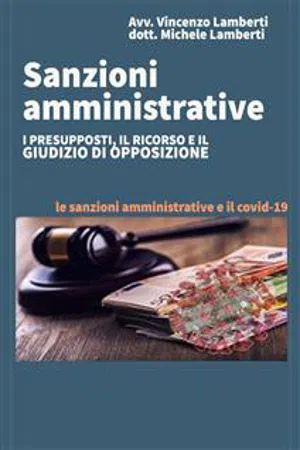![]()
Capitolo I
I presupposti generali per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
1.1 PREMESSA
In via generale per illecito amministrativo si intende la violazione di un qualsiasi comando o di un qualsiasi divieto, ovvero qualsiasi fatto che costituisca la trasgressione di una regola tale da diventare l’oggetto di una adeguata reazione dell’ordinamento, quale la potestà sanzionatoria.
A fronte di questa, generica, definizione dottrinale, a livello costituzionale l’articolo 28 Cost. propone una diversa definizione di illecito ritenendo tale gli atti compiuti in violazione di diritti, atti ai quali corrisponde una responsabilità secondo le leggi penali, civili ed amministrative.
Nel corso dell’ultimo secolo si è assistito sempre di più ad una differenziazione delle fonti che hanno dato origine ad una molteplicità di illeciti c.d. amministrativi. Da un lato vi è stata la creazione giuridica di illeciti ab origine di natura amministrativa. Dall’altro ad un vasto – e non ancora esaurito – processo di depenalizzazione, culminato nella necessità di approvare una legge specifica sul procedimento di applicazione e di esecuzione di sanzioni amministrative concentrato nella legge 689/81.
Né pare possibile, in questa sede, affondare l’analisi sulla distinzione ontologica tra illecito penale ed amministrativo. In realtà a livello teorico si ricordi che in dottrina generalmente si sostiene che la sanzione penale risponde alla ratio della tutela e dell’ordine pubblico o alla punizione del reo in chiave di prevenzione futura e deterrenza nella reiterazione di quello od altro illecito, mentre la sanzione amministrativa è funzionale e strumentale alla azione amministrativa, alla sua efficacia e alla sua effettività, una sorta di collegato indispensabile per assicurare effettività alla stessa attività amministrativa e al perseguimento del collegato interesse pubblico. Di sicuro interesse di consultazione si appalesa sul punto la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983, recante appunto criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative.
Per quanto di nostra competenza limitiamoci a ricordare che in termini oggettivi la sola distinzione che possiamo fare è quella relativa alla sanzione comminata dal legislatore, riconoscendosi così sanzioni penali, in caso di multa, ammenda, reclusione, ergastolo o arresto e sanzioni amministrative nel caso di comminazione del pagamento di una somma di denaro.
Al di là, della sopradescritta distinzione, le principali fonti degli illeciti amministrativi restano comunque la legge, quella speciale che va a disciplinare i singoli settori di pubblico interesse, ed i regolamenti, che, nei settori più disparati, sono promanati dalle autorità locali per disciplinare tutte le condotte a cui cittadini e imprese sono tenute ad uniformarsi. Il mancato rispetto delle norme ivi contenute comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria ivi contenuta.
Un esempio classico di una legge speciale che contiene illeciti amministrativi è dato dal Codice della Strada, Dlgs. 285/1992, che, dopo i numerosi interventi di depenalizzazione, ha condotto alla marginalizzazione della protezione penale. La stragrande maggioranza delle violazioni, infatti, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, se del caso corredate da un sostanzioso apparato di sanzioni accessorie. L’individuazione della tipologia di illecito, come detto intuitiva dalla semplice lettura delle sanzioni collegate alla violazione, condiziona la scelta degli atti da redigere nella immediatezza della violazione.
In presenza di una violazione amministrativa l’organo di polizia stradale procedente, ad esempio, ha il principale obbligo di contestare la violazione e redigere il verbale di contestazione, dando poi origine a un complesso procedimento sanzionatorio che proviamo a sintetizzare nel prosieguo.
Nella immediatezza, quindi il verbalizzante deve: individuare la violazione commessa; collegare ad essa il corretto apparato sanzionatorio previsto dal legislatore; porre in essere i comportamenti operativi richiesti nella immediatezza dal caso, secondo le indicazioni riportate nel riferimento normativo; identificare il trasgressore e, se presente, ogni altro obbligato in solido, tramite la lettura dei documenti di guida e circolazione o di eventuali documenti sostitutivi (ovvero tramite altre attività investigative in ipotesi di violazioni diverse da quelle stradali); redigere il verbale di contestazione seguendo le indicazioni di cui nel prosieguo; adottare le sanzioni accessorie previste e porre in essere le misure cautelari, interdittive o precautelari previste dal caso concreto. Ove invece il fatto commesso sia punito con sanzioni penali deve essere seguita la traccia descritta dal codice di procedura penale, sinteticamente riprodotta e richiamata nel capo II del Titolo VI del codice della strada, che assume una valenza del tutto indipendente e diversa rispetto alla procedura prevista per l’accertamento delle sanzioni amministrative. In termini operativi la differenza sostanziale consiste nel fatto che in queste ipotesi non deve essere effettuata alcuna contestazione dell’illecito, né deve essere redatto uno specifico verbale di contestazione. Né, quindi, deve essere effettuata alcuna notificazione al trasgressore o all’obbligato in solido di atti di contestazione o di accertamento. In queste ipotesi, ferma rimanendo l’adozione degli atti di polizia giudiziaria richiesti dal caso e l’immediata esecuzione di sanzioni accessorie collegate a ipotesi di reato o altri provvedimenti precautelari, interdittivi relativi al veicolo o ai documenti di circolazione e guida, l’agente verbalizzante segue la procedura descritta nell’articolo 220 del codice della strada che rinvia integralmente all’articolo 347 c.p.p. provvedendo a redigere la comunicazione di notizia di reato, da trasmettere al Pubblico Ministero senza ritardo.
Nella immediatezza l’operatore di polizia stradale che accerta un illecito previsto dal codice della strada punito con sanzioni penali deve, quindi, redigere tutti gli atti di P.G. previsti dal codice di procedura penale e funzionali al caso in esame.
Contestualmente l’ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale procedente provvede alla redazione della comunicazione di notizia di reato, atto riassuntivo delle operazioni eseguite recante la rappresentazione dei fatti e delle norme ritenute violate e la trasmette unitamente agli altri atti di polizia giudiziaria predisposti nell’immediatezza al Pubblico Ministero competente per territorio senza ritardo.
Si tenga presente che nel codice della strada non sono più presenti reati affidati alla competenza del giudice di pace. Per questi motivi gli atti devono essere trasmessi senza ritardo (ovvero entro 48 ore se si è proceduto con sequestro probatorio o preventivo, ovvero con atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) con comunicazione di notizia di reato e non entro quattro mesi con relazione ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 274/2000.
1.2 La legge 689 del 1981
La legge n. 689 del 19811, rubricata “Modifiche al sistema penale”, si compone di tre Capi, di cui quello d’interesse è il I, rubricato “le sanzioni amministrative”.
Quest’ultimo si compone di quattro sezioni, la Iª “principi generali”, la IIª “applicazione”, la IIIª “Depenalizzazione dei delitti e delle contravvenzioni”, la IVª recante disposizioni transitorie e finali”.
La L. n. 689/1981 ha definito i principi generali e il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle pecuniarie, prevedendo una disciplina simile a quella vigente nel diritto penale e stabilendo tra l’altro: la tassatività della fattispecie; l’irretroattività delle leggi che le prevedono.
I predetti principi di portata generale, se rispettati, conferiscono legittimità alla generalità delle sanzioni amministrative, sia che esse siano contenute all’interno di leggi speciali, sia che costituiscano la reazione dell’ordinamento locale alla violazione dei regolamenti comunali, provinciali e regionali. Si pensi ad esempio ai regolamenti in materia edilizia, a quelli di polizia mortuaria, a quelli infine per il conferimento dei rifiuti e la disciplina delle pubbliche affissioni su aree pubbliche. Si pensi ad esempio alle sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria. Con la legge 689/81 il legislatore si è voluto conferire dei limiti di portata generale attraverso i quali regolare e legittimare, secondo criteri univoci, il potere sanzionatorio in determinate materie che successivamente ha inteso esercitare sulla base di leggi e regolamenti, al fine di tutelare l’interesse pubblico e della collettività nonché, in taluni casi, per ripristinare l’ordine giuridico violato. I principi contenuti all’interno della legge di c.d. depenalizzazione sono stati mutuati e propri del diritto penale, anche se, come è stato ampiamente chiarito in premessa, la sanzione amministrativa, per scopi e modalità di estinzione, è completamente differente sia dal punto di vista ontologico che strutturale da quella penale. Tali principi generali costituiscono senz’altro il riferimento costante per tutti gli operatori impegnati nella complessa e delicata funzione di legalità e di sicurezza del territorio. Essi hanno un valore etico e giuridico, in grado di orientare l’operatore nella corretta applicazione delle norme violate, nel pieno rispetto delle prescrizioni procedurali. E sono queste che garantiscono diritti fondamentali, come l’esatta definizione dell’illecito, la necessità della contestazione immediata, l’obbligo di riportare nella verbalizzazione le dichiarazioni del trasgressore, i termini di notifica di natura perentoria, l’esatta indicazione delle modalità con le quali il trasgressore può estinguere il tutto e l’Autorità alla quale poter ricorrere.
L’analisi della legge 689/81 non può prescindere dall’esame di alcuni principi fondamentali. Il primo, senz’altro più importante, è quello di legalità che è contenuto all’interno dell’art. 1. Quando la norma statuisce che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione” e che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati”, mutua ed afferma un principio tipicamente penalistico che esprime un baluardo volto a garantire e tutelare la libertà delle persone. Tale principio garantisce inoltre che la Legge di cui ci si occupa sia legittima anche dal punto di vista costituzionale, atteso che l’art. 1 espressamente fa riferimento e rinvia al principio costituzionale di cui all’art. 25 comma 2 ovvero nullum crimen, nulla poena sine lege. L’estensione anche alle sanzioni amministrative del principio costituzionale, ex art. 25 comma 2, destinato ad applicarsi alle sole sanzioni penali non è stata però immediata, atteso che fin dagli anni 70 si apri un dibattito dottrinale sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 3 luglio 19672. La dottrina più rilevante, contrariamente a quanto affermato dai giudici di legittimità, non riteneva che il principio di cui all’art. 25 comma 2 fosse estensibile alle sanzioni amministrative in quanto il principio costituzionale era solo riferibile alle pene ed alle misure di sicurezza previste dal codice penale e quindi non era applicabile alle sanzioni amministrative. Per di più secondo l’autorevole dottrina, tale principio, anche per ragioni sistematiche, non poteva essere esteso agli illeciti amministrativi in quanto il costituente lo aveva previsto solo in riferimento a principi propri del diritto penale, quali ad esempio l’inviolabilità della libertà personale, l’applicazione delle misure di sicurezza, il principio del giudice naturale precostituito per legge e così via. Alla luce di tali spunti di riflessione, non sembrava possibile, perciò, procedere ad un inserimento della sanzione amministrativa in un quadro omogeneo e sistematico poiché ciò avrebbe potuto condurre a un affievolimento del livello di garanzia. Ma, seguentemente, la Corte Costituzionale, con numerosissimi arresti giurisprudenziali, è intervenuta più volte sulla questione dell’applicabilità dell’art. 25 comma 2 alle sanzioni amministrative ed ha chiarito che il predetto principio costituzionale può assumere parametro di riferimento anche per le stesse, atteso che la natura di una norma non dipende dalla qualificazione fornita dal legislatore quanto da criteri sostanziali.
Secondo la Corte, “le nuove sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni depenalizzate dovrebbero ritenersi, secondo il giudice a quo, >sanzioni di natura sostanzialmente penale, in quanto tali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 25, comma 2 Cost” (Cfr. Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 109, Pres. Grossi, Red. Zanon)3. Chiarito che dunque il principio di legalità contenuto all’interno della legge di depenalizzazione espressamente rinvia a quello costituzionale previsto per la sanzione penale, resta da affrontare il tema della irretroattività della sanzione amministrativa, posto che l’art. 1 comma 1 espressamente prevede in merito.
Per analogia, i principi della irretroattività della legge e quello del c.d. favour rei, dovrebbero applicarsi anche alla sanzione amministrativa. Ma tale passaggio non è stato così scontato, considerato che a tale conclusione si è pervenuti a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che si sono susseguiti a partire dagli anni 70. In prima analisi, occupandosi di confisca dei beni, la Corte chiariva che la stessa era da ritenersi una sanzione amministrativa e che “Per conseguenza essa non dà luogo a violazione del principio della irretroattività della legge penale”.
Successivamente la Corte Costituzionale aveva modo di chiarire la relazione tra la sanzione amministrativa e il principio di irretroattività statuendo che “il principio della irretroattività delle leggi è stato costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio stesso è rimessa alla prudente valutazione del legislatore”. Tale arresto era da ricollocarsi in ragione delle peculiarità della sanzione amministrativa e di quella penale, atteso che innanzitutto, trovavano il loro fondamento in differenti parametri costituzionali.
Secondo la Corte, mentre la sanzione penale trovava la sua origine negli artt. 25, comma 2 e 27 della Carta fondamentale, quella amministrativa era da ricondursi alla potestà sanzionatoria legittimata dagli artt. 23 e 97. Assume un rilievo fondamentale al fine di valutare se il principio di irretroattività della legge possa applicarsi anche alle sanzioni amministrative la lettura della Sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2010, laddove è stato statuito che “il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Principio questo, del resto, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale - data l’ampiezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito…») - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato”. Da tale arresto dunque emerge che le sanzioni amministrative possono essere applicate solo a fattispecie di violazione commesse dopo la loro entrata in vigore. Ed in sostanza perché anche per le sanzioni amministrative, vige, come chiarito in precedenza, il principio di legalità ex art. 25 comma 2 cost., al quale le stesse sono irrimediabilmente assoggettate.
Stante l’applicabilità dei principi di legalità e di irretroattività, un altro principio di rilevante importanza è contenuto all’interno dell’art. 8 laddove il legislatore si concentra su una fattispecie che potrebbe verificarsi allorquando il c.d. trasgressore con la medesima condotta o omissione viola diverse disposizioni oppure la medesima disposizione precettiva. Nel caso di specie, statuisce la norma, al trasgressore dovrà essere irrogata la sanzione amministrativa per la violazione più grave, che sarà aumentata sino al triplo. L’articolo teste enucleato riprende in sostanza il filo conduttore dei due precedenti principi, con la legge di depenalizzazione che in sostanza, anche in questa sede, ha mutuato, anche per le sanzioni amministrative, un principio proprio del diritto penale, qual è il concorso formale4. L’applicabilità di tale principio alle sanzioni amministrative ha comportato, però, problemi di carattere pratico e applicativo, atteso che, mentre nell’ambito del diritto penale, il concorso formale viene applicato sulla base di chiari riferimenti normativi, in tema di sanzioni amministrative la scelta spetta in concreto all’autorità competente all’irrogazione della sanzione. A differenza del procedimento penale e dell’univocità della contestazione di più reati in sede di concorso formale, nel caso di una o più condotte che hanno determinato la violazione di più precetti o del medesimo precetto più volte, l’autorità amministrativa dovrà avviare singole procedure sanzionatorie per ogni singola violazione accertata e commessa.
Infatti, considerato che per la corretta irrogazione delle sanzioni amministrative è previsto l’obbligo di contestazione quale condizione di procedibilità, è di tutta evidenza che, la violazione di più norme sostanziali comporterà l’attivazione di singoli procedimenti. Il concorso formale tra le sanzioni amministrative, a differenza del procedimento penale, non opererà dunque ex ante ma solo e residualmente ex post, considerato che lo stesso principio potrà operare solo se, in sede di ricorso dinanzi al giudice competente per materia, il trasgressore potrà richiedere l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Benché tra i principi cardine delle sanzioni amministrative, il concorso formale resta però un principio a cui di rado si fa ricorso in sede processuale, in quanto l’entità della sanzione risulterebbe così notevolmente più elevata di quanto ordinariamente previsto per il pagamento in misura ridotta delle singole sanzioni. L’incidenza sul profilo quantitativo della sanzione non è solo l’unico motivo per cui ha detto concorso formale non si suole far ricorso. Infatti l’applicazione del predetto principio comporterebbe numerosi problemi di ordine pratico che incidono in...