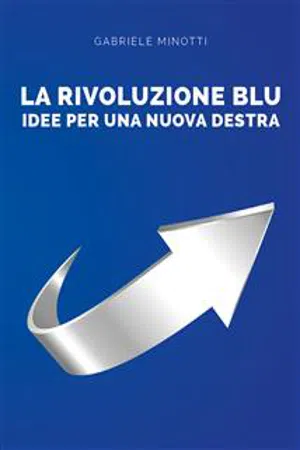![]()
Rompere i tabù: unioni civili e testamento biologico
Un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello delle unioni civili. Fondamentalmente perché, essendo di destra, ho una visione delle relazioni umane (di qualsiasi tipo) improntata a principi quali la responsabilità e la stabilità: il “libero amore”, senza vincoli e senza impegni di nessun genere, è qualcosa che va oltre la mia concezione. In secondo luogo, non ho mai capito sulla base di cosa il riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso pregiudicherebbe la famiglia “tradizionale” (o “naturale” come la si chiama oggigiorno, in maniera terminologicamente impropria) fondata sul matrimonio fra uomo e donna e aperta alla procreazione.
Andiamo con ordine. Dal 2016, con l'approvazione della ben nota “legge Cirinnà”, le coppie omosessuali italiane hanno la possibilità di accedere a un istituto giuridico, noto come “unione civile”, per regolamentare la loro vita in comune. Tranne che per le adozioni di figli esterni alla coppia, i diritti e i doveri derivanti dal contrarre tale rapporto giuridico sono gli stessi del matrimonio. Inutile dire che l'Italia è stata l'ultimo Paese occidentale ad aver provveduto in tal senso, dopo oltre un decennio di battaglie, proposte di legge arenatesi in Parlamento, discussioni inutili e interminabili, oltre che profondamente ideologiche.
In quell'occasione, la destra italiana uscì sconfitta. Non certo perché venne approvata una legge alla quale si è opposta strenuamente in nome della difesa della famiglia, ma perché intraprese una sciocca quanto inutile crociata dal sapore moralistico (probabilmente ingolosita dai voti di quelle formazioni cattolico-integraliste abbandonate da quella sinistra centrista, erede diretta della Democrazia Cristiana, che avevano sempre sostenuto) che poi si è rivelata essere una battaglia donchisciottesca contro i mulini a vento. Infatti, era inevitabile che, prima o poi, le unioni fra persone dello stesso sesso avrebbero trovato riconoscimento anche in Italia: perché, piaccia o no, i costumi e le società vanno avanti e progressivamente si aprono a nuove possibilità ed esperienze.
Se da noi l'istituzione di uno strumento giuridico a tutela delle coppie omosessuali è arrivata così in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e occidentali (che nella maggior parte dei casi avevano già provveduto da anni in questo senso), non è stato certo per la strenua opposizione dei vescovi – almeno fino all'elezione di Papa Francesco – né tanto meno per l'isteria del Family Day, ma per la pavidità dei legislatori per il loro attaccamento al consenso, per la mancanza di volontà politica, per l'iniquità di coloro che non ritengono di dover dare a ciascuno ciò che gli spetta.
Che la destra italiana abbia sempre avuto dei grossi problemi con la regolamentazione dei rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso è cosa ben nota, ma non altrettanto note sono le ragioni di questo. Quello che intendo fare nelle successive righe è analizzare – nella maniera più sintetica possibile – alcune delle motivazioni più frequentemente addotte dalla destra, nel corso del tempo, contro il riconoscimento delle unioni omosessuali, per dimostrarne la totale mancanza di logica, la completa insussistenza, evidenziando al tempo stesso come una vera destra, liberale e occidentale, non possa essere contraria al riconoscimento di un diritto fondamentale come quello alla vita famigliare di ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale.
La prima e fondamentale argomentazione è quella relativa alla difesa della “famiglia naturale”, che il riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso metterebbe a rischio. È davvero inintelligibile come ciò possa accadere. Gli uomini e le donne eterosessuali continueranno a sposarsi e ad avere figli indipendentemente dal fatto che le coppie omosessuali possano iscrivere la loro unione nei registri comunali e trarne dei benefici e delle garanzie. Al contrario, il rafforzamento delle libertà di alcuni finisce per rafforzare anche quelle di tutti gli altri, perché in questo modo, essendo ciascuno protetto dalla legge nell'esercizio del suo diritto di perseguire le sue aspirazioni e le sue finalità, tutti finiscono per rispettare il diritto degli altri di fare lo stesso.
Se quello che si vuol dire è che non possono esserci equiparazioni tra “famiglia naturale” e unioni omosessuali, in termini di diritti e doveri, la domanda è: perché? Non si capisce per quale motivo non dovrebbero esserci uguali doveri e perché, all'assunzione delle stesse responsabilità, non dovrebbero corrispondere uguali diritti. A ciò si risponderebbe che l'unica famiglia possibile, dal punto di vista morale come da quello giuridico, è quella fondata sul matrimonio fra uomo e donna. La Costituzione, si dice infatti, stabilisce chiaramente che la famiglia è quella società naturale fondata sul matrimonio. Ma tutto dipende da come viene interpretata questa definizione.
Il termine “naturale” è tutt'altro che univoco e può significare molte cose, non tutte coerenti tra loro. In generale, lo si utilizza per indicare tutti quei fenomeni che si verificano, regolarmente o necessariamente, nell'ordine delle cose e che hanno quindi un carattere di fissità. È evidente che la composizione della famiglia non è tra queste, o almeno l'esperienza non attesta nulla di simile. Si tratta di un'istituzione che inevitabilmente risente del cambiamento di costumi e dell'evoluzione sociale. Questo è l'unico modo in cui si può considerare naturale la famiglia: è naturale nella misura in cui è il risultato di un processo sociale spontaneo, nel momento in cui è conforme al senso comune, al costume e alla mentalità dominante in quelle circostanze storico-sociali. Secondo l'orientamento della maggior parte dei costituzionalisti, è proprio questo il senso in cui i padri costituenti intesero il termine “naturale” in riferimento alla famiglia: dopo l'esperienza fascista, in cui la famiglia era diventata uno strumento nelle mani del regime per il perseguimento di finalità politiche, si volle restituire a tale istituzione proprio quel carattere libertà e spontaneità che era venuto meno durante il Ventennio.
Non parliamo, poi, dell'assurdità di quella concezione giusnaturalistica – propria del cattolicesimo integralista e retrivo al quale la destra italiana si è scioccamente accodata – che pretende di inquadrare le norme e le istituzioni al di fuori di ogni contingenza storica e culturale, di considerarle astratte rispetto alle circostanze e ai fatti sociali. Col risultato di attribuire a esse un carattere del tutto sradicato dall'esperienza e privo di qualunque concretezza, puramente teorico e intellettuale.
Inoltre, quand'anche avessero ragione il Family Day e gli altri movimenti pro-famiglia, quand'anche esistesse davvero una famiglia la cui composizione sia iscritta nell'ordine naturale delle cose, ciò non determinerebbe alcun tipo di obbligo dal punto di vista giuridico e morale: si tratterebbe solo di un fatto, dal quale non c'è alcuna ragione di ricavare una norma vincolante.
Per il resto, l'esperienza ci dice il contrario delle farneticazioni sul diritto naturale: abbiamo visto la famiglia cambiare costantemente nel corso del tempo. Aristotele, nella “Politica”, includeva nella famiglia anche gli schiavi. Poi è stato il tempo della famiglia patriarcale. Poi si è giunti alla famiglia nucleare con a capo il marito. Successivamente, abbiamo equiparato la figura della moglie a quella del marito. Ora vediamo che ci sono più tipi di famiglia, che vanno da quella tradizionale fondata sul matrimonio fino alle coppie di fatto eterosessuali, dalle cosiddette famiglie monoparentali (con un solo genitore e i figli) a quelle ricostituite (i genitori hanno divorziato e hanno creato nuove situazioni con altre persone, non di rado mettendo al mondo altri figli con queste) fino ad arrivare alle unioni omosessuali, che sebbene non siano poste dalla legge sotto la tutela dell'articolo ventinove della Costituzione, ma dell'articolo due sulle “formazioni sociali”, non possono non essere incluse, almeno dal punto di vista morale e pratico, sotto la denominazione di “famiglia”.
Al contrario, la Costituzione della Repubblica Italiana dice chiaramente che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di alcun tipo: dunque, non si capisce su che basi l'omosessualità dovrebbe costituire un impedimento alla conduzione di una vita famigliare riconosciuta e tutelata dalla legge. Sia chiaro che non si tratta di uguaglianza in termini di risultati, che si traduce in egualitarismo ideologico e pretestuoso, ma di eguaglianza in termini di opportunità, per cui tutti possono pensare di raggiungere determinati risultati e impegnarsi a tal fine.
In secondo luogo, si è detto che le unioni civili, lungi dall'essere pensate per offrire una tutela alle coppie omosessuali, non erano altro che una sorta di “cavallo di Troia” attraverso il quale la lobby gay sarebbe arrivata a rivendicazioni e scopi ben più controversi, come l'adozione di bambini esterni alla coppia o all'utero in affitto, nonché all'insegnamento dell'ideologia gender nelle scuole. Anche in questo caso non è chiara la correlazione tra questi elementi: si tratta di conseguenze potenziali, ma non necessarie. Nel senso che potrebbero esserci, ma ci saranno solo laddove si lascerà che ci siano.
Questo è uno stratagemma ormai utilizzato fino alla consunzione: quando non si trovano argomenti sufficientemente validi e credibili contro una certa istanza, ci si concentra sulle possibili conseguenze negative che esso potrebbe avere. Ma questo non si chiama ragionare sulle cose presenti, ma ipotizzare, fare supposizioni su un futuro che nessuno conosce e nessuno può prevedere. Nello specifico, si teme che l'equiparazione giuridica tra coppie sposate e coppie unite civilmente possa, nel medio-lungo periodo, attraverso la giurisprudenza, avallare la possibilità per queste ultime di adottare dei bambini: infatti, se le due cose sono equiparate sotto tutti i punti di vista, perché non dovrebbero esserlo anche sotto quest'aspetto? Si teme inoltre che anche la sola possibilità di adottare il figlio biologico del partner – come previsto dalla legge Cirinnà – possa in qualche modo invogliare le coppie omosessuali a ricorrere alla pratica della maternità surrogata.
Premetto di essere perplesso e tendenzialmente scettico sull'opportunità che due uomini o due donne allevino un bambino, per tutta una serie di motivazioni che meriterebbero una trattazione separata. Aggiungo di essere inorridito dall'idea che ci si possa servire di una donna come di un'incubatrice, come una “macchina per figli”: questo sì è parte del processo di “oggettivazione” della persona, e dunque lesivo della dignità umana.
Ciononostante, queste non sono delle buone ragioni per eludere il problema: non si deve, per questo, rinunciare a disciplinare le unioni fra persone dello stesso sesso, ma semplicemente provvedere affinché non si vada oltre i limiti consentiti.
In più, per l'ordinamento italiano possono adottare solo le coppie sposate: proprio per questo si è ritenuto di approntare un istituto giuridico diverso per le coppie omosessuali: per evitare il “passo più lungo della gamba”. L'unione civile, pur essendo realmente simile al matrimonio, non lo è nominalmente. Ciò significa che nessun bambino può essere adottato da una coppia di omosessuali, nemmeno per via giurisprudenziale, come ci attesta l'esperienza: le uniche sentenze in questo senso sono relative sempre ai figli biologici di uno dei due partner o all'affido momentaneo in caso di inadeguatezza dei genitori, il più delle volte a coppie in cui tra almeno uno dei due partner e il bambino in questione già sussiste un legame significativo (per esempio di parentela o di amicizia). Dunque, il problema non esiste.
Quanto all'ideologia gender: anzitutto, sarebbe bene darne una definizione univoca e chiara, perché ancora si fa fatica a capire di cosa si tratti. Se, come sospetto e senza considerare il catastrofismo di un certo pseudo-cattolicesimo, si tratta semplicemente di dire che i ruoli di genere sono dati dalla cultura e non dalla biologia, non vedo come si possa contestare una simile affermazione. Non è la biologia a stabilire che gli uomini debbano andare a lavorare e che le donne debbano stare a casa a pulire e a cucinare; né è la biologia a dirci che il soldato o il pompiere sono mestieri da uomini e la maestra o l'infermiera da donne. Tutto è frutto della cultura. Per cui a un mutamento socio-culturale corrisponde un mutamento anche nei ruoli di genere. Esiste una scienza che osserva e analizza questi mutamenti: gli “studi di genere”, per l'appunto.
Il punto non è stabilire se i ruoli di genere siano fissi e immutabili in quanto naturali, o mutevoli in quanto dati dalla cultura: il principio è stabilire che se non si può manipolare la società, le sue tradizioni e la sua cultura a proprio piacimento, per cui non si può pretendere di sovvertire ciò che l'esperienza di secoli ci ha dimostrato essere buono e funzionale, lo si può tuttavia integrare nel corso del tempo.
I ruoli che uomini e donne rivestono in società e all'interno della famiglia possono variare a seconda delle diverse circostanze di tempo e di luogo. Questa non è ideologia, ma senso della realtà, per quanto taluni gruppi, abituati a pensare secondo schemi metafisici vecchi di secoli, possano averne una concezione piuttosto alterata, finendo per confondere la realtà con le congetture loro famigliari.
Discorso diverso sono gli eccessi auspicati dal movimento lgbt – che chi scrive contesta apertamente e col quale rifiuta ogni accostamento – come il superamento della binarietà dei sessi (la cosiddetta “teoria queer”) o la variabilità del sesso a piacimento, data l'inesistenza di differenze biologiche, ma solo culturali, fra uomo e donna. Come pure l'idea di lasciare che i rappresentanti delle associazioni lgbt tengano lezioni nelle scuole o che dei travestiti raccontino fiabe ai bambini. Esistono solo due sessi: maschio e femmina. Sono biologicamente determinati e variabili solo con uno specifico intervento chirurgico a seguito di un percorso stabilito. I rappresentanti delle associazioni lgbt, dato il messaggio estremista e radicale di cui si fanno portatori (lo dico per esperienza), abilmente celato dietro la lotta alla discriminazione e per i diritti delle persone omosessuali, non devono entrare nelle scuole. E le fiabe ai bambini devono raccontarle i genitori, non certo degli estranei, oltretutto conciati da “drag-queen”. Si tratta, quindi, di trovare il giusto equilibrio, una via di mezzo tra due opposti fanatismi: quello del Family Day e quello dell'Arcigay.
Un'altra argomentazione pretestuosa addotta dalle destre italiane contro l'approvazione delle unioni civili è stata che esse erano fondamentalmente inutili: per regolamentare le questioni patrimoniali all'interno delle coppie omosessuali sarebbe stato sufficiente una scrittura privata, un testamento. Semplicemente ridicolo. In primo luogo, il testamento non risolve tutte le situazioni, ma solo quelle relative al lascito dei beni mobili e immobili: rimangono prive di copertura tutta un'altra serie di questioni, quali quelle previdenziali o assicurative, la successione nei contratti d'affitto, la possibilità di prendere decisioni sulla salute del partner, la possibilità di avere dei permessi dal lavoro per assisterlo e simili. In secondo luogo, sono davvero poche le persone che, in giovane età, redigono un simile atto, a meno che non si tratti di individui estremamente previdenti, dal momento che difficilmente, da giovani, si pensa alla possibilità di morire prematuramente a causa di un incidente o di una malattia.
In terzo luogo, nel nostro ordinamento esiste la cosiddetta “quota legittima”, che è un limite posto alla volontà del testatore, che deve per forza tenere conto dei legami di parentela più prossimi: sicché, se il testatore redige un atto col quale lascia al suo compagno o alla sua compagna ogni suo avere, i legittimari potrebbero sempre impugnare il testamento onde ricevere la loro parte di eredità, a maggior ragione che la persona designata come erede, per la legge, non sarebbe più di un amico o di un coinquilino. Quindi il testamento, lungi dall'essere una valida alternativa all'unione civile, non offre alcuna garanzia, né alcuna copertura giuridica, alle coppie omosessuali.
Provai grande dispiacere quando Giorgia Meloni ebbe a dire – proprio in occasione della discussione sulla legge Cirinnà – che le unioni civili avrebbero finito per appesantire le casse dell'Inps, obbligando lo Stato a erogare la reversibilità anche alle coppie omosessuali. E che, in ogni caso, la pensione di reversibilità era stata pensata per le donne rimaste prive di reddito con la morte dei mariti e per i figli rimasti orfani: in nessun caso per le coppie gay. Anzitutto, non credo che siano quelle poche coppie omosessuali unite civilmente ad appesantire i conti della previdenza. In secondo luogo, quand'anche fosse, si potrebbe ovviare al problema tagliando laddove sarebbe doveroso, come sulle pensioni d'invalidità ricevute dai vari ciechi che guidano l'auto o dai vari paralitici che fanno jogging, nonché sui sussidi coi quali facciamo ingrassare gli sfaccendati e i malavitosi: in questo caso, col risparmio, potremmo coprire molto più che le spese per erogare la pensione di reversibilità alle coppie omosessuali. Ancora, se questo fosse vero, allora si dovrebbero dispensare gli omosessuali dall'obbligo contributivo nei confronti dell'Inps o si dovrebbe far pagare loro una quota contributiva inferiore, giacché quei soldi non sono un regalo all'ente previdenziale, ma un semplice prestito che, si suppone, debba tornare indietro.
Da ultimo, è sicuramente vero che la pensione di reversibilità venne originariamente pensata per tutelare le vedove e gli orfani, in un tempo in cui la sola fonte di reddito in una famiglia era il lavoro dell'uomo. Ma allora si dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere che tale istituto ha ormai perso ogni utilità, dal momento che la maggior parte delle donne, al giorno d'oggi, lavora ed è economicamente auto-sufficiente. Al contrario, bisogna smettere di pensare alla pensione di reversibilità come a una tutela e iniziare a concepirla come un'integrazione al reddito per fare in modo che, anche dopo la morte del coniuge, si possa continuare a condurre un tenore di vita simile a prima dell'infausto evento. E in tal caso non vi sarebbe alcun motivo di negare tale beneficio anche alle coppie omosessuali.
Personalmente, come già detto in precedenza, sono favorevole a un sistema previdenziale integralmente privato, nel quale lo Stato non abbia alcun ruolo e nel quale ciascuno sia completamente libero di scegliere quanto versare, a quale compagnia assicurativa e a chi lasciare la suddetta integrazione al reddito in caso di morte. Tuttavia, fin quando il nostro sistema previdenziale sarà pubblico, non posso esimermi dal ragionare sulla base di ciò che esiste e che funziona attualmente.
È stato detto, inoltre, che l'amore non fa diritto, che due uomini o due donne sono liberi di amarsi e di vivere assieme, ma che questo non determina il dovere, da parte dello Stato, di attribuire rilevanza giuridica a tale situazione. Lo Stato, infatti, non disciplina i sentimenti, ma solo ciò che è utile: se riconosce il matrimonio tra uomo e donna è perché esso è necessario per la procreazione legittima, e quindi per la conservazione della comunità.
Ora, se l'unico interesse dello Stato fosse la maggior procreazione possibile, allora non dovrebbe tutelare nessun tipo di unione monogama, dal momento che qualunque uomo potrebbe avere più figli contemporaneamente da diverse donne, invece che un solo figlio da una sola donna. Inoltre, se davvero lo Stato non normasse i sentimenti, tale argomento sarebbe inattaccabile. Tuttavia, è vero l'esatto contrario, perché la comunità si fonda proprio sui sentimenti, sulla “simpatia”, ossia sulla capacità di immedesimarsi nell'altro, di condividerne le emozioni, di guardarlo e di riconoscersi in esso. I legami comunitari non sono altro che legami emotivi e sentimentali, per il quale riconosciamo noi stessi e le nostre emozioni nell'altro e nelle sue emozioni. Per cui, se lo Stato governa la comunità e la comunità si fonda sui sentimenti, allora lo Stato, di fatto, non può non riconoscere quei sentimenti ai quali deve la sua stessa esistenza. Ciò sarebbe contraddittorio rispetto alla sua natura.
La verità è che lo Stato esiste per proteggere qualunque vincolo di tipo contrattuale che i cittadini, in piena libertà e responsabilità, scelgono di intrattenere. Lo Stato ha come fine la difesa della vita, della libertà e della proprietà delle persone. Ora, cos'è l'unione civile se non ...