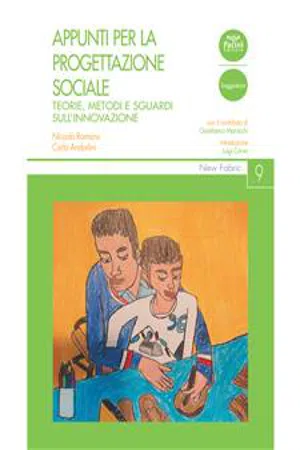
eBook - ePub
Appunti per la progettazione sociale
Teorie, metodi e sguardi sull'innovazione
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Appunti per la progettazione sociale
Teorie, metodi e sguardi sull'innovazione
Informazioni su questo libro
Appunti per la progettazione sociale prova a alimentare la letteratura specifica sul tema con una sorta di manuale che alterna contenuti teorici ad approfondimenti tesi a evidenziare strumenti, approcci, metodi e innovazione di una progettazione capace di “stare nel mezzo” ai cambiamenti in atto.
Si rivolge prioritariamente a coloro che si affacciano alla progettazione sociale e a studenti universitari, cui vuole offrire uno strumento agile ma il più possibile completo, per affrontare una materia che, al di là dei riferimenti teorici, richiede necessariamente di essere praticata, con un continuo ancoraggio alla realtà delle cose.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Appunti per la progettazione sociale di Niccolò Romano,Carlo Andorlini, Gianfranco Marocchi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Sociologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
PARTE SECONDA
LA PRATICA DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE
Capitolo 3. Fasi e approcci del lavoro “desk”
Una breve premessa
Iniziamo con una doverosa premessa: in questo capitolo ci occuperemo in gran parte di un approccio metodologico alla gestione del ciclo di progetto in auge da vari decenni, ampiamente analizzato e talvolta criticato: il Project Cycle Management (o PCM); non andremo quindi a raccontare niente di sostanzialmente nuovo, e non abbiamo neppure la presunzione di offrire una disamina approfondita di tale metodologia: esistono già a questo proposito strumenti facilmente accessibili1, che non avrebbe senso duplicare o parafrasare pedissequamente. Quello che invece vorremmo fare, è fornire qualche semplice chiave interpretativa su un approccio che, seppur largamente adottato (e richiesto da finanziatori pubblici e privati), non sempre risulta aderente a contesti e realtà in cui la progettazione tende a farsi più liquida e destrutturata, o quantomeno ad assumere forme oblique.
Non si tratta di semplice opportunismo (ci chiedono di progettare in questo modo, quindi impariamo a farlo), quanto, piuttosto, di saperne riconoscere e decifrare gli elementi di valore, in modo da recuperarne la catena di senso, anche al di fuori di schemi apparentemente troppo rigidi.
Riteniamo, infatti, che i fondamentali del PCM (li riassumiamo qui in tre parole: orientamento all’obiettivo) posseggano un valore intrinseco e, se in certi casi possono servire come spartiacque per aiutarci a distinguere ciò che è un progetto da ciò che non lo è (ma viene talvolta “camuffato” per esigenze varie, come abbiamo visto nel primo capitolo), d’altro canto possono anche soccorrere nel riconoscere, ricondurre e valorizzare entro una logica progettuale prassi ed esperienze che nascono dal basso.
Questo non vuol dire che il PCM sia l’unico o il migliore dei modi di progettare, né che la progettazione debba necessariamente parlare quel linguaggio od utilizzare meccanicamente determinati schemi (le stesse linee guida della Commissione Europea ammoniscono sui rischi derivanti da una loro applicazione sterile); è invece l’impianto logico di fondo che, come detto e ridiremo, può fornire una bussola per orientarsi, anche prendendo a prestito certi strumenti, con la libertà di reinterpretarli e adeguarli ai nostri scopi.
E una metafora per cominciare
Come in parte abbiamo già anticipato, un progetto origina e si sostanzia in un processo articolato, che non è astratto ma squisitamente concreto, essendo contestualizzato, innanzi tutto, entro precise coordinate di spazio e di tempo: è come un viaggio, attraverso il quale si vuole raggiungere un traguardo; durante il tragitto capita di avere compagni di viaggio, come di fare incontri occasionali, più o meno fortunati; e si potranno avere a disposizione mezzi e risorse che ci consentiranno di affrontare il cammino, in un modo o nell’altro.
In questa metafora del viaggio2, già possiamo intravedere le costanti che caratterizzano il processo progettuale, che devono sempre essere definite e comprese in profondità, pena la fragilità e l’incertezza dell’agire.
Ogni viaggio ha un punto di partenza, ed anche i progetti possono avere scaturigini diverse, che contribuiscono ad innescare e alimentare il desiderio di cambiamento: può essere un evento esterno (si parla di focusing event, quando un particolare evento funge da catalizzatore di energie progettuali), un bando di finanziamento, un’innovazione normativa, una sollecitazione politico-culturale, una risoluzione interna ad un’organizzazione, una particolare attitudine o la condizione personale di un membro dello staff; o (più spesso) un mix di tutto questo. C’è poi la meta che vogliamo raggiungere: lo scopo del progetto; e ci sono i vari soggetti coinvolti nel processo: attori e partner, destinatari diretti e indiretti, reti di relazioni; ci sono i mezzi a disposizione: possiamo scegliere di fare un viaggio in treno, in aereo, in auto, a piedi, in barca o bicicletta, e allo stesso modo potremo avere mezzi e risorse anche molto differenti (umane, materiali, finanziarie) per portare a termine il nostro progetto; e ci sono, infine, i chilometri che dobbiamo percorrere: le azioni e le attività che saranno pianificate all’interno del perimetro progettuale.
Come succede spesso anche con i viaggi (quantomeno con quelli in cui è previsto un ritorno), il percorso non è lineare, ma circolare: si parla, non a caso di ciclo di progetto; analogamente a quanto abbiamo visto in relazione alla programmazione, infatti, le varie tappe si avvicendano e si rincorrono entro un movimento ad anello, che si rinnova ogni volta ripartendo da un nuovo inizio. Per esaurire questa metafora, possiamo concludere che, come in un viaggio utilizzeremo una cartina geografica che ci mostri la strada, così avremo bisogno di una mappa metodologica che ci aiuti a districarci ed orientarci tra le vie tortuose dell’azione sociale.
Differenti approcci metodologici
In letteratura3 vengono individuati due principali approcci metodologici alla progettazione sociale: quello sinottico razionale e quello dialogico4.
L’approccio sinottico razionale poggia su una visione meccanicistica della realtà: assumendo come punto di partenza la possibilità di ricostruire con certezza le catene causali che sono alla base dei problemi individuati, postula che sia possibile individuare con altrettanta certezza (sulla base di giudizi oggettivi) le migliori soluzioni che, una volta messe in campo, saranno in grado di centrare l’obiettivo. L’orientamento dunque è al problem solving5, con una centralità dominante del sapere tecnico, tipica della progettazione in ambito scientifico.
L’approccio dialogico affonda invece le sue radici nelle teorie sistemiche e in una concezione costruttivista della realtà6, secondo cui l’ambiente esterno è in continua interazione con i diversi punti di vista degli osservatori, dai quali è influenzata e modificata, e che a loro volta interagiscono con l’interno e con l’esterno. Secondo l’approccio dialogico, la progettazione nasce e trae vitalità dalle relazioni; l’orientamento, in questo caso, è al problem setting7, nel senso che i problemi non sono oggettivamente predeterminati: è dalla relazione tra i vari soggetti coinvolti che si individuano i problemi8 e prendono forma le possibili soluzioni; soluzioni che, probabilmente, non saranno le migliori nel migliore dei mondi possibili, ma sono quelle che, in un dato luogo e in un dato momento, appaiono le più adeguate ad esito di un processo di scambio, confronto e negoziazione tra le parti in gioco.
Entrambi gli approcci illustrati presentano luci ed ombre: un’eccessiva tendenza alla semplificazione, il primo; il rischio di dispersione connesso alla natura negoziale e stipulativa del secondo. Luci ed ombre che, in linea generale, se da una parte possono far ritenere l’approccio razionale adeguato a situazioni in cui i problemi da affrontare sono ampiamente noti e condivisi, d’altro canto faranno prediligere l’approccio dialogico laddove le problematiche sono nuove od oltremodo complesse9.
Abbiamo riportato questa brevissima rassegna per dovere di completezza, ma riteniamo di poter affermare che, data la multiformità dei fenomeni e degli universi umani ed alla luce delle considerazioni sopra svolte sull’evoluzione del welfare e i pilastri della progettazione sociale, una scelta netta tra i due approcci non sia da considerare all’ordine del giorno10. Come abbiamo visto, i sistemi di protezione sociale stanno evolvendo nella direzione di una pluralità di attori e di funzioni, ed i problemi da affrontare sono sempre più sfaccettati e complessi: anche il problema apparentemente più semplice richiede la messa in campo e il confronto tra posizioni, saperi e punti di vista diversi; è allora impensabile che la realtà del sociale possa essere ricostruita in base a semplificazioni fisico-centriche che attribuiscono a leggi certe ed immutabili la capacità di prevedere univocamente azioni e reazioni, e che le soluzioni possano giungere dall’applicazione di un determinismo meccanicistico, e altrettanto semplificatorio. In questo senso, oltre alla consapevolezza di agire entro sistemi complessi in una prospettiva costruttivista, sarà necessario ricostruire le relazioni di causa/effetto all’insegna di una causalità circolare, in cui non c’è una linearità unidirezionale (X è causa diretta di Y, che ne è l’effetto), ma fenomeni ed eventi interagiscono continuamente e si influenzano a vicenda, in modo biunivoco e ricorsivo11.
La questione, semmai, sarà quella di come graduare le interazioni e le relazioni che alimentano il processo progettuale: più o meno intense, più o meno complesse, ma comunque necessarie.
Possiamo quindi affermare che la progettazione nel sociale adotti sempre un approccio di tipo dialogico? Purtroppo no, per diverse ragioni. Prima di tutto perché mettere in piedi dinamiche di concertazione è faticoso e spesso costoso; inoltre, quella tendenza distorsiva a rincorrere bandi e opportunità di finanziamento che abbiamo incontrato nel primo capitolo, spinge ad una sorta di progettazione in scala (il cosiddetto “progettificio”), in cui risulta dominante la capacità di utilizzare determinate forme e strutture tecniche, a tutto discapito del dialogo. E, ironia della sorte, la progettazione in scala porta ad applicare ed interpretare in modo acritico (acquisendone linguaggi e strumenti ma riducendoli spesso a vuoti automatismi) proprio quella metodologia così apprezzata dai finanziatori (il PCM) che, come vedremo subito, considera invece uno dei suoi presupposti fondamentali il coinvolgimento dei beneficiari e l’analisi partecipata dei problemi.
Il Project Cycle Management: origini e inquadramento
Dopo averne accennato più volte, ci dedichiamo adesso al Project Cycle Management, metodologia di gestione del ciclo di progetto ormai diventata a tutti gli effetti uno standard di progettazione (non soltanto sociale), essendo adottata in modo più o meno esplicito da varie linee di finanziamento: in primis dall’Unione Europea, nonché dai principali organismi pubblici e privati che concedono finanziamenti su progetti.
Il PCM è stato introdotto sistematicamente negli anni novanta dal programma europeo di cooperazione internazionale, sulla base di una serie di debolezze ricorrenti12, messe in evidenza dalla valutazione delle pregresse esperienze.
I progetti finanziati, in particolare, erano risultati carenti sotto una serie di profili, che possiamo di seguito riassumere:
- scarsa aderenza e rispondenza ai bisogni e alle problematiche dei destinatari, a causa di una analisi non sufficientemente approfondita del contesto di riferimento;
- progetti focalizzati sulle attività, e scarsamente orientati al raggiungimento di obiettivi definiti a monte e di risultati oggettivamente verificabili;
- visione di breve termine e scarsamente orientata alla sostenibilità di lungo periodo.
Per ovviare alle carenze sopra riepilogate, viene dunque proposto un processo articolato in sei fasi13 che, unitamente ad una serie di principi di fondo, mira a supportare ed orientare una progettazione più solida e logicamente coerente.
Ecco le fasi in cui si dispiega il ciclo di progetto:
- Programmazione indicativa
- Identificazione
- Formulazione
- Finanziamento
- Realizzazione
- Valutazione
Le fasi del ciclo sono teoricamente progressive (finisce una e comincia l’altra), ma, nella pratica, possono – e spesso devono – essere diacroniche (la valutazione, ad esempio, viene svolta, come vedremo, durante tutto l’arco del processo; allo stesso modo, nella fase di finanziamento, potrà spesso accadere di dover ritornare sui passi precedenti per adeguarli o armonizzarli alla linea di finanziamento individuata).
Programmazione indicativa
Come già sappiamo, la programmazione precede il progetto: preesistono vari livelli di pianificazione che, a seconda dei punti di vista, possono rappresentare dei vincoli entro i quali l’azione progettuale deve esplicarsi. Se la vediamo in questi termini, può sembrare una sorta di costrizione, una camicia di forza che tarpa le ali del progettista illuminato; in realtà, secondo la nostra esperienza, una valida cornice programmatica (in particolar modo se condivisa e frutto di livelli articolati di concertazione e partecipazione) rappresenta un’ancora di salvezza per il team di progetto, cui fornisce preziose coordinate in termini di priorità tematiche, possibilità di risorse dedicate, opportunità di cooperazione con altri progetti ed altri attori, m...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- INTRODUZIONE
- PREMESSA: SUGGESTIONI SUL SENSO, SIGNIFICATO E VALORE
- PARTE PRIMA: ORIENTAMENTO TEORICO E POSIZIONAMENTO CULTURALE
- PARTE SECONDA: LA PRATICA DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE
- PARTE TERZA: LE FORME PATTIZIE
- PARTE QUARTA: I SOGGETTI
- PARTE QUINTA: FOCUS SULLA VALUTAZIONE
- BIBLIOGRAFIA
- NOTE SUGLI AUTORI