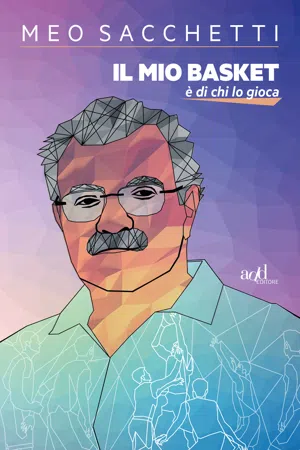![]()
Time out 1
(Dido Guerrieri, 1983)
Quello che sto per raccontare è uno dei primi time out di cui ho memoria, con il maestro Dido Guerrieri, allora mio allenatore. Si stava giocando una partita per me molto importante perché, con la maglia di Torino, eravamo sul campo di Varese, la mia squadra del cuore fin dai tempi di Novara quando ancora non ero nessuno. Sarà stato il 1983, ero ancora giovane, molto giovane, e ricordo che nel finale si era creata una situazione per me abbastanza inedita: dovevo tirare due liberi, a quel punto decisivi, perché mancava una manciata di secondi al temine
L’allenatore avversario chiese il timeout, con l’obiettivo di togliermi la concentrazione. Subire il fallo e andare subito in lunetta è molto meglio che andarci dopo aver trascorso un minuto ad arrovellarti il cervello al pensiero di tutto quel che può accadere se, per disgrazia, sbagli i due tiri liberi che si chiamano anche tiri dalla “linea della carità” perché fare canestro da quattro metri, senza un avversario che ti ostacola, dovrebbe essere (in teoria) facile come gettare una monetina nel piattino di un mendicante.
Mentre eravamo raccolti attorno a Guerrieri si discuteva degli scenari possibili: se Meo li sbaglia tutti e due, facciamo così, se ne sbaglia uno solo facciamo così. Tutti avevano qualcosa da dirmi, ma Guerrieri zittì ogni voce dicendo, con estrema sicurezza: «Tranquilli ragazzi, Meo li mette dentro tutti e due e vinciamo la partita». Con quelle poche parole mi aveva trasmesso una grande carica, mi aveva quasi inculcato la certezza che non li avrei sbagliati. Infatti non li sbagliai e vincemmo quella partita.
In pochi secondi, Guerrieri mi aveva dato una fondamentale lezione di vita sportiva: vedere sempre rosa, essere ottimisti. Il coach dalla panchina deve solo trasmettere messaggi positivi. Purtroppo non sempre basta questo atteggiamento per arrivare al risultato e a volte anche gli infallibili sbagliano, ma questi ricordi, si possono tranquillamente dimenticare…
![]()
Olimpia e tre figli
E pensare che non doveva neppure essere un maschio.
Brian, il figlio che mi ha regalato la gioia impagabile di vincere insieme uno scudetto, nelle lastre delle ecografie era una femminuccia.
Sarebbe stata la seconda, dopo Alice nata due anni prima, nel 1983, e che adesso vive in Finlandia dove si è sposata con un “vichingo”, come chiamo con affetto e un pizzico di sarcasmo, Matti, mio genero. A Helsinki Alice era arrivata per l’Erasmus dalla Statale di Milano, ma dopo la laurea triennale in Lingue e letterature straniere ha deciso di ritornare lassù per concludere il ciclo di studi con la specialistica. Doveva fermarsi appena il tempo utile, ma ha trovato lavoro, si è ambientata e lì creerà la sua famiglia. I Sachet-Sacchetti diventano così sempre più europei: dalla Romania alla Finlandia dopo essere partiti e rientrati in Italia. E chissà che cos’altro accadrà…
Ho assistito alla nascita di tutti e tre i miei figli e non è stato semplice: avevo il terrore del sangue, credevo di non sopportare l’ambiente della sala parto, non me la sentivo, insomma, ma ero convinto che esserci fosse la cosa giusta. Nel mio caso, però, c’era anche un problema di tipo pratico: il camice che avrei dovuto indossare.
Vista la mia stazza, quelli in dotazione al reparto erano così stretti da sembrare, su di me, una camicia di forza aderente come una calzamaglia. Arrivato il giorno della nascita di Brian, mi preparo con questo “coso” stretto addosso ed entro in sala parto pronto a veder nascere la mia seconda femminuccia. E invece, al momento del parto, l’ostetrica annuncia trionfale «È maschio» e io, in una situazione che da felice si era trasformata in surreale e quasi imbarazzante, tra lo stupore generale rispondo con una frase ancora più assurda: «Deve esserci un errore».
No, nessun errore, se non quello commesso dall’ecografista.
Olimpia aveva scelto il nome di Alice e adesso toccava a me trovare quello del secondogenito, oltretutto “improvvisamente” maschio, quindi da decidere in pochissimo tempo senza aver modo di confrontarsi e meditare con calma la cosa. In quel periodo, tra i miei giocatori preferiti c’era Brian Winters, atleta Nba di un anno più vecchio di me al quale mi ispiravo (una guardia anche lui, di quasi due metri, scelto al draft del 1974 dai Los Angeles Lakers) e che aveva a lungo giocato nei Milwaukee Bucks. Di lui mi piaceva soprattutto la pulizia dei fondamentali e ne ammiravo il tiro mortifero, quello che io non ho mai avuto… Quando mi chiedono che giocatore sono stato provo un certo imbarazzo: amo dire che sono stato uno che ha copiato molto e ha sempre cercato di imparare guardando gli altri.
Avevo una caratteristica che mi rendeva un giocatore particolare nel panorama del basket italiano, una stazza extra-large, ma piedi rapidi che mi permettevano di correre e, quando ho cominciato a certi livelli, ho avuto la fortuna di avere un playmaker come Charlie Caglieris che capiva i miei movimenti e mi faceva arrivare la palla tra le mani.
Ho sempre preferito un assist a un canestro, mi sono sempre sacrificato in difesa e ho difeso su tutti, da Larry Wright, velocissimo playmaker di Roma campione d’Italia e d’Europa, al monumentale Dino Meneghin. In attacco ho giocato molto vicino al canestro, da “quattro” come si direbbe oggi ma anche da playmaker puro: l’ho fatto anche all’Olimpiade di Mosca 1980 dove, per necessità di squadra, contro la Spagna mi sono improvvisato regista. La cosa non mi veniva troppo male, e inoltre proteggevo la palla con il corpo, perché in quel modo era come metterla in cima a una montagna, o in cassaforte.
Non ho mai vissuto per il canestro e per lo scout, e se un merito mi va riconosciuto è quello di aver aiutato gli altri a giocare meglio e mettere in evidenza le loro doti. Mi è sempre piaciuto il basket “difesa e contropiede”, con transizioni rapide e quando ho smesso di giocare ho trasferito questa metodologia nella mia carriera di allenatore.
Sì, Brian Winters incarnava un po’ il mio modo di giocare, era un modello e a lui pensai quel 4 maggio 1986 a Moncalieri con il mio secondo figlio tra le braccia.
Olimpia non era molto d’accordo di chiamarlo Brian, soprattutto come primo nome, e aveva rilanciato con un più consueto Simone; nel braccialetto che mettono al polso di mamma e neonato subito dopo la nascita c’era addirittura già scritto Simone, ma in quel momento era troppo esausta per frenare la mia insistenza. Decidemmo, salomonicamente, che l’avremmo registrato con entrambi i nomi, ma per me i problemi non erano finiti e un altro ostacolo mi aspettava in Comune a Moncalieri, dove non avevano accettato il nome Brian perché straniero. Mi avevano però detto che potevano italianizzarlo.
«Sì, ma come?», avevo chiesto.
E loro: «Facciamo Briano».
Non proprio una meraviglia, quindi il mio secondogenito è registrato come Brian Simone, ma per tutti è solo Brian.
Con Olimpia avevamo discusso anche al momento di scegliere il nome per Alice. Io volevo chiamarla Chantal: fu lei a “suggerire” Alice, dicendo che aveva in testa quel nome fin da ragazza. Non potevo che cedere.
Ma al di là delle diatribe per i nomi, un altro particolare stava per accomunare tutti e tre i nostri figli: data, giorno della settimana e ora di nascita. Alice e Brian sono nati entrambi di domenica, il giorno 4 e intorno alle 15, minuto più, minuto meno. Anche Tommy, il mio terzo figlio, sembrava indirizzato al giorno 4, di luglio, altra domenica, ma per quella data io dovevo essere a Bormio per l’inizio del corso allenatori. In quel periodo il nostro ginecologo di fiducia era diventato Paolo, mio cognato e marito della sorella di Olimpia, Luisa: non so come, ma trovarono il modo, assolutamente naturale, intorno alle 15 del 29 giugno di anticipare la nascita per permettermi di essere anche quella volta presente in sala parto.
All’inizio Brian era appassionato soprattutto di calcio, ma non dovetti aspettare molto per vederlo dedicarsi alla pallacanestro. La svolta avvenne quando, l’estate dei Mondiali del 1990, andammo al camp in Valsesia organizzato da quel grande amico e dirigente che è stato Osvaldo Gagliardini, un uomo eccezionale. Era un insegnante, appassionato come pochi altri del basket, di quello vero, di quello fatto dai giovani e dai bambini, pensato per loro, per la loro crescita. Un basket ricco di grandi valori, sportivi e soprattutto etici. Con queste premesse ha aperto un camp di basket in Valsesia che per molti anni ha portato il mio nome, cosa di cui sono molto fiero e onorato.
A quel camp Brian si era presentato con le due divise da calcio (Juventus e Milan, per non fare torto né a me, milanista, né a Olimpia, bianconera), ma Lella, la moglie di Osvaldo, lo spronò a imitare gli altri bambini che tiravano a canestro. Aveva appena compiuto cinque anni, e siccome non c’erano altri modi per arginare la sua esuberanza, quel settembre lo iscrivemmo per la prima volta ai corsi di minibasket.
Brian mi somiglia, anche come struttura fisica. Io forse ero un po’ più forte, ma lui ha un tiro, sia dalla lunetta, sia da tre punti, di certo migliore del mio.
Non è finita qui, però: anche Tommy ora gioca in serie B. In lui rivedo la mia ostinazione nel voler raggiungere traguardi importanti e recuperare il tempo perduto per il fatto di aver cominciato tardi. Sta lavorando duro. È nato nel 1993 e anche per lui, alla nascita, c’è stato qualche problema sul nome… con Olimpia. Io volevo chiamarlo Larry, perché a quell’epoca il mio idolo, che aveva appena smesso di giocare, era l’indimenticabile Larry Bird, ma niente da fare: in quell’occasione Olimpia era stata irremovibile. «Non se ne parla» e aveva “suggerito” «chiamiamolo Tommaso».
Io, come al solito, volevo avere l’ultima parola e lo chiamammo Tommy americanizzando la scelta di Olimpia per avere almeno qualche assonanza con Larry. Questo nome, però, è diventato il nickname che Tommy usa nella posta elettronica: quindi posso dire che un omaggio al biondo dei Celtics sarebbe piaciuto anche a lui.
Il 26 giugno 2015 a Reggio Emilia per festeggiare con me e Brian lo scudetto della Dinamo c’era anche Tommy: era in tribuna, tra gli ultras della Dinamo e il servizio di sorveglianza non voleva farlo scendere sul campo al termine della partita, ma Brian, supportato dalla mamma, abbracciandolo al di là della transenna, non so come riuscì ad alzarlo e trascinarlo sul parquet. Ma nei miei occhi e nel mio cuore, su quel campo c’era soprattutto Olimpia, “Holly” per tutti.
Anche il suo nome è abbastanza singolare: è nata a Torino, e i genitori, seguendo le Olimpiadi in televisione, avevano poi deciso di ricordare quell’evento sportivo straordinario chiamandola così. Anche lei ha giocato a basket e il nostro incontro è avvenuto quando ero a Torino proprio su un campo di pallacanestro. Maggio 1980: lei giocava in serie A2, io ero andato a vedere la partita di un’amica alla quale avrei dovuto fare da testimone di nozze. Nella squadra avversaria c’era Olimpia che al termine del match mi fu presentata da un amico comune, Raul, che sarebbe diventato poi il padrino di battesimo di Alice. Ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati e, come si diceva allora, “ci siamo parlati”. Tutto avvenne relativamente in fretta e Olimpia è diventata mia moglie due anni dopo.
Holly è per me più che una moglie, è la luce dei miei occhi e in più, questo è lei a sostenerlo, è stata un portafortuna nella mia carriera cestistica che, a livello di Nazionale, fino a quando la conobbi non era stata proprio felicissima.
Fin dai tempi della mia prima maglia azzurra, il 21 maggio 1977, ad Ancona contro il Messico, le mie convocazioni erano sempre incerte, facevo parte di quel gruppo di pochi giocatori che, alla fine del raduno, venivano rimandati a casa o confermati. Insomma, ero sempre in bilico tra il sogno di giocare in Nazionale e la delusione di essere il primo degli esclusi.
Ma proprio in chiave azzurra, un bel regalo del destino, generoso con me dopo essere stato un po’ cattivello, fu quello di farmi esordire contro il mio idolo, Manuel Raga, la guardia messicana di Varese che quando saltava non tornava più per terra tanto era impressionante la sua capacità di restare sospeso nel vuoto. Ricordo le polemiche a Masnago, quasi un’insurrezione popolare, quando Alexander “Aza” Nikolić nel 1973 decise di tagliarlo a vantaggio di Bob Morse. Ma alla fine aveva avuto ragione il professore di Belgrado, l’inventore della grande Ignis. Bob Morse era immarcabile.
Il mio duello fondamentale, però, non è stato con Raga o Morse, ma con Franco Boselli, uno dei due gemelli del basket milanese (l’altro era Dino, mio compagno di camera a Varese). Fino all’ultimo io e Franco eravamo in corsa per la dodicesima maglia disponibile per l’Olimpiade di Mosca. Alla fine scelsero me. Olimpia me l’ha sempre detto: «Ti ha portato fortuna il mio nome». E non solo in quella circostanza, posso aggiungere io dopo tutti questi splendidi anni di matrimonio.
![]()
Io e Brian, il papà e il coach
«Te lo porto via!» mi aveva urlato Olimpia senza mezzi termini. Seguivo l’Under 13 di Pino Torinese e alla fine di una partita avevo ripreso in modo forse un po’ troppo deciso Brian, che allenavo per la prima volta, perché aveva giocato male e aveva commesso alcuni errori che proprio non mi erano piaciuti. Mi sembrava di trattarlo come tutti gli altri, ma forse esageravo e Olimpia, una volta rientrati a casa, si era infuriata.
«Te lo porto via!» disse a muso duro.
Tempo dopo, con la serie B di Castelletto Ticino di cui ero allenatore, avevamo vinto una partita proprio grazie a Brian che aveva segnato il canestro del successo a un paio di secondi dal termine. Tornando a casa (in macchina con noi perché era ancora minorenne e non aveva la patente), era rimasto seduto in silenzio per quasi tutto il viaggio fino a che, all’improvviso, a bassa voce ma con piglio risoluto, lo sentimmo dire: «Se aspettavi ancora un po’ a mettermi in campo perdevi anche questa…». C’è molto di mio figlio in questo episodio.
Insieme abbiamo vinto uno scudetto, ma quello che abbiamo percorso non è stato un cammino facile. Molti anni fa, all’inizio della mia carriera, Brian non aveva capito quale lavoro facesse esattamente suo padre: amavo curare il giardino, non avevo orari d’ufficio, non mi vestivo come gli altri papà, passavo il tempo a “giocare”, e quando gli chiedevano che mestiere facessi lui rispondeva: «Il giardiniere» o, meglio, «tappa i buchi in giardino» e in fondo non sbagliava troppo, perché amavo e amo molto la terra al punto che, da quando ho messo radici ad Alghero, mi sono addirittura messo a produrre olio e qualche bottiglia di mirto.
Buona parte del nostro tempo libero, Brian e io lo abbiamo passato insieme, spesso mi seguiva agli allenamenti in palestra, familiarizzando così con quell’ambiente. Il primo contatto con la palla a spicchi Brian lo ha avuto proprio sul parquet di Masnago, talvolta anche durante il riscaldamento prima delle partite e lì ha iniziato a gattonare. Ha preso molto da me: in tanti dicono che siamo uguali, soprattutto quando si parla di testardaggine. «Sembri tuo padre» è la frase più ricorrente, e non so se si tratti di una critica o di un complimento. Non sono d’accordo, però: io, per esempio, sapevo stare zitto, soprattutto davanti a un insegnante a scuola o a un allenatore in palestra. Lui invece è capace di non smettere mai. Quelle poche volte che l’ho messo a sedere è stato non per questioni tecniche, ma perché mi aveva realmente sfinito parlando. Gli dicevo: «Okay, Brian, hai ragione tu, intanto però vieni a sederti un po’ in panchina».
Prima della nostra storia di padre e figlio in campo c’era stata quella, altrettanto bella, di un padre, Dino Meneghin, che è arrivato a giocare nella massima serie contro il figlio Andrea. La prima volta che è successo fu a Masnago, il 14 ottobre 1990: in campo Varese, con Andrea, contro Trieste, dove giocava Dino, che vinse la partita. In quell’occasione Dino segnò 6 punti, mentre Andrea, non ancora diciassettenne, rimase in campo pochi minuti.
Alla presenza contemporanea di quei due in campo, associo anche un ricordo spiacevole: il 9 novembre 1991, di nuovo Trieste contro Varese, ancora a Masnago, mi sono rotto il tendine d’Achille e la mia carriera da giocatore si è chiusa definitivamente. Non ero più giovanissimo, sono del 1953 e andavo verso i quaranta, avevo già avuto un’ernia al disco e un crociato rotto, infortuni che avevano segnato la mia vita sportiva. Ma quella sera di novembre era stato forse un segnale del destino o del mio corpo che mi diceva “basta”, anche perché ero sceso in campo grazie a un’infiltrazione antidolorifica. L’episodio ha segnato anche una svolta nel mio atteggiamento di atleta e quando ho cominciato ad allenare mi sono ripromesso che mai e poi mai avrei fatto giocare un mio ragazzo in condizioni fisiche non perfette. Anche a costo di perdere una partita. Per la cronaca, quella sera Andrea si prese la rivincita, Varese vinse 82 a 69, anche se Dino, di nuovo, segnò più del figlio…
La mia eredità cestistica per ora è stata raccolta da Brian che forse ha voluto emulare il papà – senza dimenticare i trascorsi materni – oppure più semplicemente ha il Dna giusto. Mio figlio ha avuto la fortuna di avere i migliori maestri, Pino Pinelli alla Pallacanestro Varese e Teo Mitton al Basket Venaria, nella cintura di Torino, dove ci trasferimmo l’anno successivo alla fine della mia carriera da giocatore.
Per i primi anni lo fecero giocare come playmaker, facendolo lavorare molto su passaggio e palleggio. Poi, quando ancora andava alle scuole medie, soffrì del morbo di Osgood-Schlatter chiamato anche “il morbo della crescita”: in appena un anno e mezzo Brian si alzò di diciannove centimetri passando da poco più di un metro e settanta al metro e novanta (ora sfiora i due metri) e fu dirottato al ruolo di ala, dove gioca tuttora. In quegli anni però aveva assimilato i fondamentali del giocatore piccolo, della guardia, una caratteristica che gli è servita tantissimo perché oggi se la cava piuttosto bene sia in attacco sia in difesa, sia vicino al regista sia nei pressi del canestro.
Dopo gli anni della formazione, Brian con me in panchina ha giocato a Castelletto Ticino anche da senior, in serie B. Non entrava moltissimo, ma era ancora juniores. I dirigenti mi spingevano a farlo giocare di più ed è stato questo un leit motiv della carriera parallela della famiglia Sacchetti: sono in molti a sostenere che, ...