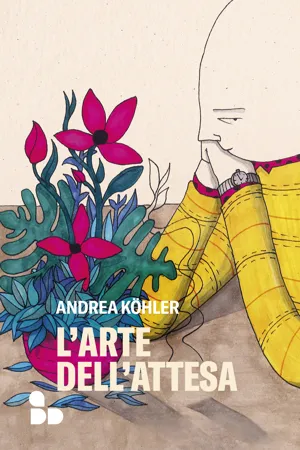![]() II. Sentire il tempo
II. Sentire il tempo![]()
Domani, bambini, qualcosa accadrà
«A mio parere i bambini sono i più bravi ad aspettare, perché ancora non diffidano (dell’attesa), perché non sono ancora costretti a condannarla come priva di valore culturale», scrive Wilhelm Genazino nel suo saggio Der gedehnte Blick [Lo sguardo allargato]. Ma anche se i bambini non considerano ancora l’attesa come tempo sprecato, nell’infanzia il più delle volte viene vissuta con un senso di impotenza. In fondo la vita ci insegna molto presto l’esercizio del rimandare: abituarci a orari decisi da altri, controllare il nostro intestino, accettare il ritmo giorno-notte. Nella vita umana, la prima lotta per il potere si svolge sul terreno dell’attesa, cercando di imporre una disciplina al corpo. Nelle primissime ore di vita dobbiamo riconvertirci in uno strumento che obbedisce all’orologio. La prima cosa a essere allenata nell’esistenza terrena è la pazienza.
«Il saper aspettare, il dover aspettare è la condizione fondamentale di ogni comprensione», scrive Genazino. Eppure nel cosmo infantile l’attesa è ancora vissuta come qualcosa di limitato. L’attenzione del bambino è «legata al piolo dell’attimo» – come lo è, secondo Nietzsche, per l’animale – e l’attesa per lui costituisce una sequenza di momenti indefiniti limitata nel tempo. Una condizione, dunque, che durante l’infanzia è spesso un tempo privo di sospetti, da riempire di sogni a occhi aperti. Le ore che non sono scandite dalle richieste degli adulti sono perciò animate da un’instancabile opera di correzione della realtà e l’attesa è la prima sperimentazione del pensiero utopistico, della resistenza contro un mondo in cui le nostre vite sono pianificate dagli altri.
Certo, quando eravamo piccoli spesso il tempo diventava anche penosamente lungo. Le ore desolate in cui seguivamo gli adulti nelle loro commissioni, la noia senza fine di prolungate visite ai parenti, durante le quali non c’era altro da fare che stare seduti in silenzio, si sono incise con chiarezza nel ricordo e alcuni sogni ci riportano questi vecchi tormenti. In piedi accanto a una finestra – istintivamente, quando si aspetta, si cerca un orizzonte aperto –, da bambini abbiamo per la prima volta preso consapevolezza del tempo a livello fisico: una cupa pressione nelle viscere, un atroce allungarsi e tendersi dalla testa ai piedi. I minuti si tramutavano in gomma da masticare, prolungandosi all’infinito, il corpo diventava un tavolo di tortura. Ma anche nell’infanzia poteva capitare di desiderare ardentemente un rinvio; chi non ricorda il violento batticuore con cui aspettavamo ansiosi che venisse scoperto un misfatto, i minuti d’angoscia durante i quali speravamo che il tempo potesse trasformarsi in un lungo non-ancora e che il nostro “crimine” prima o poi cadesse in prescrizione?
Tuttavia la messa in scena dell’attesa è tipica del primo periodo della vita. L’attesa gioiosa della mattina del compleanno o di Gesù Bambino, l’eccitazione, quando si accendono le luci nella stanza dove si distribuiranno i regali: è il classico inventario delle attese festose. Il ricordo trasforma volentieri questi momenti in idilli dell’infanzia, quando attendere e pregustare una gioia erano ancora, così pareva, una cosa sola. Ma mai l’attesa ha messo del tutto da parte, anche nelle promesse, la sua missione pedagogica. «Domani, bambini, qualcosa accadrà»: non sembra di sentire anche la bacchetta? Le attese dell’infanzia sono sempre state fragili idilli. Persino il calendario dell’Avvento lega l’attesa alla tentazione e al divieto e, nel caso la tentazione sia più forte (quella di aprire subito tutte le porticine, di saccheggiare i pacchetti), aiuta a riconoscere con amarezza che chi non sa aspettare deruba se stesso della dolce ricompensa della pazienza.
![]()
Minaccia di morte e passatempo
Nel suo Saggio sulla stanchezza Peter Handke descrive l’attesa nei bambini come un assalto da parte di una stanchezza che tutto stravolge. È una stanchezza che faceva visita all’io narrante, in particolare durante la messa di Natale, «con la virulenza di un male», e che decenni dopo risveglia ancora in lui una «improvvisa vergogna». Questa vergogna, che scaturisce dalla forma originaria di un tedio esistenziale, fa del bambino sul banco della chiesa un «esule», escluso dai rituali della devozione e della comunità. Forse in tutte le attese risiede una simile forma di esclusione. Perché anche quando aspettiamo con gli altri, ognuno aspetta da solo. Come il sonno, l’attesa non si può condividere, e quando la inganniamo insieme agli altri, per esempio giocando o raccontando delle storie, lo facciamo sempre e solo individualmente.
Di questo vive anche il ciclo di fiabe delle Mille e una notte, la classica storia del rimandare in cui la figlia di un visir, aspettando la morte una mattina dopo l’altra, rinvia il termine dell’esecuzione con il suo racconto intrecciato ad arte e sempre interrotto al momento più interessante.
Il re Shahriyar, che l’infedeltà della consorte ha trasformato in un feroce vendicatore nei confronti del genere femminile, si porta ogni notte nel letto una vergine, che al mattino fa giustiziare per non subire più l’onta dell’infedeltà. La stessa sorte dovrebbe toccare alla bella Shahrazad, che rimanda il suo termine ultimo intessendo storie meravigliose e promettendo di continuarle la sera successiva. Dopo mille e una notte presenterà al re i suoi tre figli maschi – venuti al mondo durante il tempo del racconto – e il re, ammaliato dalla sua arte di raccontare, la prenderà in sposa.
Non molte sentenze di morte hanno un così lieto fine. L’attesa della pallida ora mattutina del boia è uno scenario così spaventoso anche perché è animata da una sconvolgente solitudine, da cui il mito cristiano della crocifissione trae la sua forza; probabilmente è difficile trovare un altro passo della Bibbia che, più di quello della notte nel giardino del Getsemani, sia capace di spingersi nelle profondità dell’angoscia umana.
«Quando Gesù giunse con i discepoli nel luogo detto Getsemani, disse loro: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. Prese con sé Pietro e i due figli di Zebedèo e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino a morire. Restate qui e vegliate con me”. E, andato un po’ oltre, cadde faccia a terra e pregava: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Non però come voglio io, ma come vuoi tu”.
Tornò poi dai discepoli e li trovò addormentati. Disse a Pietro: “Così, non siete capaci di vegliare nemmeno un’ora con me? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione”» (Matteo 26, 36-41).
Lo spirito è forte, ma la carne è debole. Per tre volte Gesù trova i discepoli – che lo stanno aspettando e dovrebbero essere preoccupati per lui – sopraffatti dal sonno, finché arriva il momento in cui «il Figlio dell’Uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori». Grazie all’attesa imminente della resurrezione, la fine di Cristo è già spostata su un altro piano temporale non legato a quello terreno, tuttavia la vita e l’insegnamento stesso di Gesù di Nazareth sono sempre stati condizionati dalla breve durata della sua esistenza. «Allorché Gesù inizia, a trent’anni, la sua carriera di rabbi (maestro), mette fin dall’inizio il suo messaggio sotto il precetto di un tempo che preme senza scampo, invitando a prendere decisioni nette», scrive Harald Weinrich nelle sue considerazioni filosofico-letterarie sul tempo che stringe. Stringe a tal punto che il figlio dell’uomo assoggetta in modo esplicito anche la preghiera al bisogno di risparmiare tempo ed esprime la sua novella in brevi parabole.
Weinrich ritiene non sia possibile esprimere con concetti astratti ciò che una morte annunciata può provocare in un essere umano: solo la narrazione ci può fornire informazioni affidabili in proposito, può darcene un’intima percezione e nello stesso tempo offrirci la salvezza dal pericolo.
Rimandare il termine ultimo della nostra esistenza, nella consapevolezza della nostra finitezza è, per dirla con Marcel Proust, la legge crudele dell’arte. Il desiderio di passare il tempo dell’attesa in compagnia è forse la causa prima di ogni narrazione che, a turno, in una miriade di varianti, altro non è che la vera essenza dell’attesa. I bambini possiedono ancora il senso del tempo delle vecchie storie, quando chiedono di ascoltare continuamente le stesse fiabe, come se la ripetizione potesse garantire che la vita continua sempre uguale con il suo affidabile mormorio. Si potrebbe pensare che la società dell’intrattenimento sia una forma tardiva, priva di magia, delle fiabe delle Mille e una notte e che queste siano il preludio orientale di quelle soap che si interrompono sempre nel momento più avvincente, lasciandoci con il desiderio di sapere cosa succederà. Ma se davvero la televisione dovesse essere la nostra Shahrazad, forse non ci sarà modo di scampare a quella minaccia di morte.
![]()
Rinuncia!
Far aspettare è una prerogativa dei potenti che, temporeggiando, controllano il nostro tempo e lo consumano in modo vorace e sconsiderato. Chi ci fa aspettare celebra il suo potere sul tempo della nostra vita, e ciò che rende minaccioso quel potere è il fatto che non possiamo mai sapere se non sia proprio per questo motivo che ci tiene sulla corda. Il divieto di movimento è da sempre un privilegio patriarcale del potere. Chi fa aspettare ci relega in un luogo. Era così già nel paradiso, e la trasgressione di tale precetto sfociò nella cacciata.
Quando aspettiamo qualcuno, sperimentiamo sempre, come fosse la prima volta, che non si può andar via senza essere puniti; se lo facciamo comunque, quasi sempre ci viene impedito di tornare. È la legge del convento. Anche la prigionia è sempre caratterizzata dalla negazione della possibilità di usufruire in maniera autonoma dei propri ritmi e dei propri spazi. La prigione è quel luogo in cui persino l’interruttore della luce obbedisce a una regia estranea; il tratto totalitario dell’apparato disciplinare, che priva il detenuto di ogni secondo e di ogni movimento, è stato analizzato accuratamente da Michel Foucault in Sorvegliare e punire. Nel contesto militare, in cui l’attesa è spesso di estrema importanza strategica, anche l’esperienza al fronte consiste soprattutto, come si sa, in attese snervanti. Forse è per questo che in guerra chi diserta, ossia chi decide di andarsene prima che sia arrivato il tempo di farlo, viene punito con la morte.
Essere condannati ad aspettare, pertanto, è una maledizione, e chi la pronuncia ci tiene in pugno. Qualcuno – una persona, un’istituzione – ci impone un tempo a noi estraneo, e la cosa opprimente è proprio che il nostro senso del tempo sia in balìa di una regia estranea. L’attesa è impotenza, e il fatto che da soli non riusciamo a cambiare le cose è un’umiliazione che stravolge il nostro modo di percepire il mondo. Per questo chi aspetta ha spesso l’impressione di essere messo dalla parte del torto, di essere punito senza sapere il perché. Sta seduto ad aspettare, come sotto le percosse. È questo atteggiamento passivo, la sensazione di essere condannato, a gettare su di noi il dolore e la vergogna dell’attesa.
L’arbitrio autoritario degli apparati burocratici è diventato non a caso il simbolo del tormento dell’attesa e si è trasformato nella quintessenza degli Stati dittatoriali. L’ufficio è la vera sala d’aspetto dei tempi moderni. Qui l’assurdità dell’attesa penetra come un veleno nei nervi di chi aspetta. In un testo sugli uffici di collocamento di Berlino, Siegfried Kracauer ha descritto l’effetto demoralizzante delle sale d’aspetto pubbliche all’inizio degli anni Trenta, dove la povertà «ora fa visibilmente sfoggio dei suoi stracci rattoppati, ora, con pudore borghese, si ritira in un angolo nascosto. […] Ma se in un caso le riesce di occultarsi, con tanta maggiore sicurezza si rivela in un altro […]».
La gente avverte l’attesa come un doppio peso. Cerca di passare quel tempo assurdo in ogni modo possibile, ma, ovunque si rivolga, l’assurdità la insegue. «Può darsi che i più vecchi stringano amicizia con l’attesa come un compagno; per i giovani disoccupati è invece un veleno, che li intossica lentamente.»
Oggi la situazione dei disoccupati è diversa da allora, tuttavia l’atmosfera delle sale d’attesa omologate rispecchia ancora le condizioni sociali che vi regnano. Secondo Kracauer, bisognerebbe interpretare le immagini di questi spazi come «sogni della società», come geroglifici, decifrando i quali si metterebbero a nudo le fondamenta della società costruite anche con ciò che viene negato o intenzionalmente ignorato. Il che in questo caso significa: chi aspetta negli uffici è cortesemente pregato di non sapere con chi o che cosa avrà a che fare.
Così nelle sale d’attesa di un ufficio pubblico è sempre evidente l’intento di disciplinare coloro che aspettano: il mobilio consunto, la squallida luce al neon, i numeri assegnati per stare in fila, il penetrante odore di supplica. La squallida architettura per postulanti di ogni colore ripropone la stessa desolata realtà di quei «campi di transito» e ricoveri per rifugiati, in cui l’attesa di un futuro migliore spesso non è altro che un periodo ...