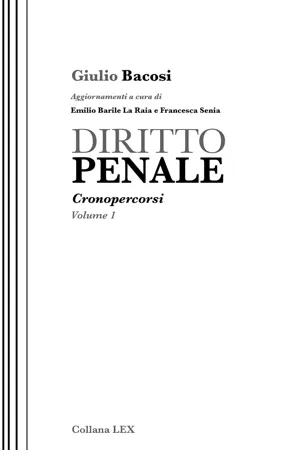![]()
Capitolo 1
HA VAGA FOGGIA DI “SANZIONE”.
MA, NELLA CICCIA, È “PENA”…
Principio di legalità europea, sanzioni penali
e sanzioni amministrative
Massima
L’abitudine a concepire il principio di legalità penale nella relativa declinazione meramente “interna” viene da tempo contraddetto da un approccio pretorio diverso che – in ottica assai più sostanziale che formale – tiene conto di quanto previsto a livello europeo “convenzionale” (CEDU), profilandosi dunque in modo vieppiù netto una “legalità europea” a connotazione sostanzialistica capace di impattare in modo consistente sui rapporti tra sanzioni interne (formalmente) amministrative e sanzioni penali collegate ai medesimi fatti imputati al soggetto agente; ne discende la stigmatizzazione “pro reo” – a tratti più severa, a tratti più blanda – di probabili “bis in idem” da parte della Corte EDU, con prospettive financo di applicazione alle sanzioni amministrative (massime laddove “para-penalmente” connotate) di principi “penalistici” ad esse ancora estranei, primo fra tutti quello della retroattività della “lex mitius”.
![]()
Crono-articolo
Originariamente la “sanzione” non corrisponde, in ambito romanistico, ad un atto compendiantesi nella risposta “secondaria” dell’ordinamento alla violazione “primaria” di una norma giuridica, la “sanctio” atteggiandosi piuttosto a clausola che è parte integrante della norma “primaria” medesima.
Nelle leggi della Repubblica, più in specie, figurano talune clausole dette per l’appunto “sanctiones legis”, che costituiscono quella parte della legge (caput) contenente prescrizioni volte ad assicurarne l’attuazione e, massime, a regolarne i rapporti con il resto dell’ordinamento già vigente; un esempio si rinviene nel c.d. caput tralaticium de impunitate, col quale – nel contesto letterale di una determinata Lex – si statuisce che colui il quale, per ottemperare alla Lex medesima appena introdotta, violi una legge precedente non può per questo essere passibile di una “sanzione” (stavolta intesa in senso moderno, ed il cui concetto è dunque genericamente ben presente ai Romani). Sono dubbi i rapporti tra questo caput e l’altro “ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset” (e dunque “sarà diritto ciò che il popolo ha deliberato per ultimo”), “capita” entrambi concernenti la successione di leggi nel tempo e la possibile abrogazione della legge precedente da parte di quella successiva.
Ancora, costituisce una sanctio nel senso anzidetto il “caput” alla cui stregua la “rogatio” (proposta di legge) va assunta come non presentata laddove risulti proibito – per l’appunto – presentarla in base al ius o al fas (regole di ascendenza “divina”): qui i Romani della Repubblica pongono dei limiti al procedimento legislativo, garantendo in particolare chi propone la legge dall’eventuale accusa di voler violare i ridetti limiti.
Qualcosa di più vicino al concetto di sanzione nel senso “secondario” modernamente inteso si rinviene nella classificazione tardo classica (Tit. Ulp., 1.1-2) onde, nello specifico ambito delle leggi c.d. proibitive (che dunque vietano di tenere un dato comportamento) vanno distinte le leges perfectae (esse proibiscono un atto disponendone, laddove compiuto, la nullità e dunque privandolo ex ante di effetti) da quelle minus quam perfectae (l’atto viene vietato, ma se compiuto non è nullo, venendo piuttosto irrogata ex post, per l’appunto, una “sanzione”, sub specie di pena pubblica o privata, al relativo autore) e da quelle imperfectae (onde l’atto vietato, laddove compiuto, non è nullo, né viene irrogata una pena pubblica o privata al relativo autore).
Tipico esempio di lex minus quam perfecta, che dispone una sanzione assimilabile a quelle moderne in ragione del compimento dell’atto vietato, è la Lex Laetoria de circumscriptione adulescentium, datata 200 a.C. circa, con la quale si irroga una pena pecuniaria a chi, nel concludere un atto a rilevanza patrimoniale, abbia abusato dell’inesperienza di un minore dei 25 anni arrecandogli pregiudizio; pena applicata su impulso di chiunque, e dunque a valle di una vera e propria azione popolare, il che connota la pertinente “sanzione” in termini decisamente “pubblicistici”.
1889
Il 30 giugno viene varato il R.D. n.6133, codice Zanardelli, di impianto liberale, che vede la luce in un contesto storico di formazione dello Stato unitario e di embrionale affacciarsi all’orbe giuridico del diritto amministrativo.
In questa fase, problemi concernenti sanzioni amministrative “parapenali” e di connessa riperimetrazione del principio di legalità non si pone ancora, prevedendosi semplicemente – all’art.1 – che a definire i fatti penalmente rilevanti e le rispettive pene sia una legge.
1930
Il 19 ottobre viene varato il R.D. n.1398, nuovo codice penale, il cui art.1 conferma che a definire i fatti penalmente rilevanti e le rispettive pene deve essere una legge. Analogamente, ai sensi dell’art.199 nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Esiste dunque una “legalità penale”, sia su crinale delle pene che su quello delle misure di sicurezza, mentre la “legalità” delle sanzioni amministrative risulta “diffusa”, dovendosi ricondurre alle singole leggi che le prevedono.
1948
Viene varata la Costituzione Repubblicana, il cui art.25 cristallizza un rigido principio di legalità – declinato, fra l’altro, in termini di riserva assoluta di legge – in materia penale, onde nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (comma 2), né può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (comma 3).
Nello stesso tempo talune norme dedicate all’azione della Pubblica Amministrazione si esprimono invece in termini di riserva di legge relativa: non già solo l’art.97, alla cui stregua i pubblici uffici sono organizzati “secondo disposizioni di legge” (in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione), ma anche l’art.23 alla cui stregua nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non “in base alla legge”.
1950
Il 4 novembre viene firmata a Roma la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
1955
Il 4 agosto viene varata la legge n.848, con la quale l’Italia ratifica la CEDU.
1957
Il 25 marzo viene sottoscritto a Roma il Trattato istitutivo della CEE, Comunità Economica Europea.
* * *
Il 14 ottobre viene varata la legge n.1203 che ratifica, tra gli altri, anche il Trattato CEE.
1959
Il 21 gennaio vengono eletti i componenti della Corte EDU.
Il 23 febbraio la Corte EDU tiene la prima seduta, che dura 5 giorni.
1976
L’8 giugno esce la storica sentenza della Corte EDU Engel c. Paesi Bassi, che vara i c.d. “Engel criteria”, canoni guida per ritrarre la effettiva natura di disposizioni di diritto interno da assumersi presidiate dalle garanzie CEDU stante il relativo afferire – prescindendo dal pertinente nomen iuris – a materia “sostanzialmente penale”.
Per la Corte EDU, al fine di verificare se un procedimento abbia o meno ad oggetto “accuse in materia penale” ai sensi della Convenzione, vanno considerarti 3 diversi fattori, muovendo dalla qualificazione data dal sistema giuridico dello Stato convenuto all’illecito contestato dal ricorrente; qualificazione (nomen iuris) la quale, nondimeno, deve assumersi avere solo un valore formale e relativo, dovendo la Corte medesima verificarne la correttezza alla luce degli altri fattori indicativi del carattere (concretamente) “penale” dell’accusa contestata.
In secondo luogo, va difatti presa in considerazione per la Corte la natura sostanziale dell’illecito commesso, vale a dire se si è di fronte ad una condotta in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale o se è invece preposta alla tutela erga omnes di beni giuridici della collettività, anche alla luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati contraenti.
Va infine considerato – per la Corte – il grado di severità della pena che rischia la persona interessata, in una società di diritto appartenendo alla sfera “penale” le privazioni della libertà personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per quelle la cui natura, durata o modalità di esecuzione non possano causare al relativo destinatario un apprezzabile danno.
In sostanza, per la Corte EDU si è al cospetto della “materia penale” – con necessità di assicurare al soggetto coinvolto tutte le garanzie che la ridetta “materia” impone – laddove si abbia a che fare con un fatto penalmente rilevante alla stregua della qualificazione (formale) prevalente degli Stati contraenti, tenendo conto altresì della natura (sostanzialmente) penale dell’infrazione commessa, nonché della natura punitiva e della gravità della sanzione applicabile, siccome diretta a fini preventivi e punitivi.
1981
Il 24 novembre viene varata la legge n.689, recante modifiche al sistema penale (c.d. legge di depenalizzazione), alla stregua del cui art.1 – significativamente rubricato “principio di legalità” – nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (comma 1), le leggi che prevedono sanzioni amministrative applicandosi soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (comma 2), con conseguente non operatività per le sanzioni amministrative del principio della retroattività della legge sopravvenuta più favorevole (al contrario di quanto accade in materia penale).
Per il successivo art.9 sul c.d. principio di specialità, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.
Vede dunque la luce una disciplina generale delle sanzioni amministrative, corredata da un precipuo “principio di legalità” di tali sanzioni non perfettamente coincidente con quello “penale” puro (massime in termini di irretroattività della lex mitius, che opera in ambito penale non opera in ambito amministrativo). Il nuovo “microsistema” sanzionatorio amministrativo si preoccupa peraltro anche di disciplinare i relativi rapporti con il diritto penale, in termini di c.d. “specialità”.
1982
Il 10 luglio viene varato il decreto legge n.429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Stando al relativo art.10, l’applicazione delle pene previste nel decreto legge non esclude l’applicazione delle “pene pecuniarie” (in realtà, sanzioni di natura amministrativa tributaria) previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, configurando dunque una deroga rispetto al generale principio di specialità...