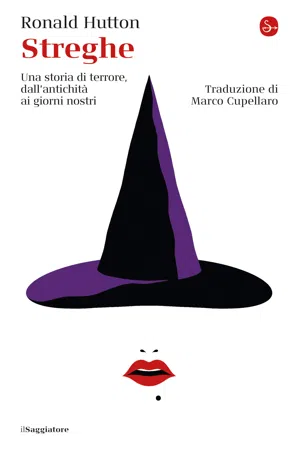![]()
1. Il contesto globale
L’importanza della ricerca di un contesto mondiale in cui inquadrare i processi per stregoneria dell’Europa moderna sta nella possibilità di individuare, attraverso questa contestualizzazione, le (eventuali) specificità europee sia di quei processi, sia delle immagini della stregoneria circolanti nell’Europa del tempo. Una simile ricerca può aiutare a rispondere alla domanda se ciò che accadde nell’Europa moderna sia da considerarsi inconsueto, in un’ottica globale, o se invece non sia stato semplicemente un’estrema manifestazione locale di cose che gli uomini fanno in moltissimi luoghi ed epoche. Prima di avviarsi su questa strada, è essenziale definire subito che cosa si cerca esattamente e quali si ritiene siano le caratteristiche di quella figura che in inglese viene chiamata witch, strega. Il significato che abbiamo scelto e indicato nelle pagine precedenti – «strega» è chi si presume compia atti di magia distruttiva – fissa la prima e principale caratteristica attribuita a coloro che furono processati per stregoneria nell’Europa moderna: il fatto di essere ritenuti una minaccia diretta per i propri simili. In moltissimi casi si pensava che quelle persone si servissero di mezzi non fisici, occulti, per arrecare disgrazie o danni fisici ad altri esseri umani; inoltre, o in alternativa, esse venivano spesso accusate di mettere a repentaglio le basi religiose e morali della società. Oltre a questo primo connotato, la figura della strega definita in quei processi, e nell’ideologia su cui si fondavano, presentava altre quattro caratteristiche peculiari. Una era l’intenzione di nuocere ai membri della propria comunità o famiglia, assai più che a sconosciuti: quella persona minacciava insomma il proprio gruppo dall’interno. Un’altra caratteristica di chi compiva atti di stregoneria era di non essere un caso isolato, unico: in altre parole, si pensava che le streghe operassero nel solco di una tradizione, usassero tecniche e risorse trasferite loro da altri, acquisendole per eredità, per iniziazione o per spontanea manifestazione delle forze cui erano connesse. La quarta componente dello stereotipo europeo della strega consisteva nell’essere bersaglio di una ostilità generale ed estremamente forte da parte della società. L’uso delle tecniche di magia attribuite alle streghe non era mai legittimato ufficialmente dall’esistenza di una faida o di una rivalità: esse erano ricondotte a un’avversione della strega per l’umanità e la società in generale, e a una sua alleanza con forze malvagie e sovrumane presenti nell’universo (ovvero, nel caso europeo, a un patto con il Diavolo dei cristiani); perciò suscitavano quasi sempre nel pubblico un moto spontaneo di furore e orrore. Infine, la quinta e ultima caratteristica che riscuoteva un generale consenso era la certezza che combattere le streghe fosse non solo necessario ma anche possibile, in vari modi: costringendole o convincendole ad annullare i loro malefici; oppure aggredendole direttamente e fisicamente al fine di ucciderle o ferirle; o ancora accusandole ufficialmente affinché la legge distruggesse i loro poteri infliggendo loro un castigo che poteva spingersi fino alla condanna a morte.
Nessuno studioso dei processi per stregoneria svoltisi nell’Europa moderna muoverà obiezioni a queste cinque caratteristiche distintive della figura della strega: l’unica perplessità riguarda semmai la loro ovvietà. Esse formano comunque una checklist abbastanza precisa delle caratteristiche fino a oggi utilizzate dalla ricerca, che può risultare utile ai fini di uno studio comparativo su scala mondiale. Il risultato di un simile studio è, per certi versi, scontato: da secoli gli studiosi dicono di aver trovato in questa o quella parte del mondo figure estremamente simili a quella che in Europa viene definita strega, e per indicare queste figure ricorrono addirittura al termine inglese witch. Ancora una volta, però, in questi necessari raffronti conviene procedere con cautela e utilizzare un campione più ampio. Inoltre, non è affatto certo che questa operazione abbia valore per gran parte degli studiosi dei processi europei per stregoneria. La storia del rapporto tra quegli studiosi e gli esperti di quella che in altre parti del mondo viene definita stregoneria è già lunga, carica di pregiudizi e con una forte componente di disaffezione. Perciò, prima di provare a fare ulteriori passi avanti, è opportuno ripercorrerla.
Storici, antropologi e stregoneria: un’amicizia finita male?
Negli anni sessanta per gli studiosi britannici un approccio globale allo studio della stregoneria era la norma, soprattutto alla luce del fatto che la maggior parte delle ricerche sul tema pubblicate intorno alla metà del xx secolo veniva da antropologi che si occupavano di società extraeuropee, perlopiù situate nell’Africa subsahariana. Gli studiosi inglesi che alla fine di quel decennio iniziarono a lavorare sui processi europei per stregoneria, oltre a utilizzare correntemente elementi antropologici nell’interpretazione dei dati europei, riconoscevano che il loro interesse per questo tema era stato ispirato dagli studi riguardanti altre aree geografiche. Gli antropologi ricambiavano la cortesia con gesti di collaborazione come l’immancabile intervento di storici europei nei loro convegni o nei volumi collettivi sulla stregoneria. Nel suo studio del 1978 sulla strega come archetipo umano Rodney Needham citò dati di fonte sia africana che europea e sottolineò come l’approccio comparativo fosse una delle componenti essenziali della sua operazione. Ma all’epoca questa visione era ormai avviata al tramonto. Essa non appariva più convincente agli storici americani, secondo cui i gruppi sociali «primitivi» africani non somigliavano granché alle culture e società, molto più complesse, dell’Europa moderna. In America anche alcuni antropologi avevano iniziato a notare, già sul finire degli anni sessanta, che il termine «stregoneria» veniva usato per etichettare fenomeni molto diversi in varie società. Nella stessa Gran Bretagna, dove la collaborazione tra storia e antropologia era all’apice, alcuni esponenti di punta di entrambe le discipline raccomandavano cautela in simili scambi.
In realtà, a condannare quell’approccio fu un’evoluzione interna all’antropologia, legata alla dissoluzione degli imperi coloniali europei e alla conseguente reazione nei confronti del quadro di riferimento tradizionale di questa disciplina, accusato di ancillarità all’imperialismo. Questa reazione era ostile sia all’imposizione di termini e concetti europei nello studio di altre società, sia alla possibilità di effettuare comparazioni tra le suddette società grazie all’imposizione di quei termini e concetti. L’ultimo grido erano le analisi di una comunità esaminata da vicino nella sua peculiarità, a partire dalle logiche interne dei suoi modelli linguistici e mentali (il che naturalmente accresceva il valore e potere del singolo studioso, che poteva rivendicare una conoscenza privilegiata della comunità studiata). All’inizio degli anni settanta questa «nuova antropologia» iniziò a diffondersi anche nelle università britanniche. Nel 1975 una studiosa americana che sosteneva questo approccio, Hildred Geertz, criticò pubblicamente Keith Thomas, il più autorevole storico inglese favorevole a un approccio antropologico allo studio della storia della sua nazione. Geertz accusava Thomas di aver preso una serie di categorie elaborate in Inghilterra dal Settecento in poi e averle trasformate in armi culturali contro altri popoli; inoltre, la studiosa americana sollevava la questione più generale della possibilità di trasformare degli elementi culturali peculiari in concetti generali per poi compararli ad altri elementi peculiari, scavalcando i confini tra epoche e continenti. In realtà, Geertz non poneva in dubbio il valore in sé di determinate categorie di ricerca, ma si limitava a raccomandare maggior cautela e spirito critico nel loro utilizzo; tuttavia, Thomas colse l’occasione di quel dibattito per invitare gli storici occidentali ad abbandonare le comparazioni con le culture extraeuropee e a concentrarsi sul contesto d’origine della terminologia da loro utilizzata, adatta a descrivere soprattutto la propria società.
In tal modo Thomas riconosceva esplicitamente la svolta dell’antropologia, la diffidenza degli antropologi verso l’uso di concetti occidentali ai fini della comprensione di culture non occidentali e la loro preferenza per l’uso dei concetti propri delle persone di volta in volta studiate. Egli prendeva atto del desiderio degli antropologi di ricostruire determinati sistemi culturali nella loro totalità, anziché importare termini utilizzati in modo irriflesso dagli storici, come «stregoneria», «credenza» o «magia», per comparare sistemi diversi. E qualora il messaggio non fosse ancora arrivato agli storici inglesi, fu un antropologo collega di Thomas all’università di Oxford, Malcolm Crick, a ribadire più volte la stessa tesi, tra il 1973 e il 1976, con specifico riferimento alla stregoneria. Crick proponeva di «dissolvere» il concetto di strega «in un quadro di riferimento più ampio», ricollegando le figure associate alla stregoneria nel mondo anglofono ad altre figure che impersonavano altri tipi di potenze occulte nell’ambito di una stessa società. Inoltre, lo stesso Crick affermava che le categorie concettuali erano talmente variabili da una cultura all’altra che non era assolutamente possibile affrontare la «stregoneria» in termini generali, e invitava gli storici inglesi a tenersi alla larga dal materiale etnografico, dichiarando (senza fornire alcuna prova) che «la stregoneria inglese non era uguale ai fenomeni etichettati in questo modo in altre culture». Gli storici della stregoneria in Europa recepirono il messaggio, e dalla fine degli anni settanta le ricerche sempre più numerose sulle credenze in fatto di stregoneria e sui processi per stregoneria nell’Europa moderna si limitarono a studi interculturali su scala continentale, o tutt’al più estesi ai coloni europei in altri continenti. E se qualche studioso provava sporadicamente a comparare materiali europei e africani, si poteva esser certi che si trattasse di una figura non particolarmente in vista né specializzata nello studio della stregoneria.
Nel 1989 una recensione dall’eloquente titolo History without anthropology dichiarava che gli antropologi erano riusciti con successo a dissuadere gli storici dall’interessarsi al lavoro antropologico sulla stregoneria. Eppure, paradossalmente, in quello stesso periodo gli antropologi stavano per cambiare di nuovo idea. In un certo senso – importante – essi non avevano mai abbandonato l’approccio comparativo, né la terminologia occidentale criticata da molti di loro negli anni settanta: perfino chi usava termini autoctoni per designare pratiche magiche di popoli non europei continuava a parlare, nel titolo del proprio saggio, di witchcraft e magic; anzi, la maggior parte degli antropologi usava quei termini inglesi anche nell’introduzione dei propri lavori, e alcuni di loro li utilizzavano nel quadro di riferimento generale dello studio locale, riconoscendo in tal modo il significato di quei termini per il pubblico anglofono come una sorta di «valuta internazionale» semantica. Negli anni novanta alcuni dei principali antropologi iniziarono a dirsi concretamente interessati a rinfrescare la collaborazione con gli storici dell’Europa. Un’antropologa criticò l’ossessione dei suoi colleghi per il lavoro olistico sul campo in piccole comunità, bollando l’osservazione partecipata come «angusto accademismo» che rischiava di tagliar fuori l’antropologia dalla storia delle religioni. Un’altra antropologa, partendo dagli atteggiamenti verso la stregoneria e la lebbra rispettivamente nell’Africa attuale e nell’Europa dell’era moderna, mise a confronto le rispettive strategie di rifiuto e i fenomeni di caccia alle streghe. Una terza studiosa dichiarò che l’immaginario della stregoneria nell’Europa moderna era molto affine ad alcune credenze africane e criticò apertamente la tesi secondo cui il termine «stregoneria» era privo di qualsiasi valore di confronto interculturale, e si spinse a dichiarare che l’antropologia aveva il dovere di effettuare simili comparazioni. Parallelamente, anche un sociologo inglese, Andrew Sanders, sulla stessa linea, pubblicò nel 1995 una indagine mondiale sulla figura della strega in cui utilizzava sia documenti storici europei che testimonianze etnografiche contemporanee. L’evoluzione più significativa in tal senso si ebbe tra gli africanisti, con l’invito a studiare la stregoneria con rinnovata attenzione per i confronti interculturali. Questa tendenza fu favorita da una delle caratteristiche più dolorose, e (per molti) sorprendenti, degli stati postcoloniali nel continente africano: una recrudescenza della paura verso la stregoneria e delle aggressioni alle presunte streghe, che, come vedremo più avanti, era una reazione al processo di modernizzazione seguito alla proclamazione dell’indipendenza. Gli antropologi che studiavano questo fenomeno si ritrovavano a loro volta a dover spiegare ai loro contemporanei occidentali che in Africa la persistenza di credenze sulla stregoneria non andava attribuita a una qualche innata propensione dei popoli africani alla «superstizione» o all’«arretratezza». Questa strategia condusse a porre ancora una volta l’accento sulla diffusione di credenze analoghe in ogni regione del pianeta, compresa l’Europa ancora in tempi relativamente recenti, e suggerì di rispolverare il metodo comparativo: espliciti appelli in tal senso furono lanciati, a metà degli anni novanta, da alcuni africanisti di primo piano. Un tipico esempio di questo filone fu l’influente studio sul Camerun di Peter Geschiere, che concludeva: «queste nozioni, che oggi in tutta l’Africa vengono indicate con il termine “stregoneria”, riflettono una serie di problemi comuni a tutte le società umane». Geschiere invitava gli antropologi a studiare le ricerche sui processi europei per stregoneria, definendo questo loro disinteresse «ancora più sconcertante» di quello degli storici europei per le possibili analogie con l’Africa. Nel criticare quegli studiosi della storia moderna europea che asserivano una radicale differenza tra le società africane contemporanee e quelle da loro analizzate, lo stesso autore faceva notare che agli occhi delle élite di amministratori e coloni europei l’Africa agli inizi del Novecento non era socialmente e culturalmente meno complessa dell’Europa cinquecentesca. E nel 2001 i curatori di una importante raccolta di saggi sulla stregoneria in Africa raccomandavano agli studiosi di non circoscrivere lo studio delle credenze sulla stregoneria a «una determinata area del mondo o epoca storica». L’adozione di una prospettiva multiculturale era ormai assolutamente irrinunciabile per gli studi sulle città africane contemporanee: ne è un esempio Soweto, sobborgo di Johannesburg, dove negli anni novanta l’immaginario sulla stregoneria era una mescolanza di idee provenienti da vari gruppi di popolazione nativa e di altre introdotte dai coloni olandesi e inglesi e basate sugli stereotipi dell’Europa moderna.
Il riavvicinamento tra storici e antropologi è rimasto, comunque, un’operazione estremamente difficile. Nonostante gli inviti a tornare al metodo comparativo, concretamente pochi africanisti hanno esaminato con autentica attenzione gli studi sulla figura della strega in altre aree o epoche. Anche chi provava a citare fonti relative all’Europa moderna appariva di solito del tutto ignaro di ciò che era stato pubblicato dopo i primi anni Settanta: la successiva fioritura internazionale di ricerche sempre più sofisticate sembrava far parte di un altro mondo. Quanto agli storici della stregoneria, quasi tutti avevano smesso di seguire l’antropologia, partendo dal presupposto che fossero gli stessi antropologi a dissuaderli. Tornare dopo o...