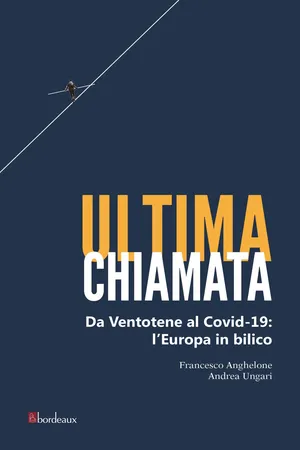![]()
Prima parte
Da Ventotene al Trattato costituzionale
![]()
L’Europa tra le due guerre mondiali
All’indomani della Prima guerra mondiale il continente europeo uscì profondamente scosso sia dalle vicende militari, con oltre sedici milioni di morti, sia dalla diffusione della Spagnola, una pandemia influenzale iniziata nel 1918 che produsse tanti decessi quanti ne aveva causati il conflitto. Malgrado il ridimensionamento demografico, economico e militare causato dalla guerra, l’Europa mantenne la sua centralità politica nel periodo tra le due guerre mondiali, confermata dal proliferare di nuovi Stati. In effetti, la mappa della nuova Europa uscita dalla Conferenza di pace del 1919-20 vedeva il prevalere di due fattori concomitanti e, per certi versi, politicamente intrecciati: la scomparsa degli Imperi sovranazionali e la conseguente affermazione degli Stati nazionali. Sulle ceneri degli ex Imperi molti popoli riuscirono ad ottenere la propria dimensione statuale, svincolandosi da strutture politiche ereditate dall’Alto Medioevo e che avevano dominato la scena europea per secoli. Veniva a compimento quel processo di affermazione delle idee nazionali che era partito dalle riflessioni dei pensatori illuministi e che aveva trovato modo di concretizzarsi nel corso dell’Ottocento grazie agli ideali della Grande Rivoluzione e delle baionette napoleoniche. Un percorso che grazie alla diffusione del Romanticismo e delle varie insurrezioni patriottiche aveva contestato progressivamente gli ideali della Restaurazione e dell’Ancien Régime, coniugandosi quasi ovunque a quelli del liberalismo politico (Belgio, Grecia, Italia, Spagna) oppure scegliendo la via dell’autoritarismo (Germania). Questa prima fase di affermazione degli Stati nazionali si concluse, in effetti, nel 1870, con il compimento dell’unificazione tedesca e l’acquisizione di Roma al Regno d’Italia.
Nonostante gli anni successivi, fino alla Grande guerra, non vedessero la nascita o l’indipendenza di nuovi Stati come nel periodo tra il 1830 e il 1870 (eccettuata l’indipendenza della Norvegia dalla Svezia nel 1905), essi furono caratterizzati da ripetute tensioni nazionali che si concentrarono nello spazio balcanico, dove convergevano gli interessi di tre Imperi: quello austro-ungarico, quello russo e quello ottomano. E non è un caso che la scintilla della Grande guerra, seppur motivata da attriti tra le grandi potenze accumulatisi negli anni precedenti, provenisse proprio da un’area che era alla ricerca della propria identità, a dispetto delle costruzioni sovranazionali nelle quali era stretta.
Il tema delle nazionalità, poi, fu abilmente sfruttato dalle potenze dell’Intesa, soprattutto all’indomani dell’uscita di scena della Russia zarista, anch’essa Impero multietnico; sicché a partire dal 1918 l’Intesa, seppur in maniera molto strumentale, agitò questo tema al fine di accelerare lo sgretolamento dell’Impero sovranazionale per eccellenza, quello austro-ungarico. In tal modo, malgrado tutte le contraddizioni derivanti dalla complessità della politica che si consumarono al tavolo della pace, è innegabile che la Prima guerra mondiale segnò il trionfo del principio di nazionalità. Un principio, però, che aveva perso molto del carattere democratico e liberale degli anni centrali dell’Ottocento, contraddistinguendosi per un più marcato accento nazionalistico che, come vedremo, porterà con sé delle conseguenze. Se il sentimento nazionale/nazionalistico vide la propria affermazione all’indomani della conclusione del conflitto, la società europea tra le due guerre mondiali fu caratterizzata da profonde contraddizioni.
A una ripresa del sentimento religioso dovuto alle tragedie della guerra si affiancò, ad esempio, l’avvio di un processo di scristianizzazione del continente che prendeva le mosse proprio dalla constatazione del baratro in cui esso era giunto.
La scomparsa di Imperi sovranazionali autoritari e l’affermazione di nuovi Stati, soprattutto repubbliche, fece guardare con speranza al futuro della democrazia, ma tale aspettativa fu da subito offuscata dall’affermazione di regimi fascisti, clerico-autoritari o militari che, al 1929, aveva riguardato quasi tutti gli Stati europei. Il profondo pacifismo che serpeggiò in tutte le opinioni pubbliche, e che non da ultimo determinò la politica di appeasement di Parigi e di Londra verso la politica nazista, si affiancò alla ripresa di un accentuato militarismo che si espresse non solo con l’affermazione di regimi militari, ma anche, da un certo punto in poi, con una ripresa della corsa agli armamenti. Contraddizioni evidenti, alle quali si aggiunse la sfida che al liberalismo e alla democrazia, apparentemente trionfanti, fu portata dalle “novità” politiche che si affermarono tra le due guerre, ossia il fascismo, il comunismo e il nazismo. Una sfida che veniva condotta sul terreno dell’efficientismo organizzativo, vero o presunto che fosse, della rapidità decisionale, in assenza di opposizioni politiche, del consenso delle rispettive opinioni pubbliche, assoggettate a un controllo poliziesco; una sfida che senz’altro ottenne, per certi versi, indubbi successi e che fece proseliti anche in quei Paesi dove la pratica del liberalismo politico era più radicata e profonda, come l’Inghilterra e la Francia.
Una situazione complessa, dunque, quella europea tra le due guerre mondiali, che però non deve offuscare l’importanza che ebbe, proprio in questa fase, la nascita di speranze e di progetti per cercare di mettere fine alle guerre e di risolvere le tensioni ancora esistenti tra gli Stati. Il più importante di questi progetti trasse le proprie origini dall’idealismo politico del Presidente degli Stati Uniti, Thomas Woodrow Wilson, che, a conflitto in corso, elaborò i cosiddetti “Quattordici punti” che rappresentavano una summa di princìpi ispirati al concetto di nazionalità, al liberalismo politico e al liberismo economico. E fu proprio su questi ultimi che, seppur in maniera contraddittoria, si basarono i rappresentanti di Parigi per ridisegnare la mappa dell’Europa.
Accanto a questi princìpi, il Presidente statunitense propose la creazione della Società delle nazioni (Sdn), ossia di un consesso mondiale che doveva favorire l’intesa tra gli Stati ed evitare il ripetersi di guerre, scongiurandole attraverso dei meccanismi di arbitrato e di mediazione. Tale organizzazione, purtroppo, sin da subito operò senza il sostegno del Paese che l’aveva proposta, gli Usa, che non vi parteciparono perché dal 1920 essi tornarono a una politica di isolazionismo che li avrebbe allontanati dal continente europeo. Nonostante ciò, la Sdn operò fattivamente per tutti gli anni Venti del Novecento, ottenendo anche dei successi nel risolvere alcune controversie territoriali sorte nel frattempo; certo è che al suo interno cominciò ben presto a emergere il ruolo preminente di Inghilterra e Francia, a discapito dell’altra vincitrice della Grande guerra, l’Italia, che si era avviata su un percorso che l’avrebbe rapidamente portata fuori dall’alveo degli Stati liberali.
In effetti, malgrado i successi ottenuti dall’organizzazione, era chiaro che la politica internazionale era ancora nelle mani degli Stati nazionali e, soprattutto, di quelli che potevano imporsi maggiormente; tant’è che i più importanti trattati degli anni Venti, la Conferenza per il disarmo navale di Washington (1921-22), il Patto di Locarno (1925) e il Patto Briand-Kellog (1928), furono determinati dalla volontà dei singoli Stati di sanare i perduranti dissidi.
Accanto all’attività altalenante della Sdn si cominciarono a diffondere in quel periodo correnti di pensiero che, da un lato, si soffermavano sulla crisi dell’Europa e, quindi, sulla sua inevitabile decadenza, che videro protagonisti scrittori quali Oswald Spengler, André Gide e Thomas Mann, e, dall’altro, che si concretizzarono nell’iniziativa del conte Richard Coudenhove-Kalergi che, guardando agli Stati Uniti come modello di riferimento, invitava gli Stati europei a superare i vecchi rancori e a costituirsi in blocco, anche per meglio fare fronte al dilagare del comunismo. Fu così che egli promosse il primo Congresso Paneuropeo che si svolse a Vienna il 4 ottobre 1926; primo tassello di un movimento al quale aderirono eminenti personaggi dell’epoca come i politici Aristide Briand e Gustav Stresemann e l’economista John Maynard Keynes.
Sia il movimento Paneuropeo sia la Sdn non ressero, però, di fronte al brusco risveglio causato dal crollo di Wall Street del 1929; la crisi di sovrapproduzione e la bolla inflazionistica che era scoppiata negli Usa ben presto si riversarono in Europa in considerazione della già avviata interconnessione economica tra le due sponde dell’Atlantico. Le banche statunitensi, infatti, si erano molto esposte in investimenti nelle economie europee, soprattutto in Germania; pertanto, la necessità di riottenere rapidamente i prestiti concessi condusse molte aziende e molte istituzioni bancarie al fallimento, come l’importante Banca austriaca Credit-Anstalt. Le conseguenze di tale crisi operarono su tre livelli.
A livello economico, ovviamente, non ci fu una risposta comune da parte degli Stati europei, e sarebbe stato francamente difficile in quel periodo; tutti, però, alla forte inflazione che si sviluppò sul continente risposero nell’ottica del contenimento della spesa pubblica e del più rigido monetarismo. Questa linea di politica economica, in realtà, non ottenne i frutti sperati, tant’è che si può dire che gli Stati europei non uscirono mai completamente dalla crisi economica del 1929, che li accompagnò fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Non è un caso che il pensiero dell’economista britannico Keynes trovò applicazione concreta negli Usa, i quali, nonostante fossero pesantemente colpiti dalla crisi, attraverso una politica di deficit spending e di vaste opere pubbliche riuscirono a rilanciare l’economia.
A livello sociale, la crisi colpì l’Europa in maniera molto dura, provocando una fortissima disoccupazione, mancanza di cibo e stenti fortissimi nelle classi più disagiate, ma anche nella piccola e media borghesia. Tutto ciò favorì un’atmosfera cupa e di fondamentale disorientamento collettivo, inasprendo i rapporti di classe e favorendo il serpeggiare di sentimenti, come è ovvio, ben lontani dai canoni della solidarietà. Una situazione che i governi europei non riuscirono a fronteggiare in maniera compiuta, adottando politiche di taglio della spesa pubblica che certo non alleviarono le condizioni di vita delle popolazioni.
A livello politico, le conseguenze furono ancora più dirompenti. Il difficile equilibrio europeo che si era raggiunto a partire dal 1924-25 andò incontro a un progressivo deterioramento, determinato dal riemergere dei mai sopiti contrasti nazionali e dall’aggressiva politica condotta dai regimi autoritari e totalitari. In effetti, le contraddizioni con le quali si era applicato il principio di nazionalità a Parigi, oltre a causare lo spirito di rivalsa degli Stati usciti sconfitti dalla Grande guerra, esplosero sull’onda della crisi economica, alimentando rivalità e tensioni sempre meno risolvibili nel quadro della Sdn e del dialogo europeo. La presa del potere da parte di Adolf Hitler in Germania (1933), diretta conseguenza della crisi economica, alterò profondamente l’equilibrio europeo e mondiale, dal momento che alla base dell’ideologia nazista vi era una completa rivisitazione della cartina del continente. La considerazione della necessità di rivedere le clausole del diktat del 1919, considerate inique, si accompagnava a un esacerbato nazionalismo e alla volontà di riunire tutti i popoli tedeschi in un unico grande Reich, creando per esso uno spazio vitale verso l’Est Europa, abitata da popolazioni slave che, nella visione hitleriana, erano da considerarsi inferiori.
Ad assecondare Hitler in questa politica di conflittualità diplomatica intraeuropea, ci fu Benito Mussolini che, proprio nel corso degli anni Trenta, diede un impulso maggiormente aggressivo alla politica estera del fascismo, attaccando l’Etiopia nel 1935, Paese membro della Sdn di cui faceva parte anche l’Italia, e occupando l’Albania nel 1939. L’aggressività in politica estera, in realtà, aveva un obiettivo di politica interna, volto ad accentuare la presa del regime sul Paese in una direzione totalitaria che, anche a causa dell’andamento militare della Seconda guerra mondiale, non fu mai completamene raggiunta.
A complicare il quadro, intervenne la Guerra civile spagnola (1936-39) che vide emergere la figura di Francisco Franco e l’instaurazione di un regime dittatoriale in Spagna che, al pari di quello portoghese di Salazar, avrebbe contraddistinto la penisola iberica fino alla metà degli anni Settanta.
A questa aggressività degli Stati autoritari/totalitari le potenze democratiche europee, Inghilterra e Francia, risposero in maniera contrastante. Prima di tutto perché nelle proprie opinioni pubbliche forte era il desiderio di pace e, quindi, di non ripetere l’ecatombe della Prima guerra mondiale; in secondo luogo, perché all’interno di questi due Paesi non poche erano le correnti di simpatia nei confronti dei modelli dittatoriali citati. Questi ultimi erano considerati più efficienti rispetto alle “decadenti democrazie” e, soprattutto, maggiormente in grado di difendere il continente da quello che era ritenuto il pericolo fondamentale, ossia la diffusione della rivoluzione bolscevica. In effetti, la politica di tutte le potenze europee verso l’Unione sovietica (Urss) era stata sempre quella di contenerne l’espansione; sebbene non fossero mancate relazioni economiche e commerciali tra i vari Stati e Mosca (basti pensare alla Germania della Repubblica di Weimar) era chiaro che il comunismo era vissuto dalle classi dirigenti europee come il pericolo maggiore. Questo atteggiamento ostile e la generale avversità ad accordi con Mosca, fu ripagata dal leader sovietico Josif Stalin con la conclusione di due trattati, uno con la Germania (1939) e uno con il Giappone (1941), che giustamente sono stati indicati come il via libera che i due Paesi del Patto Tripartito Berlino-Roma-Tokyo aspettavano per scatenare la Seconda guerra mondiale.
Nello scenario descritto, è chiaro che le voci che contavano sulle capacità di intervento della Sdn o che invocavano la necessità degli Stati Uniti d’Europa non potevano che soccombere di fronte al dirompere del nazionalismo che avrebbe fatto sprofondare l’Europa e il mondo in una nuova catastrofica guerra.
La ricostruzione dell’Europa e l’avvio del percorso comunitario
Il titolo di un film di Roberto Rossellini, Germania anno zero, potrebbe essere tranquillamente utilizzato per far co...