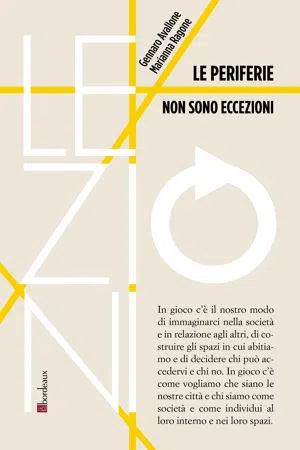
eBook - ePub
Le periferie non sono eccezioni
Per una critica dei modi di guardare e giudicare
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Le periferie non sono eccezioni
Per una critica dei modi di guardare e giudicare
Informazioni su questo libro
In gioco c'è il nostro modo di immaginarci nella società e in relazione agli altri, di costruire gli spazi in cui abitiamo e di decidere chi può accedervi e chi no. In gioco c'è come vogliamo che siano le nostre città e chi siamo come società e come individui al loro interno e nei loro spazi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Le periferie non sono eccezioni di Gennaro Avallone,Marianna Ragone in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Sociologia urbana. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Sociologia urbanaIntroduzione1
Quando un femminicidio o una violenza dettata dall’omofobia o dalla transfobia si verificano in aree urbane del territorio italiano che sono state consegnate all’opinione pubblica come spazi pericolosi e periferie degradate, la narrazione che accompagna queste azioni si ripete solitamente uguale a se stessa. La colpa è della periferia, perché è caratterizzata da disoccupazione, dispersione scolastica e mancata presenza del controllo dello Stato ed i suoi abitanti sono privi di cultura, arretrati, poveri.
Questo racconto delle periferie, fondato sulla loro riduzione ma anche sulla loro spettacolarizzazione, descritte come un mondo alieno, esotico, in cui accadono cose eccezionali, assenti altrove, nasconde numerose insidie, a partire dal fatto che non fa comprendere le analoghe violenze che si verificano in contesti spaziali differenti. Al tempo stesso, esso fa dimenticare che questi tipi di violenza non sono la manifestazione di arretratezza, ignoranza o bassi titoli di studio – secondo la lettura stereotipata che si dà degli abitanti delle periferie e come se la mancanza di cultura formalizzata fosse di per sé un indicatore di un potenziale di violenza maggiore della media della popolazione – ma sono la concretizzazione di un modo di definire donne, persone trans e omosessuali come inferiori. In questo senso, i femminicidi e, più in generale, le violenze contro i corpi femminilizzati assecondano una costruzione socio-politica che trova le sue radici nei rapporti patriarcali, che non sono associabili a specifiche aree socio-spaziali, ma riguardano i rapporti di potere complessivi presenti nella società e nelle sue istituzioni. Come scrive l’antropologa Rita Segato (2016, 97): «così come comprendere la storia del patriarcato vuol dire capire la storia della sfera pubblica e dello Stato, nella stessa maniera, e al centro di tutte le questioni, capire le forme della violenza di genere oggi significa comprendere ciò che attraversa la società nel suo insieme».
Comprendere che le periferie non sono un’eccezione dal punto di vista dei rapporti di potere e di violenza costituisce la sfida di questo testo, che si pone come finalità generale quella di proporre una critica dei modi di guardare e giudicare sia le aree socio-spaziali descritte come periferiche sia le violenze di genere nella società italiana odierna.
La domanda che accompagna l’intero testo è la seguente: è possibile colpevolizzare le periferie e chi vi abita se questi tipi di violenze si esercitano in tutta Italia, all’interno di riferimenti culturali comuni all’intera società? Per rispondere bisogna porsi altri due interrogativi. Il primo riguarda le funzioni che svolgono lo Stato, la scuola ed i mezzi di comunicazione nei riguardi sia delle violenze di genere sia delle condizioni di vita nelle aree periferiche. Il secondo si riferisce alla storia della produzione dei quartieri di periferia e delle più ampie trasformazioni strutturali che hanno attraversato la società e le città italiane nei decenni più recenti.
L’insieme di questi aspetti viene affrontato nelle diverse parti che compongono il libro. Nel primo capitolo, si propone una definizione delle periferie e, soprattutto, si mette in evidenza l’importanza che ha avuto nel contesto italiano la produzione pubblica dei quartieri di edilizia popolare. L’attenzione si sofferma, di conseguenza, sulle responsabilità delle istituzioni statali e locali negli esiti (positivi e problematici) di questa politica, che, specialmente nel caso delle aree di edilizia economica e popolare, hanno spesso prodotto per legge contesti sociali di difficoltà.
Il secondo capitolo è dedicato a individuare i principi teorici che hanno guidato l’urbanistica razionalista egemone durante il Novecento, evidenziando come la crisi della casa pensata come macchina dell’abitare iniziata dalla fine degli anni Settanta non abbia trovato ancora alternative capaci di una nuova urbanistica, cioè di un sapere e di un insieme di politiche e pratiche capaci di rispondere alla domanda su come si produce una città ed un abitare per tutta la popolazione.
Il terzo capitolo si concentra sul processo e sulle pratiche di spettacolarizzazione delle periferie, i cui effetti sono quelli di ridurne la complessità e l’eterogeneità interna per lasciare spazio ad una rappresentazione semplificata, che ne appiattisce la storia e la comprensione.
Il quarto capitolo analizza l’immaginario sociale che è stato costruito intorno alle periferie e le ripercussioni che questo ha avuto sulla loro conoscenza e sulle decisioni politiche che le hanno riguardate negli ultimi decenni.
Il quinto capitolo si sofferma sulla violenza di genere e la sua, pretestuosa, relazione con le aree periferiche, evidenziando quanto essa sia, invece, connessa con i rapporti tra i generi in maniera generalizzata.
Infine, nel capitolo conclusivo si ricorda la costruzione sociale e politica delle periferie come aree esotiche interne, rilevando la necessità di andare oltre le rappresentazioni consolidate nel sistema dell’informazione sulle aree periferiche e la violenza contro le donne e i corpi femminilizzati, a partire da una critica pratica della loro spettacolarizzazione.
1 Il testo è stato elaborato in maniera congiunta dai due autori. Nello specifico, Marianna Ragone ha scritto i capitoli 4, 5 e 6; Gennaro Avallone ha scritto i capitoli 1, 2 e 3. L’introduzione è stata scritta da entrambi.
Capitolo 1. Di cosa parliamo, quando parliamo di periferie
1. Introduzione: lo spazio ed i suoi significati
Lo spazio può essere pensato ed osservato analiticamente da tre punti di vista distinti tra loro, ognuno dei quali ne sottolinea alcune caratteristiche. Premettendo che «è fondamentale riflettere sulla natura dello spazio se vogliamo capire i processi urbani sotto il capitalismo», David Harvey (2006, 271-273) ha proposto di distinguere tra spazio assoluto, spazio relativo e spazio relazionale. In questa tripartizione, lo spazio assoluto «è fisso e noi registriamo o pianifichiamo gli eventi all’interno della sua cornice. Questo è [...] solitamente rappresentato come una griglia preesistente e inamovibile, suscettibile di misurazioni standardizzate e aperta al calcolo». Lo spazio relativo è caratterizzato «in un doppio senso: che ci sono molteplici geometrie tra cui scegliere e che la cornice spaziale dipende in modo cruciale da ciò che è quello che viene relativizzato e da chi». Infine, «la visione relazionale dello spazio sostiene che non esiste una cosa come lo spazio al di fuori dei processi che lo definiscono. I processi non si verificano nello spazio, ma definiscono il proprio quadro spaziale».
Nell’analisi di Harvey, questa tripartizione si incrocia con quella proposta da Henry Lefebvre, secondo cui lo spazio è percepito (spazio materiale), concepito (rappresentazione dello spazio) e vissuto (spazi di rappresentazione). Il primo, lo spazio materiale, costituisce il mondo dell’interazione tattile, è lo spazio dell’esperienza. Il secondo, lo spazio rappresentato, è quello che riflette le realtà materiali in rappresentazioni astratte. Il terzo, gli spazi di rappresentazione, è l’insieme delle immaginazioni, paure, emozioni, fantasie e sogni che formano parte del modo in cui viviamo nel mondo.
Lo spazio, dunque, non è una dimensione semplice né lineare. Esso appare, piuttosto, come una matrice che può assumere diversi significati in base al punto di osservazione. Ciò che risulta rilevante è che lo spazio guardato dal punto di vista assoluto assume caratteristiche apparentemente ad esso intrinseche, che fanno perdere di vista la sua storicità (il fatto che esso cambia nel tempo), la sua relatività (il fatto che ogni porzione di spazio ha caratteristiche e significati che dipendono dalla sua relazione con il resto dello spazio) e la sua dimensione simbolica (il fatto che a ogni parte dello spazio vengono associati valori, sentimenti, significati, anche divergenti tra loro, dai diversi individui, gruppi e attori sociali che li vivono o attraversano). Dunque, ogni porzione di spazio può essere compresa solo andando oltre la sua fenomenologia immediata e collegandola alla sua storia, e a quella del più ampio spazio in cui essa si è svolta, così come ai rapporti che essa vive con il resto dello spazio con cui è in relazione.
2. Periferie e centri: definizioni possibili
Se questo tipo di approccio alla comprensione dello spazio viene applicato allo studio delle periferie si comprende il fatto che esse non possono essere osservate come realtà dotate di una specifica e definitiva essenza, ma vanno osservate in maniera relazionale, in connessione con la restante parte dello spazio e, soprattutto, con il centro, il polo opposto a cui le periferie sono costitutivamente, e storicamente, collegate. Sul piano logico, oltre che relazionale, se c’è un centro allora c’è una periferia, fino al punto di poter dire che posto un centro, tutto il resto dovrebbe essere periferia, sempre più estrema quanto più la distanz...
Indice dei contenuti
- Introduzione