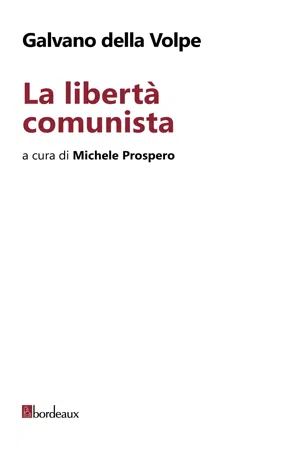III. L’«uomo totale» marxiano in quanto persona storica, sociale, e il suo «libero sviluppo e movimento». La nuova problematica
1. Non è possibile cogliere in tutta la sua portata la concezione marxiana filosofica della persona e della libertà se non partendo, naturalmente, dai suoi principi: dai concetti i più generali, di «uomo», «natura», «società», «lavoro» e «prassi rivoluzionaria» (che si trovano nei postumi Manoscritti economico-filosofici, del 1844, e nella Ideologia tedesca, I, Feuerbach, del 1845-6, editi da Adoratskij nella Marx-Engels historisch-kritische Gesamtausgabe, Berlin, 1932, I, 3, pp. 29-172, e I, 5, pp. 7-67).
Cominciamo dal principio: dall’analisi del concetto di uomo. L’uomo, dice Marx, «è immediatamente un ente naturale [Natur-wesen]» (I, 3, p. 160: corsivo del virgolato sempre di M.): ossia è particolare, è particolarità. Perciò è un ente «passivo, dipendente, limitato», cioè finito: e in quanto passivo è «un ente appassionato», anzi «la passione è forza sostanziale dell’uomo» (pp. 160-1). Contro Hegel, che riduce l’uomo a una «astrazione dell’uomo», alla «coscienza di sé», al pensiero o sapere, Marx cerca aristotelicamente «l’uomo reale», ch’è, anzitutto, «natura», oggettività, materialità, particolarità insomma. È chiaro che l’hegeliana «coscienza di sé» non può esteriorizzarsi che in una «cosa astratta», la «materialità» (Die Dingheit), appunto un’«astrazione», non in una «cosa reale». Infatti, «la “materialità “ non è assolutamente nulla di autonomo [Selbständiges], di essenziale [Wesentliches] rispetto alla “autocoscienza”, ma semplicemente una cosa creata, qualcosa di posto da essa [...]. L’uomo reale, invece, crea e pone degli oggetti solo in quanto esso è posto da oggetti, in quanto è originariamente natura [...]. Esso, nell’atto di porre qualcosa, non esce, dunque, dalla sua attività pura per creare l’oggetto, bensì il suo prodotto oggettivo manifesta semplicemente la sua attività oggettiva, la sua attività in quanto attività di un ente naturale, oggettivo [...]. Essere oggettivo, naturale, sensibile e avere altresì un oggetto, una natura, un sensibile fuori di sé, oppure essere noi stessi oggetto, natura, senso, è la stessa identica cosa [...]. Un ente che non ha oggetto fuori di lui non è un ente oggettivo: ma «un ente non oggettivo [non particolare] non è un ente» (pp. 159-61). Notiamo subito il carattere di vero e proprio criterio unitario, filosofico, che tende ad assumere la categoria marxiana della «natura», in quanto essa abbraccia, nel significato di particolarità, sia l’aspetto subiettivo che quello obiettivo della natura.
D’altra parte, continuando, «l’uomo non è soltanto un ente naturale [particolare], ma è anche un ente naturale umano, cioè un ente che esiste a se stesso [riflesso in sé, pensante], dunque un ente generico [Gattungswesen], e come tale deve confermarsi e affermarsi tanto nel suo essere che nel suo sapere» (p. 162). Ossia è ente generico in quanto «esso si rapporta a sé come a un ente universale [einem universellen] e però libero» (p. 87): e questa è la sua differentia specifica: l’universalità. Formulazione marxiana dell’homo animal rationale. «L’uomo – in qualsiasi grado sia un individuo paticolare e pur essendo la sua particolarità che fa di lui un individuo [...] – è parimente la totalità ideale» (p. 117).
Concludendo l’analisi: l’uomo è «un ente generico determinato [ein bestimmtes Gattungswesen]», naturale (ivi): come dire che è un composto di particolarità o natura e genericità. Ma questa formula del composto o sinolo marxiano ha un senso preciso solo a patto che sia risolta nell’altra: che «l’individuo [umano] è l’ente sociale» (ivi). Perché solo in quest’ultima si rivela a) che la genericità o universalità è la differenza specifica dell’uomo rispetto agli altri enti naturali o particolari; b) come l’umanità dell’uomo, la genericità o universalità, si attui soltanto nel suo rapporto alla naturalità o particolarità ch’è pur qualcosa di «autonomo»; c) come tale rapporto sia possibile soltanto mediante la socializzazione (universalizzazione) della natura, mediante il costituirsi, insomma, di società o comunità verace. Si tratta, in altri termini, di vedere la verità del composto ch’è l’uomo in questo; nell’esser uomo-natura e però ente sociale. Accettiamo come un’ipotesi da verificare questo singolare composto (di distinti, diciamo) e vediamolo alla prova del problema umano per eccellenza: il problema della persona o libertà): se esso sia criterio superiore a quelli tradizionali per la soluzione di tal problema. Vediamo perciò, passando dall’analisi alla sintesi, come si configuri il rapporto in cui si trovano fra loro gli elementi del sinolo, l’umanità o universalità e la natura o particolarità.
«L’essere umano della natura – afferma Marx – non c’è se non per l’uomo sociale; è in questo modo che c’è un legame della natura con l’uomo: è per l’esserci dell’uomo per un altro e dell’altro per lui; e solo in quanto elemento vitale dell’umana realtà la natura è fondamento [Grundtage] della esistenza umana dell’uomo. Solo così l’esistenza naturale dell’uomo è la sua esistenza umana, e la natura è divenuta per lui umana. Così la società è la perfetta consustanziazione [Wesenseinheit] dell’uomo [o universale] con la natura [o particolare], la verace resurrezione della natura, la realizzazione del naturalismo dell’uomo e dell’umanismo della natura» (p. 116).
Vediamo l’applicazione e la verificazione di questa concezione dei rapporti dell’uomo con la natura; ch’è una concezione nettamente antitradizionale, in quanto non è quella specificamente romantica, basata sul principio di un rapporto soggettivo-lirico, ispirazione, genio, intuizione che sia, dell’uomo alla natura; ma non è nemmeno (si è visto) quella genericamente idealistica della natura come oggettivazione dell’uomo autocosciente, o dialettica apparenza dello spirito.
Vediamo, dunque, la conferma di quanto sopra che ci offre l’esame, ad esempio, dei sensi e bisogni umani. «L’occhio – nota Marx – è divenuto umano quando il suo oggetto è divenuto un oggetto sociale umano, dell’uomo e per l’uomo. È dunque immediatamente nella loro pratica che i sensi sono divenuti dei teorici. Essi si rapportano sì alla cosa per amor della cosa, ma la cosa stessa è un rapporto umano oggettivo seco stessa e con l’uomo e viceversa. Il bisogno o il godimento perde così la sua natura egoistica, e la natura perde la sua mera utilità dal momento che l’utilità è divenuta utilità umana [cioè universale perché sociale]» (p. 119). Così «l’uomo non si perde allora nel suo oggetto, se questo diventa per lui oggetto umano [universale o valore], uomo oggettivo. Ciò è possibile soltanto se questo oggetto diventa per lui un oggetto sociale, anch’esso un ente sociale, come la società viene ad essere per lui in questo oggetto» (ivi). Naturalmente «non solo i cinque sensi, ma altresì i sensi detti spirituali, la sensibilità pratica, il volere, l’amare etc., in una parola la sensibilità umana, il carattere umano del sentire, c’è soltanto per l’esistenza del suo oggetto, per la natura divenuta umana (p. 120), perché socializzata e così, solo così, universalizzata, spiritualizzata, acquisita al valore. La riprova di quanto si è detto si ha nelle seguenti considerazioni critiche circa la sensibilità umana difettosa che si manifesta in quel rapporto dell’uomo con la natura ch’è il fatto economico della proprietà privata; considerazioni che traggono la loro ragion d’esser e la loro verità, s’intende, dal criterio suaccennato del rapporto uomo-natura, che non è che il concetto stesso marxiano dell’uomo, che ora stiamo verificando sul terreno fenomenologico e sperimentale.
«La proprietà privata – osserva Marx – ci ha resi talmente sciocchi e unilaterali che un oggetto non lo sentiamo nostro che quando lo possediamo [...]. Tutti i sensi [umani!], fisici e intellettuali, sono stati sostituiti dalla semplice alienazione [Entfremdung] di essi tutti, dal senso dell’avere. A questa assoluta povertà doveva ridursi l’ente umano [...]» (p. 118).
La verifica sperimentale del criterio filosofico del rapporto uomo-natura ci ha portati, dunque, nel mondo economico: il che non deve stupirci per due ragioni: l’una ideale e intrinseca alla stessa problematica filosofica da cui siamo partiti, in quanto il mondo economico è innegabilmente manifestazione tipica e fondamentale dei rapporti umano- naturali; l’altra storica o di fatto (nel senso di uno storicismo effettivo e concreto, non dialettico per una ...