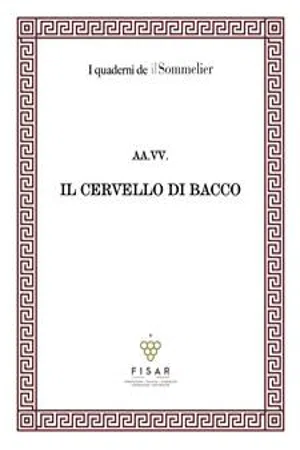
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il cervello di Bacco
Informazioni su questo libro
Vino.
E poi memoria, emozioni, linguaggio, errori…
Qual è il legame tra il vino e il nostro cervello? Perché abbiamo bisogno di utilizzare il linguaggio per esprimere ciò che sentiamo, vediamo, gustiamo? Perché l'esperienza dell'assaggio è più intensa se condivisa?
Il vino, poesia imbottigliata, è l'annaffiatore della nostra mente, ci fa navigare verso rotte inusuali, evoca i mondi interiori colorando la nostra vita. “Nel vino è la vita” e nella verità una scoperta.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il cervello di Bacco di Alice Lupi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Tecnologia e ingegneria e Agricoltura. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Tecnologia e ingegneriaCategoria
AgricolturaPerchè questo progetto
Alice Lupi
Circa una trentina di anni fa, in una riunione affollata di persone, assistetti all’intervento di un manager che disse alla platea: «Al lavoro tendo a semplificare tutto in modo che emerga il cuore dei problemi». Rimasi un po’ interdetta. A distanza di qualche anno, mi capitò poi sotto mano un testo del progettista Munari che mi aiutò a capire la frase che mi aveva lasciata basita: «Semplificare vuol dire cercare di risolvere il problema eliminando tutto ciò che non serve alla realizzazione delle funzioni1».
Con questo approccio, noi autori della rivista Il Sommelier, abbiamo cercato di improntare il progetto del presente libro che affronta un tema tutt’altro che facile: il legame tra le neuroscienze e il vino.
Durante la scorsa primavera, nella fase di costruzione dello speciale del magazine2 (incentrato proprio su questa relazione), una serie di domande sono emerse che meritavano, da parte nostra, un approfondimento ulteriore.
Siamo partiti dal presupposto che «Il cervello è un formidabile sistema biologico in grado di eseguire miliardi di calcoli al secondo3» esso coordina il funzionamento del nostro organismo, sia fisicamente sia cognitivamente (pensiamo alla memoria, all’attenzione, alla percezione, al linguaggio, alle abilità sociali…). Da qui ci siamo chiesti, per esempio, c’è un nesso tra l’effetto Madeleine, narrato da Marcel Proust, e le scienze? Perché anche i più navigati relatori, o i più esperti sommelier, possono commettere errori nel parlare di un vino? Cosa sono, e come incidono, le emozioni che sono sempre invocate durante un assaggio? Incuriositi, abbiamo provato a progettare una struttura di lavoro e tentato - attraverso, appunto, le neuroscienze - di trovare delle risposte.
Consapevoli della complessità della materia abbiamo proceduto in punta di piedi; abbiamo ritenuto opportuno intervistare accademici e professionisti del settore, abbiamo volutamente lasciato loro la parola. Ciò spiega le numerose interviste che sono pubblicate nel libro. Il dinamismo del settore ha stimolato il nostro lavoro. Infatti, le diverse discipline che si affiancano alle neuroscienze (fisiologia, marketing, linguistica…) oggi praticano numerosissime ricerche, mettono in campo studi per rispondere a problemi aperti.
Ci siamo resi conto che tale rapporto (cervello - vino) è formato da molteplici legami che quotidianamente mettiamo in pratica ma che risultano essere impercettibili, perché troppe volte scontati, oppure blasonati, al punto da essere svuotati di significato.
Consapevoli che il vasto legame tra le neuroscienze e vino non si esaurisce con il presente testo, abbiamo lavorato cercando di essere il più esaurienti possibili utilizzando un linguaggio per lo più semplice.
Abbiamo pensato di suddividere il testo in tre sezioni: la prima parte è dedicata ad inquadrare le neuroscienze e la fisiologia della degustazione; la seconda è dedicata all’aspetto cognitivo mentre la terza si sofferma sul marketing e su studi e ricerche messi in campo.
Come accennato, abbiamo scritto questo libro tenendo a mente il nostro filo conduttore: cercare di semplificare il legame neuroscienze - vino.
Confessiamo che nella stesura del presente lavoro sentivamo, come un duplice eco, risuonare da una parte le parole dell’economista Richard Thaler: «Se vuoi incoraggiare qualcuno a fare qualcosa rendigliela facile» e dall’altra quelle del progettista Munari: «Semplificare è un lavoro difficile ed esige molta creatività4».
Ci auguriamo di esserci riusciti.
Introduzione
Alice Lupi
«Ogni interpretazione tende a
conseguire l’evidenza»
Max Weber, Economia e società
conseguire l’evidenza»
Max Weber, Economia e società
Parlar di vino
Degustare un calice di vino in compagnia, anima e colora un semplice assaggio. Il carattere conviviale e dialogico, che soggiace, contribuisce alla voglia di stare insieme, di rintracciare, confrontandosi, anche termini che definiscano propriamente il nettare di Bacco.
Gli eventi enoici sono opportunità di apprendimento e occasioni per arricchire le proprie conoscenze enologiche, sono anche la possibilità di instaurare nuove relazioni e, ancora, di rafforzare quelle esistenti. Tutto ciò avviene principalmente grazie all’uso della parola: «L’intera vita di un essere umano è coinvolta nelle e dalle parole1». Un mondo senza parole sarebbe come un usignolo senza canto.
Grazie alle parole esprimiamo i nostri pensieri, opinioni, idee, proponiamo un ricordo, negoziamo un oggetto, entriamo in relazione con le persone: «La parola è una “parabola”, un suono che fa un percorso da chi lo pronuncia a chi lo ascolta […]. I poli della parabola indicano una relazione, dunque socialità2».
Sovente assistiamo a narratori del vino che ricorrono a una divulgazione lirica, a frasi ampollose per raccontare la bevanda degli dei, sovente più consoni a uno snobismo linguistico che alla mera descrizione organolettica dello stesso. Un’annotazione va riportata: «I gradi di libertà delle parole sono […] un riflesso dei gradi di libertà del nostro cervello3».
È vero «Le parole sono di tutti4» ed è altrettanto vero che «La parola non ha bisogno di un mestiere o di un’arte per essere prodotta o riprodotta5». L’uso della terminologia adeguata è però fondamentale per discernere i professionisti dai semplici appassionati. La scelta del termine appropriato, durante una degustazione, è espressione del background dell’assaggiatore che evidenzia la presenza di «[..]due sistemi di comunicazione del vino, uno di essi coincide con quello dell’analisi sensoriale […] e uno poggia sulla metafora, la sinestesia ecc. e quindi attinge alla creatività, ovviamente finalizzata e pertinente all’oggetto dell’interesse dell’assaggiatore6».
Ciò distingue un professionista, che si avvarrà di un bagaglio linguistico più tecnico, da un assaggiatore meno esperto, che userà per lo più parole generiche. Da una parte, dunque, il linguaggio scientifico (microlingua) e dall’altro un linguaggio comune (macrolingua) che, come due camere attigue, hanno bisogno di comunicare. La questione della comunicabilità tra una microlingua e una macrolingua è già stata posta dal fisico Micheal Faraday in un’epistola indirizzata al suo collega J. C. Maxwell nel 1857: «Quando un matematico si impegna a indagare azioni e risultati fisici e arriva a conclusioni proprie, non è forse possibile formulare tali conclusioni nel linguaggio comune con la stessa compiutezza, chiarezza e definitezza che in formule matematiche?»7. Torna nuovamente il concetto di semplificazione, accennato nell’intervento precedente, anche se nel nostro caso si tratta per lo più di chimica, pensiamo alle famiglie dei profumi. Questa semplificazione, o meglio, traduzione da linguaggio chimico a quello comune, permette alle persone d’intendere di cosa si parla. Molte volte, si ricorre all’uso di figure retoriche per aiutarci a comunicare: «Pensate al linguaggio scientifico: come faremmo a farci un’idea di che cosa sono i buchi neri se non ci fosse questa espressione semplice ma altamente metaforica che ci mette in grado di immaginarli e di comprenderli?8». Oltre la metafora, anche la catacresi ci dà una mano, pensiamo all’espressione “il collo della bottiglia” come altro lo potremmo chiamare? Anche la sinestesia corre in aiuto dei degustatori: «Nella sinestesia giochiamo con i cinque sensi, mettendo in rapporto due aree sensoriali diverse: spieghiamo con il tatto qualcosa che ha a che vedere con la vista (esistono “colori caldi” e “colori freddi”), attribuiamo il nostro carattere alle cose (il mare può essere “calmo” oppure “agitato”), e non compriamo qualcosa se il suo prezzo ci pare troppo “salato”9».
Rimanendo calati nella nostra realtà enologica, il piacere dei sensi è dato anche dalla comunicazione del “proprio gusto o del proprio disgusto”. Secondo il prof. Ivan Bargna, docente di antropologia, il gusto e il disgusto non hanno a che fare con dei giudizi pensati, ma implicano dei comportamenti che sono di attrazione e di reazione che, in qualche modo, incidono sulle relazioni sociali.
La diffusione della cultura sensoriale del vino, che non si beffeggi di astruse frasi e di versi improbabili, è opera in primis delle scuole di sommellerie, della Fisar nella fattispecie, che ha il compito di trasferire – attraverso i suoi relatori e i corsi, attraverso i suoi sommelier e gli eventi – il linguaggio specifico, avvalendosi della terminologia appropriata alla descrizione dei vini. Ciò richiede, come vedremo nelle prossime pagine, una mera educazione sensoriale: «Se teniamo conto anche degli altri sensi, la gente pian piano si abituerà e scoprirà che ci sono tanti recettori sensoriali per conoscere il mondo in cui viviamo»10. Spetta poi al soggetto degustatore allenare i sensi, come un atleta allena i suoi muscoli.
La mente è più estesa del cielo11
Fino a qui, abbiamo visto che l’assaggio di un vino, professionale o edonistico che sia, vede il coinvolgimento di precisi elementi: i sensi, il pensiero, le parole e, appunto, il vino. In realtà, il deus ex machina, come scopriremo nei capitoli a seguire, è il nostro cervello. Grazie ad esso parliamo, degustiamo, ricordiamo, percepiamo il mondo, camminiamo, leggiamo, scriviamo, rispondiamo al telefono, dialoghiamo con le persone. Il cervello, come un regista di uno spettacolo non si vede sulla scena di degustazione, coordina le funzioni del nostro organismo pur rimanendo dietro le quinte. È inevitabilmente presente, codifica, decodifica, memorizza… «I nostri sensi […] interagiscono continuamente in quel grande integratore di dati, o meglio di percezioni (ma anche di nozioni, ricordi ed emozioni) che è il nostro cervello12».
Ogni senso ha un proprio set di recettori cui fanno capo, e un insieme di neuroni sensoriali che trasmettono gli impulsi dai recettori al sistema nervoso centrale: «Tutte le nostre sensazioni, da quelle uditive a quelle tattili a quelle dolorose, dipendono da cellule specializzate a captare e tradurre le diverse energie degli stimoli in un unico linguaggio: i recettori13» (cd. trasduzione).
I sensi sono i nostri rilevatori, capaci di farci mettere a fuoco, nel caso specifico, se un vino, molto banalmente, ci piace o no (attrazione/repulsione, gusto/disgusto). È una fase profondamente intima, soggettiva. Un momento che non solo precede l’eventuale esternazione agli astanti, grazie alla parola, della nostra descrizione del vino, ma addirittura anticipa la formulazione del pensiero, ciò vale indistintamente per gli esperti e per i semplici amatori: «Tra sensazione delle cose e sensazioni di sé, si instaura un andirivieni continuo: prima del pensiero, vi sono i sensi»14.
Tra le numerose funzioni complicate che svolge il cervello umano, vi è anche l’articolazione del linguaggio. La linguistica s’interessa alle neuroscienze: «oggi sappiamo che le parole non sono merci scollegate e inerti in un magazzino che […] è il nostro cervello che è un insieme sempre in movimento, un insieme dinamico di miliardi di cellule nervose, i neuroni, ciascuna legata ad altre in miliardi e miliardi d...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- 1. Perché questo progetto, di Alice Lupi
- 2. Introduzione, di Alice Lupi
- Prima parte. Messa a fuoco
- Fisiologia
- Seconda parte. Emozioni, memoria ed errori
- Terza parte. Marketing, studi e ricerche
- Articoli correlati: