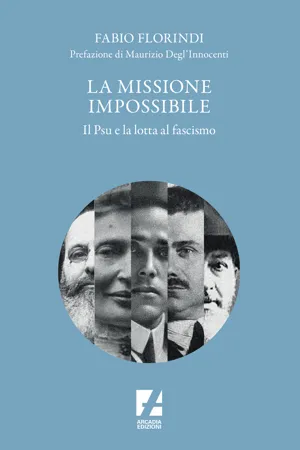![]()
Capitolo 9.
Lo scioglimento del Psu e la nascita del Psli
In diversi ambienti inizia a farsi largo l’idea che l’unico modo per liberarsi di Mussolini sia ucciderlo. Il primo attentato, su cui c’è la mano della massoneria, viene architettato dall’ex deputato del Psu Tito Zaniboni e dal generale Luigi Capello. Zaniboni è un personaggio controverso. Subito dopo la Grande Guerra aveva simpatizzato per l’impresa fiumana di D’Annunzio e collaborato con «Il Popolo d’Italia». Nel 1920 si era iscritto alla massoneria e l’anno dopo era stato eletto deputato per il Psi. Aveva firmato, assieme a Giacomo Acerbo, il patto di pacificazione tra fascisti e socialisti. Con la scissione del 1922, Zaniboni si iscrive al Psu. Alle elezioni del 1924 non è rieletto e, qualche mese dopo, il delitto Matteotti lo porta ad assumere posizioni nettamente antifasciste. Nell’attentato messo a punto contro Mussolini non è coinvolto l’Aventino, anzi Zaniboni e Capello si muovono in polemica con la passività delle opposizioni.
Il piano scatta il 4 novembre 1925: viene affittata una stanza all’Hotel Dragoni, davanti al balcone di Palazzo Chigi dove Mussolini si sarebbe dovuto affacciare per celebrare l’anniversario della vittoria del 1918. Zaniboni avrebbe dovuto sparare con un fucile di precisione austriaco e colpire il Duce. L’ex deputato del Psu arriva in albergo tre ore prima del momento stabilito per sistemare gli ultimi dettagli. In quel momento la polizia, avvertita da un informatore infiltrato nel gruppo di attentatori, fa scattare la trappola. Nella stanza dell’Hotel Dragoni viene rinvenuto il fucile e nei pressi di Palazzo Chigi l’auto su cui Zaniboni sarebbe dovuto fuggire. L’attentatore viene arrestato e, sebbene non ci sia alcun collegamento con il Psu, dopo due giorni il Duce ne approfitta per sciogliere il partito e chiudere La Giustizia. Il Partito Socialista Unitario è il primo partito sciolto da Mussolini.
Gli unitari, in particolare Turati, Treves e Gonzales, pensano alle dimissioni generali dei gruppi secessionisti. A questo proposito, il 17 novembre, lo stesso Turati scrive alla Kuliscioff: «Ieri […] ebbi notizia della decisione dei massimalisti, né scendere né dimettersi; respinta la tesi delle dimissioni sostenuta solo da due o tre. […] I popolari sono divisi e intransigentissimi e terranno gruppo domattina. Al reingresso nessuno crede più […] Io che ero dubitoso circa le dimissioni limitate o di Gruppo […] non dubiterei punto per le dimissioni allargate a tutti o quasi tutti i gruppi secessionisti, e in questo almeno avremmo concordi anche tutti i colleghi unitari». Il progetto, ostacolato dalla decisione del Psi di staccarsi dall’Aventino senza una tattica chiara, non verrà mai attuato. Non viene ritenuta praticabile, invece, la via delle dimissioni del solo gruppo riformista. Anche perché la prima preoccupazione dei leader unitari è quella di bloccare sul nascere un’eventuale migrazione di massa della base, e anche dei quadri, verso il Psi. Per questo il 9 novembre la direzione del disciolto partito invia una circolare a tutte le sezioni: «Noi che siamo i più colpiti ci sentiamo orgogliosi del nostro passato, della posizione assunta volontariamente contro il fascismo […] Rimanete al vostro posto!».
La decisione del Duce apre una fase nuova. Il primo a rendersene conto è Nenni che, in una lettera inviata il 14 novembre alla direzione del Psi, spinge per una fusione con i socialisti unitari: «Tutte le conquiste del passato sono annullate. Democrazia politica – cioè l’ambiente per ogni consapevole lotta di classe – sindacalismo libero – stampa libera – influenza politica del socialismo. Tutto finito. Tutto da riconquistare, con animo più agguerrito, con una maggiore consapevolezza politica, con una aumentata capacità di azione. Sorge da ciò il problema dell’unità socialista, dalla cui soluzione dipendono le ulteriori fortune del movimento socialista e le sue possibilità di ascesa […] È impossibile, nella tragica situazione in cui ci siamo ridotti a difendere disperatamente una bandiera, superare le scissioni? Quella di Livorno, no. La scissione di Livorno fu la più tragica e la più inutile, ma fu anche definitiva. Tutti coloro che l’hanno voluta superare (Maffi, Serrati, ecc.) non hanno avuto altro mezzo che l’adesione al partito comunista. Nessuna intesa è possibile con la III Internazionale all’infuori dell’adesione pura e semplice alle sezioni comuniste […] È invece possibile superare la scissione di Roma […] La scissione è oggi un crimine o un lusso che noi non ci possiamo permettere. Essa è inoltre un atto di morte, perché i compiti che ci si presentano sono identici per noi e per gli unitari; perché il proletariato socialista non ci capisce e trova nella nostra divisione e nelle nostre polemiche l’elemento principale della propria sfiducia […] Unificare le forze socialiste vuol dire ridare fiducia alle masse, richiamare l’attenzione dei giovani sul partito, suscitare delle forze nuove».
La posizione di Nenni trova una sponda in una parte importante dell’ex Psu. Tra gli unitari, infatti, si va rafforzando la posizione di chi è a favore dell’unità con il Psi. Comunque, nel frattempo, i riformisti si riorganizzano per conto loro. Dopo lo scioglimento del Psu, l’11 novembre si riunisce il gruppo parlamentare unitario che incarica un comitato provvisorio di rimettere assieme le forze rimaste. Dopo qualche settimana nasce il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (Psli), l’«Avanti!» ne dà notizia il 13 dicembre: «È stato annunciato che i deputati del Gruppo unitario si fanno promotori della costituzione di un nuovo Partito che si denominerà “Partito socialista dei lavoratori italiani”». Alla segreteria del Psli è nominato Zannerini, l’ex vice di Matteotti, affiancato, tra gli altri, da Caldara, Morgari, Levi e Buozzi. Gli ultimi due, però, danno subito le dimissioni, essendo anche dirigenti della Cgdl. Anche il Psli, dunque, conferma il legame con il sindacato, che ha contraddistinto da sempre i riformisti. A testimoniarlo è il fatto che il partito, nell’aprile 1926, fa sapere che «per l’azione sindacale è fatto obbligo morale per tutti i federati il massimo e costante interessamento» e che «ogni iscritto al partito deve intanto prelevare la tessera confederale per l’anno in corso ed adoperarsi nel modo migliore per l’incremento della libera organizzazione di classe». Il nuovo partito, a causa della repressione fascista, di fatto resterà sempre semi-clandestino.
Organo del Psli è il settimanale «Italia socialista», il cui primo numero esce nel marzo 1926, ma il nome della testata viene subito modificato in «Giustizia» (che riecheggia il nome del soppresso quotidiano del Psu) con direttore Antonino Campanozzi. Le linee guida della politica del nuovo partito ricalcano le precedenti del Psu. Il fine ultimo del Psli è la costruzione di una soc...