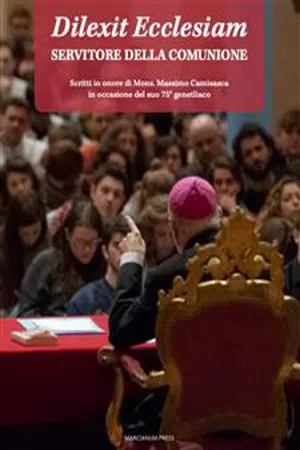Rocco Buttiglione
Pontificia Università Lateranense
Ho avuto modo di collaborare con Mons. Camisasca in molte occasioni nel corso di una amicizia che dura, anche se ormai da molti anni a distanza, fin dall’inizio degli anni ’70. In questa occasione voglio ricordare in modo particolare gli inizi degli anni ’80 ed il lavoro svolto insieme in quegli anni per favorire un incontro fra i diversi movimenti nella Chiesa e l’inizio di una teologia dei Movimenti.
Esigenza di una teologia dei Movimenti
Un primo risultato di questo lavoro sul convegno del 23/27 settembre 1981 sui Movimenti nella Chiesa negli anni ‘80 [1] . Si faccia attenzione al titolo ed alla data. Non è il consuntivo di un processo che già si è svolto nella Chiesa ma piuttosto il programma di un processo che si avvia e del quale si tenta di tracciare le linee di sviluppo. Credo sia stata la prima volta che la realtà dei Movimenti è stata tematizzata e ci si è sforzati di pensarla organicamente. L’11 febbraio il Movimento di Comunione e Liberazione era stato riconosciuto ed aveva assunto la forma giuridica della Fraternità di Comunione e Liberazione. La Fraternità è una associazione laicale. Al di là della forma giuridica si poneva comunque un problema più ampio che riguardava l’essenza stessa dei Movimenti e, insieme, il modo di essere della Chiesa alla fine del secolo XX e poi nel secolo nostro. Quella riflessione contribuirà poi ad una maturazione che trova una sistemazione nel Messaggio di Giovanni Paolo II Ai Movimenti ecclesiali ed alle nuove Comunità alla vigilia di Pentecoste del 30 Maggio 1998 ed in quello di Benedetto XVI Ai partecipanti al II Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali e delle nuove Comunità del 31 Maggio 2006 [2] . Facciamo di nuovo attenzione al titolo: c’è una certa incertezza terminologica, i Papi si riferiscono ai Movimenti nella Chiesa ed alle nuove Comunità. È come se volessero abbracciare una realtà ancora in parte magmatica: Movimenti nella Chiesa comincia ad avere un significato più preciso, con “nuove Comunità” si vogliono abbracciare fenomeni più indefiniti ma dei quali si intuisce un potenziale di rinnovamento e di apertura di cammino verso il futuro.
Giovanni Paolo II ed i Movimenti
Agli inizi degli anni ’80 è iniziato da poco il pontificato di Giovanni Paolo II. Il nuovo Papa viene da lontano, da un’altra cultura e da un’altra storia. Non è facile da capire per gli italiani, abituati a pensare che la loro cultura e la loro storia dovessero dare il ritmo alla Chiesa universale. In quel momento di sconcerto generale don Massimo ed io eravamo meno sconcertati. Il movimento di Comunione e Liberazione, al quale entrambi apparteniamo, ha una lunga storia di contatti con la Polonia. Un prete del Movimento, il mitico don Francesco Ricci di Forlì, aveva intessuto da tempo una rete di viaggi e di amicizie con le Chiese perseguitate (e con gli intellettuali liberi) dei paesi comunisti). Portavamo libri proibiti, riportavamo testi che circolavano in quei paesi negli spazi ridotti di libertà culturale concessi dal regime o anche in forma del tutto clandestina e li pubblicavamo, dopo averli tradotti, in una rivisita che si chiamava CSEO (Centro Studi Europa Orientale) [3] . Lì è apparso, nel 1967, un articolo di Karol Wojtyła con il titolo Il Cristiano e la cultura. [4] Molti di noi andavano ogni anno in pellegrinaggio a Jasna Góra ed eravamo molto amici del movimento Luce e Vita del Padre Blachnicki. Sapevamo che il nuovo Papa era amico dei movimenti e ci sembrava quindi che fosse venuto il momento di iniziare una riflessione sistematica e critica su di essi.
Creare una fraternità fra i movimenti
Il primo problema era avvicinare i movimenti fra loro e convincerli della opportunità e necessità di instaurare un rapporto di fraternità fra di loro e di iniziare una riflessione comune. Questo è meno facile di quello che può sembrare a prima vista. I movimenti sono avvenimenti di grazia affidati nelle fragili mani di uomini ed hanno una naturale tendenza alla autoreferenzialità. Nascono in una società largamente secolarizzata ed abitano una incerta linea di confine fra la fede e l’incredulità. Lo Spirito di Dio ravviva la testimonianza cristiana di un uomo, attorno a lui si raccolgono alcuni amici che vogliono vivere come lui, che vogliono imparare a vivere da lui. Si struttura un po’ per volta una amicizia. Il Fondatore diventa punto di riferimento e guida per una piccola comunità che poi si espande. Alcuni, o anche molti, di quelli che lo seguono non hanno un chiaro radicamento cristiano, non hanno mai frequentato una parrocchia o erano indifferenti o non credenti. Altri hanno trovato nella comunità anche una compensazione per vite danneggiate, per contesti familiari difficili che ne hanno ostacolato la piena maturazione umana. Altri ancora sono gli elementi più ferventi e più attivi di una comunità parrocchiale attratti da una testimonianza più radicale. L’incontro con il Movimento cambia le vite di queste persone, genera una nuova trama di rapporti umani ed un nuovo senso di appartenenza. Dà la sensazione di un nuovo inizio. In effetti i movimenti sembrano replicare il modello della Chiesa delle origini. È l’avvenimento dell’origine che si ripropone.
Tutto questo è certamente un dono di grazia, un avvenimento dello
Spirito ma non è senza problemi.
I Movimenti tendono però ad assolutizzare la loro esperienza ed a guardare con sospetto il resto della Chiesa, compresi gli altri movimenti. Se il Movimento è la Chiesa delle origini, il nuovo Israele, la Chiesa “ufficiale”, “gerarchica” tende ad essere vista come il “vecchio Israele”, una realtà dalla quale differenziarsi piuttosto che una realtà con la quale riconoscersi. Con eguale diffidenza si guarda agli altri movimenti: se sono veri credenti perché non vengono con noi? Quali patenti o latenti eresie li separano da noi?
Il primo lavoro di don Massimo fu allora quello di intessere una rete di contatti amicali per convincere i diversi movimenti che l’altro non era il deviante, il concorrente o il nemico e che l’unico Spirito chiamava tutti, attraverso percorsi diversi, a convergere nell’unica casa del Padre. Alcune volte fu facile, altre meno, cominciando dalla parola stessa Movimento, che ad alcuni non piaceva. I Neocatecumenali, per esempio, volevano chiamarsi Cammino. Il primo passo del dialogo era il riconoscimento della grandezza del dono dello Spirito che avveniva in ciascun Movimento (o Cammino). Solo a partire da lì era possibile aprire poi il Movimento al dialogo con gli altri. Come diceva spesso don Giussani un errore o un limite in una esperienza si corregge solo a partire dal positivo che essa contiene.
Movimenti e le Parrocchie
Un secondo scoglio era il rapporto fra Movimenti e Parrocchie. I parroci erano (salvo rare eccezioni) arrabbiati con i Movimenti accusati di costruire comunità chiuse alternative alla comunità parrocchiale e di “rubare” alle parrocchie i giovani migliori, più entusiasta ed attivi, sottraendoli all’impegno nella comunità parrocchiale che si concretizzava allora soprattutto nei gruppi di Azione Cattolica. I Movimenti rigettavano queste accuse. Dicevano che i loro giovani in parrocchia non c’erano mai andati o se c’erano andati se ne erano staccati all’inizio della adolescenza ed erano tornati alla pratica religiosa solo attraverso l’esperienza del Movimento. In realtà c’erano torti e ragioni da tutte e due le parti. Io sono cresciuto in un ambiente quasi interamente laico e secolarizzato. In una parrocchia praticamente non avevo mai messo piede. Io (e tanti come me) sentivamo come una inaccettabile prepotenza la pretesa dei parroci di rivendicarci quasi come una loro proprietà. Sentivamo di appartenere, per libera scelta, al Movimento e solo al Movimento. Io stesso però ho rubato alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Roma la perla del loro gruppo di Azione Cattolica, la ragazza più intelligente e più impegnata (e più carina) che poi ho anche sposato. Al parroco don Faustino Ossanna, di venerata memoria, è servita tutta la sua infinita bontà per perdonarmi. Più seria era l’altra accusa di costruire una chiesa nella Chiesa. Noi dicevamo che dopo l’invenzione dell’automobile (e del telefono e di internet…) l’ambiente di vita dei giovani non è più definito dal territorio, dalla prossimità del luogo di abitazione (parrocchia significa para oikias, vicino alle case) ma lascia ampio spazio a comunità elettive sparse sul territorio. Le persone che esercitano una influenza decisiva sulla vita di un giovane spesso non vivono nella prossimità fisica della sua casa. Le nuove generazioni diventano spiritualmente nomadi ed hanno bisogno, in un certo sensori una Chiesa nomade. Questo è vero, però è anche vero che i giovani poi si sposano, si insediano sul territorio ed allora tornano in parrocchia. Fra pastorale nomade e pastorale stanziale c’è una tensione ma ci deve essere anche una cooperazione ed un dialogo.
Carisma ed Istituzione
Il problema più grave era però ancora un altro. Per i Movimenti decisiva era la funzione del fondatore, che era spesso un sacerdote o un consacrato ma poteva anche essere un semplice laico. Il legame fra gli aderenti al Movimento e la Chiesa passava fondamentalmente attraverso il Fondatore. Il Fondatore realizza la presenza di Cristo in mezzo a noi oggi e questo è il fascino che converte. L’avvenimento di Cristo si ripete nel presente. Lo dicevano già i discepoli di S. Francesco che dicevano che Francesco era un alter Christus. Tutto questo è meraviglioso ma può anche essere blasfemo perché l’avvenimento di Cristo è unico ed irripetibile. C’è un solo Cristo che è vissuto in Palestina circa 2.000 anni fa. Questo non impedisce che l’avvenimento si ripresenti qui ed ora. Ontologicamente l’avvenimento originario si ripresenta ogni giorno qui ed ora nel sacrificio della messa. Il ripresentarsi nella esperienza del Movimento ha evidentemente caratteristiche diverse. L’avvenimento non si ripresenta qui ontologicamente ma esistenzialmente. Cosa garantisce però che il Cristo che mi si rende prossimo attraverso la persona del Fondatore sia lo stesso Cristo che è morto e risorto per me? Cosa garantisce che non sia un Cristo mutilato e ridotto, un Cristo sulla misura della mentalità dominante oggi o delle mie preferenze soggettive? L’unica cosa che può dare questa garanzia è il legame con l’autorità della Chiesa nella forma della successione apostolica. Questo legame ha due forme: la corretta celebrazione dell’Eucarestia ed il riconoscimento reale della autorità del vescovo successore degli apostoli. Il vescovo non è l’origine del carisma. Il carisma si presenta lì dove lo Spirito vuole, sconvolge i piani pastorali meglio architettati e fatica ad inserirsi nella pastorale ordinaria della diocesi. Ci vuole molta umiltà da parte di un vescovo per ascoltare il carisma dello Spirito che soffia nei Movimenti. Occorre anche molta umiltà nei Movimenti per accettare realmente e fattivamente l’autorità del vescovo.
Una appropriata collocazione canonica
Un altro problema collegato con quello del rapporto fra carisma ed istituzione è quello della appropriata collocazione canonica dei Movimenti. La prima collocazione che viene in mente e quella che sembra essere più semplice e ...