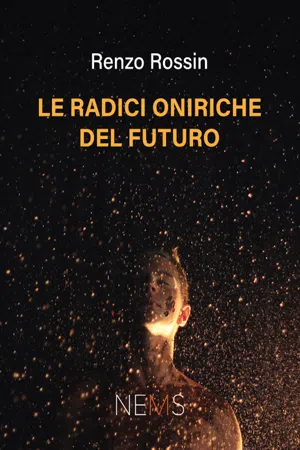
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Le radici oniriche del futuro
Informazioni su questo libro
Nulla esiste di propriamente umano, che non sia stato prima immaginato e in qualche modo sognato.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Le radici oniriche del futuro di Rolando Zucchini, Mnamon Editore, Marcella Danon in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9791280296184eBook ISBN
9791280296160PARTE I – IL FASCINO DELL’INVISIBILE
CAPITOLO 1 - C’era una volta il sogno
Risvegliare l'arte della divinazione
L’attività onirica, che rimodella ogni notte alcuni tratti del sistema nervoso centrale e che osserviamo anche negli animali, non è certo finalizzata solo alle intenzioni dell’uomo e sarebbe una perdita pericolosa non continuare a cercarvi delle indicazioni, come è accaduto sempre. La diffusione planetaria dell’oniromanzia lascia pensare che l’evoluzione “premi” l’interpretazione dei sogni, afferma lo psichiatra Enrico Borla: “Se il sogno mette sulle tracce affinché qualcuno segua un certo cammino, il nostro cosciente si trova davanti a una struttura ‘altra’. Che sia Dio, il diavolo, l’inconscio, il Sé, non ha importanza, c’è un’alterità che ci parla, ci guida, ci allontana, l’importante è che c’è. C’è un interlocutore altro con cui dialogare, litigare, opporsi ma che comunque si dimostra dotato di una conoscenza se non superiore, sicuramente ulteriore rispetto alla nostra coscienza. […] La mantica onirica è necessaria, come respirare, cibarsi, dormire, amare ed essere amati, competere, morire. Sta a noi scoprire le regole affinché i geni trasformatisi in memi possano procedere nella loro naturale evoluzione”[1].
Mentre i nostri antenati hanno avuto molto più tempo e maggiori motivazioni per occuparsi dei sogni, oggi non se ne parla se non nella relazione terapeutica, per lo più su richiesta del terapeuta stesso, che si propone di ottenere così una conoscenza più approfondita del suo paziente.
Nelle culture arcaiche e tradizionali il sogno ha influito molto più di oggi sul comportamento e sulle scelte individuali e ancor più collettive, soprattutto in quanto ritenuto via d’accesso alle forze mistiche, al mondo degli dei e degli spiriti.
La trattazione storico-etno-religiosa dimostra che il sogno e gli altri stati oniroidi come le visioni, sono stati considerati in modo non precisamente distinto tra loro, ed eminentemente come espressioni di forze e poteri del sacro, come mezzo per entrare in contatto con una realtà invisibile, e averne la collaborazione per superare situazioni critiche e risolvere problemi di ogni genere. Perché innumerevoli sono stati i bisogni, le preoccupazioni e le paure che minacciavano la sicurezza e anche l’esistenza stessa di individui, comunità e popolazioni.
Tanto da indurre ogni cultura a cercare innanzitutto di prevenire i rischi con tutti i mezzi, anche alleandosi con entità benevole mediante riti di propiziazione (adorcismo) e di allontanamento di quelle malevole (esorcismo). Vedremo che la principale motivazione a operare ritualmente nel mondo magico e religioso è di fatto la paura del futuro, il bisogno di assicurarsi una vita qualitativamente migliore e una continuità nella sicurezza; un bisogno superiore da sempre a ogni altro, ispiratore di intuizioni creative, di sistemi mantici e divinatori non meno che di scoperte scientifiche e invenzioni tecniche. Queste nelle principali civiltà vengono ottenute proprio attraverso percorsi inizialmente divinatori, come documenta lo storico della filosofia Jean Pierre Vermant[2].
Generalmente, osserva l’antropologo Vittorio Lanternari “c’è la tendenza, fra le società arcaiche, a far sì che il contenuto, in sé stesso neutro, dei sogni assuma il valore di un atto di fondazione vero e proprio, di una profezia-presagio. Congiunta a questa è la tendenza ad autoprovocare i sogni, con intento propiziatorio, e quella a delimitare la funzione profetica dei sogni ad alcune esperienze oniriche determinate, il cui valore dipende dalla persona che le riceve e dalle circostanze in cui si ricevono. Di norma valgono come sogni veri quelli fatti da personalità ragguardevoli, o addirittura dai professionisti dei sogni”[3].
Per lo studio delle credenze nel mondo antico è stato fondamentale il contributo dall’antropologia culturale, che riguardo ai sogni dimostra come i più interessanti siano stati non casuali, ma rientranti in uno schema definito di attese culturali, garantite dai ruoli istituzionali degli operatori del sacro e da precise modalità operative. Attraverso le quali il messaggio onirico viene recepito e attuato. Assumendo sogni e visioni come fatti culturali, prima che come fenomeni religiosi, possiamo distinguerli in diverse categorie: di rivelazione, sciamanici, divinatori, totemici, iniziatici, profetico/messianici.
Le fonti più antiche
L’interpretazione dei sogni ha impegnato, affascinato e tormentato uomini delle più diverse culture in ogni tempo e luogo della terra, e secondo il neurofisiologo Mauro Mancia “In un certo senso, possiamo pensare alla storia dell’umanità come a un continuo e costante lavoro sul sogno, come a una ininterrotta trasformazione del latente nel manifesto, del nascosto nel rivelato” (Mancia, 1987).
Il primo documento è di 6.000 anni fa e riguarda un sogno dell’eroe mitologico Gilgamesh, interpretato da sua madre, che predice la vittoria del figlio sul nemico Enkidu, il quale verrà vinto e diventerà amico del figlio.
Di 4.000 anni fa è un papiro egiziano da cui si comprende l’importanza che veniva attribuita al linguaggio, ai fini di interpretare il sogno, poiché viene suggerito di ricorrere ai giochi di parole e di portare attenzione alle corrispondenze simboliche e ai modi in cui viene fatto il racconto. Con questo metodo si possono ottenere indicazioni utili per la vita sessuale, le malattie e le loro cure.
Fra i maggiori apporti allo studio dei sogni nell’antichità occidentale abbiamo Artemidoro di Daldi, che ha contribuito alla loro prima sistematizzazione formale. Fu un greco del secondo secolo d. C., che li distinse in simbolici, allegorici, prefiguratori, oracolari, proponendo un’interpretazione sistematica delle visioni premonitrici veritiere, distinte dalle semplici visioni fisiologiche, che sono momentanee. La materia è minuziosamente articolata e include voci di tutti gli aspetti della vita sociale del tempo. Notevole il rilievo dato da Artemidoro ai simboli del sognatore, al suo erotismo, al contesto socio-economico e culturale in cui viveva.
Nella Grecia antica fu di grande valore sociale il sogno incubatorio, praticato presso il santuario di Asclepio, Esculapio per i romani, il cui sacerdote più noto è Aristide, un contemporaneo di Artemidoro, che ha lasciato una testimonianza personale di quel rito antico, la cui pratica troviamo anche in Egitto, con ramificazioni in culture diverse.
Benché i sogni ispirati costellino l’Antico e il Nuovo Testamento, il cristianesimo si contrappose alla visione ideologico-sacrale del mondo antico e ostacolò le pratiche mantiche e divinatorie, compresa l’oniromanzia, perché contrastavano con la concezione della grazia di Dio e con il libero arbitrio dell’uomo, in quanto insidiato nei sogni da tentazioni demoniache, più che guidato dall’ispirazione divina.
Ma alchimia e rosacrocianesimo hanno continuato ad attribuire ai sogni valore conoscitivo di carattere magico ed esoterico, e nel Rinascimento Gerolamo Cardano, con l’opera Sul sogno e sul sognare[4], costruisce un ampio catalogo dei sogni, come quello di Artemidoro, benché parzialmente ancora entro il cono d’ombra medievale. Con la nascita dell’Illuminismo, il sogno viene confinato sostanzialmente fra i temi letterari, fino all’arrivo del padre della psicoanalisi Sigmund Freud, che immette il sogno nella storia del pensiero umano.
L’attenzione al sogno nel Novecento
Per Freud il sogno esprime particolarmente l’affettività dell’infanzia del sognatore, esplorabile attraverso i suoi principali vissuti onirici. Un’affettività talmente peculiare che non basta la conoscenza dei simboli per metterne in luce la soggettività esclusiva.
La forza del desiderio vi risulta molto potente, ma la censura può inibirla, pur senza impedire che la memoria ricomponga nella relazione analitica la storia affettiva del soggetto. Che include anche sentimenti di angoscia, soprattutto davanti all’istanza punitiva del giudice interno, il Super Io.
Mentre per Freud il sogno appaga in modo mascherato il desiderio represso e rimosso[5][6], per lo psicoanalista Carl Gustav Jung invece il sogno ha uno scopo e rappresenta simbolicamente e spontaneamente la situazione inconscia del sognatore, indicando inoltre le potenzialità ancora inespresse del soggetto. La forza e bellezza plastica e poetica di certi grandi sogni deriva dalle profondità transpersonali dell’inconscio collettivo, soprattutto nella pubertà, nel mezzo e alla fine del cammino della vita[7].
Nella psicologia della Gestalt applicata da Fritz Perls alla terapia, si possono considerare i contenuti del sogno come parti del sognatore. Da questo approccio si possono derivare delle esercitazioni utili in ambito psico-pedagogico, nel quale le figure del sogno divengono intuibili mediante l’identificazione simbolica[8].
A distanza di oltre un secolo dalla pubblicazione de L’interpretazione dei sogni, con cui Freud aveva avviato la loro esplorazione da un punto di vista scientifico, i sogni restano ancora la via regia all’inconscio. Che è raggiungibile associando liberamente le parole con le immagini del sogno stesso, con l’ipnosi e con altri mezzi. Dall’approfondimento degli studi, il sogno appare comunque sempre meno come “appagamento allucinatorio di un desiderio rimosso nell’infanzia” e sempre più come un mondo parallelo di incalcolabile complessità e ricchezza, nel quale ogni notte vanno in scena importanti aspetti del nostro mondo interiore.
Considerando il sogno come rappresentazione delle relazioni fra le figure affettivamente più importanti nella formazione dell’individuo, è ancora Mauro Mancia a evidenziare il valore sacrale acquisito dagli affetti famigliari, che ritornano e possono essere elaborati nella relazione analitica.[9]
Negli ultimi quarant’anni sono aumentati di numero, precisione ed efficacia gli strumenti per la comprensione dei processi simbolici superiori anche per quanto riguarda il sogno: psicologia cognitiva, psicolinguistica, neuropsicologia, grammatica generativo-trasformazionale, etnopsicologia e altre discipline offrono modelli utili per lo studio delle operazioni mentali che avvengono anche durante il sonno.
Per esempio, secondo il linguista e filosofo Noam Chomsky l’infinita creatività dell’espressione linguistica si può spiegare con le regole sottostanti che la governano. Anche per lo psicoanalista David Foulkes le immagini dei sogni costituiscono un linguaggio con le sue regole-base, proprio come le parole studiate dalla linguistica. Fra l’altro, Foulkes ritiene che anche l’efficacia della tecnica psicanalitica delle associazioni libere possa dipendere dalla stessa memoria semantica da cui derivano le immagini oniriche, secondo le regole di una grammatica generativo-trasformazionale del sogno.[10]
Antropologia culturale ed etnopsichiatria apportano all’utilizzo dei sogni il simbolismo di antichissime tradizioni interpretative, che in passato furono fonti di importanti e diffuse credenze e pratiche spirituali, in difesa di alcune delle quali si è mobilitata anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare per il valore terapeutico che ancora conservano.[11]
CAPITOLO 2 - Divinazione e profezia
Dopo avere descritto alcune forme divinatorie di diversi popoli, in particolare quelle a base numerica, e aver raccontato di un suo interessante incontro con un medium, la psicoanalista Marie-Louise Von Franz aggiunge: “Quasi tutte le tecniche di divinazione non numeriche sono basate su qualche tipo di struttura caotica, esattamente come il test di Rorschach. Guardiamo il disegno caotico e insorge una fantasia, mentre il completo disordine della forma confonde la mente cosciente. Potremmo essere tutti medium, e tutti avere una conoscenza assoluta, se la luce abbagliante della nostra coscienza egoica non la offuscasse. Per questo il medium ha bisogno di un ‘abaissement du niveau mental’ (abbassamento del livello mentale) e deve immergersi in ‘trance’, in uno stato simile al sonno, per fare emergere le proprie conoscenze. Io stessa ho notato che in condizioni di estrema stanchezza, quando sono fisicamente esausta, improvvisamente ho lampi di coscienza assoluta. […] Guardare una formazione caotica è come addormentare la mente per un minuto e far emergere fantasie o sogni che stavano avvenendo nell’inconscio”[12].
Si tratta però di momenti passeggeri, al termine dei quali l’intuizione cessa, inoltre bisogna riconoscere che l’intuizione dell’operatore medianico – qualunque sia il suo mezzo divinatorio – lascia pur sempre nell’operato le tracce della sua soggettività.
Chiedendoci se queste considerazioni potrebbero essere estese a culture diverse dalla nostra, possiamo intanto dire che in società molto semplici, i problemi personali acquistano generalmente minor rilievo, perché vivono in una sorta di “partecipation mystique”, come un corpo unico, costituendo una Schicksalsgemeinde[13], una sorta di comunità legata dal destino, che deve fronteggiare analoghe difficoltà interne e le stesse minacce esterne, E nelle società antiche?
Sogni profetici nel mondo antico
L’etimologia di sacro rimanda alla radice indoeuropea sak, indicante ciò che è connesso al cosmo e alle sue leggi, e quindi ordinato e rassicurante rispetto alla dimensione ordinaria del mondo profano, spesso precaria e minacciosa. Le tracce culturali del paleolitico superiore fanno ritenere che i nostri antenati avessero già sviluppato il sentimento di appartenenza a un ordine superiore, che non dipende peraltro dal periodo storico, in quanto appartiene alla struttura della coscienza, secondo Mircea Eliade[14].
Alla dimensione del sacro si accede tradizionalmente mediante riti come il sacrificio e l’iniziazione, spesso recandosi dove i profeti divinavano attraverso i suoni e altri elementi naturali di luoghi considerati sacri, come sorgenti, caverne, singole piane. Fra i mezzi per interpellare gli dei, il sogno è stato sempre una via privilegiata, soprattutto all’interno dei templi in cui si praticava il rito dell’incubazione, come quelli di Serapide in Egitto e di Asclepio in Grecia.
Senofonte scrive che Socrate fu accusato di empietà e portato sotto processo perché dimostrava di non credere agli dei riconosciuti dallo stato. In realtà confidava in essi, ma pensava bastasse l’intelligenza umana per le questioni meno complesse, ponendo agli dei tramite la divinazione i quesiti su ciò che solo essi conoscevano. Per casi del genere, lui stesso mandava degli amici a interrogare l’oracolo[15]. La testimonianza di Senofonte, mentre contribuisce a farci conoscere meglio Socrate, elenca alcune attività divinatorie della Grecia antica, dove nei templi consacrati ad Asclepio si praticava il rito dell’incubazione, pratica utile per ricevere in sogno dal dio la cura necessaria. I malati che praticavano l’incubazione, vivevano un’esperienza molto suggestiva che richiedeva una purificazione attraverso il digiuno e l’entrata in una stanza segreta del tempio, l’abacon, per attendere la guarigione. Le ore e i modi in cui poteva verificarsi erano molto diversi. A Pergamo, per esempio, l’apparizione taumaturgica di Asclepio si verificava nelle ore notturne, quando il devoto dormiva o era in dormiveglia, e al suo risveglio i sacerdoti gli davano ulteriori indicazioni terapeutiche, particolarmente a scopo preventivo, riguardanti per es...
Indice dei contenuti
- Presentazione
- Introduzione
- PARTE I – IL FASCINO DELL’INVISIBILE
- PARTE II – SOGNI STRAORDINARI
- Renzo Rossin
- Note di copyright