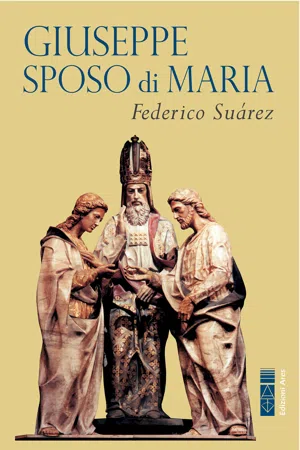
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Giuseppe sposo di Maria
Informazioni su questo libro
Un uomo qualsiasi. Un umile artigiano vissuto in una sperduta provincia dell'Impero romano. È Giuseppe di Nazaret. Di lui non ci resta una parola. Passa per il Vangelo come un'ombra silenziosa. Non sappiamo neanche quando sia morto. Ma è lecito fermarsi a questo? Federico Suárez, assimilando le scene evangeliche, ripercorre i lineamenti della persona e della vita di Giuseppe fino a mostrarcelo qual è: il più grande santo, dopo Maria. Dio stesso, Gesù, gli sarà sottomesso. A Dio stesso, a Gesù, egli insegnerà a camminare, a parlare, a lavorare tra gli uomini. Sarà testimone silenzioso degli avvenimenti più straordinari della storia di ogni tempo. Federico Suárez coglie e comunica, di Giuseppe, l'insegnamento semplice e decisivo: che questa nostra vita quotidiana, vissuta con perfezione umana, rivela la splendida trama dell'amore divino che attende di incontrarsi con le nostre quotidiane aspirazioni. Per questo Dio si è fatto uomo. E Giuseppe è stato colui che meglio e per primo, con Maria, ha saputo accoglierlo sulla terra. Per questo san Giuseppe è patrono della Chiesa universale, e maestro di preghiera.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Giuseppe sposo di Maria di Suárez Federico in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Bibbie. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Teologia e religioneCategoria
BibbieIl figlio del carpentiere
Concludendo l’episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio, san Luca racconta che egli «partì con loro e tornò a Nazaret». Qui, a Nazaret, sembra essersi svolta praticamente tutta la vita di Giuseppe. «E che cosa può attendersi dalla vita l’abitante di un villaggio sperduto come Nazaret? Lavoro e null’altro che lavoro; tutti i giorni, sempre con lo stesso sforzo. Poi, terminata la giornata, una casa povera e piccola, per ristorare le forze e ricominciare a lavorare il giorno dopo» (Josemaría Escrivá).
Così trascorse la vita di Giuseppe al ritorno dall’Egitto, del resto identica a quella che era stata anche prima, dalla fine dell’infanzia. Probabilmente morì prima che Gesù desse inizio alla vita pubblica. A Nazaret, tuttavia, lo si ricordava anche più tardi, e i riferimenti evangelici precisano che lo si ricordava soprattutto per la sua condizione di lavoratore.
«Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa trent’anni, ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe» (Lc 3,23). Così san Luca, dopo aver dedicato un breve resoconto al battesimo di Gesù, apre con la sua genealogia gli anni della vita pubblica. Poco più avanti, in occasione della visita che Gesù fece a Nazaret – e che diede magri frutti per l’incredulità dei suoi compaesani –, riporta il commento del popolo stupefatto per la sapienza delle sue parole: «Non è il figlio di Giuseppe?» (Lc 4, 22).
Questa volta san Luca ha preferito ricordare Giuseppe, mentre è stato Matteo a menzionare la Vergine: «Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria?» (Mt 13, 55). San Marco fa eco a Matteo: «Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria?» (Mc 6, 3).
Bisogna precisare che il termine «falegname», spesso usato nelle traduzioni, non è il più adeguato a designare Giuseppe, né, del resto, Gesù. Faber, dice la Vulgata con un vocabolo che nell’opinione più diffusa va tradotto con «artigiano». Giuseppe era quindi un artigiano, un lavoratore che si guadagnava con le mani di che vivere per sé e per i suoi. L’identificazione del mestiere di Giuseppe con quello di falegname va fatta probabilmente risalire a san Giustino, che l’ha egli stesso adoperata nel suo Dialogo con Trifone. Tenuto conto della sua autorità e del fatto che scriveva nel II secolo, non c’è da meravigliarsi che alla lunga la tesi sia prevalsa. Il termine usato dal testo greco può tuttavia designare tanto un operaio che lavora il ferro quanto uno che lavora il legno. Sant’Ambrogio, e con lui santuario, si è espresso per un Giuseppe fabbro, e conta un certo seguito. In fin dei conti, un’ipotesi non esclude l’altra, se si pensa che Nazaret non era poi una città tanto grande da annoverare, per così dire, operai specializzati: come succede nei paesi piccoli, più che specializzarsi si era soliti imparare a risolvere i problemi di ogni giorno, a soddisfare le necessità più immediate della gente qualsiasi che viveva nel circondario; in una parola, bisognava intendersi di varie cose. C’è anche chi traduce il termine greco con «maestro edile, costruttore di case», e qualche autore antico – senza gran fondamento, in verità – dice che Giuseppe era orefice.
Quale che fosse la sua occupazione, non v’è dubbio che si trattava di una mansione umile, di scarso rilievo: «Un operaio che lavorava al servizio dei suoi concittadini, con un’abilità manuale derivante da lunghi anni di sforzi e di sudore» (Josemaría Escrivá).
Era un uomo povero, con una famiglia a carico. In quanto capofamiglia gli toccava la responsabilità di mantenere decorosamente i suoi famigliari, e in quanto povero non aveva altro capitale che la conoscenza di un mestiere, capitale che doveva far fruttare mediante il lavoro. E anche in ciò risalta la fisionomia peculiare di Giuseppe, incline ai risvolti più quotidiani e semplici della vita (che non si identificano affatto con quelli facili). Ha perseverato nello stesso lavoro incrollabilmente, quasi che si fosse imposto come un motto personale il consiglio del Siracide: «Sta’ fermo al tuo impegno e fanne la tua vita, invecchia compiendo il tuo lavoro» (Sir 11, 20). Tutta una vita di lavoro; ma un lavoro svolto con piacere, un continuo servire, senza darvi peso, non solo – seppure principalmente – Gesù e Maria, ma chiunque avesse bisogno della sua abilità e del suo impegno.
Come san Paolo più tardi, neppure Giuseppe ha mangiato a ufo: ha lavorato con lena e fatica, giorno e notte, per non essere di peso ad alcuno (2 Ts 3, 8). Si industriò pertanto affinché alla sua piccola famiglia non mancasse il necessario: certo, un regime mai più che sufficiente, perché fu sempre povero. Inoltre non si limitò alla mera materialità del fabbricare oggetti, di eseguire commissioni. C’è modo e modo di lavorare: il lavoro si può svolgere con risentimento, con indifferenza quasi meccanica, con poco o punto interesse; o, al contrario, di gusto. Di solito soltanto da un lavoro compiuto volentieri risulta un buon lavoro, che sarà buono perché amato. Il lavoro possiede una dignità elevatissima, la quale – lo ha ricordato san Josemaría – «è fondata nell’amore», poiché è l’amore per l’opera ben fatta che possiede la capacità di esaltare il più umile dei mestieri... e colui che lo svolge.
Il lavoro è stato l’attività cui Gesù ha dedicato la massima parte della propria vita. Dunque è stato da Lui santificato e dotato di valore redentivo, al punto da divenire capace di trascendere i limiti naturali per convertirsi in un’offerta a Dio e, più ancora, in una collaborazione all’opera della Redenzione. A condizione, però, che davvero lo si svolga con amore: infatti è proprio l’amore a purificare il lavoro da qualsiasi eventuale residuo di servilismo, per trasformarlo in un servizio. È allora che ci si prodiga per rifinire l’opera, e, insieme, che si può a pieno titolo parlare di onore del lavoro, l’onore sul quale Charles Péguy ha scritto pagine così splendide che meritano una citazione, ancorché lunga: «Conosciamo un onore del lavoro [...]. Abbiamo conosciuto un impegno spinto fino alla perfezione, identica nell’insieme e nel dettaglio più minuto. Abbiamo conosciuto la pietà dell’opera ben fatta, condotta alle esigenze più estreme [...]. Quegli operai... avevano onore. Era necessario che una gamba di sedia fosse ben fatta. Era sottinteso. Era una manifestazione di superiorità. Non bisognava farla bene per forza, a causa del salario, o in vista del salario. Non bisognava farla bene per il padrone, o per gli intenditori, o per i clienti del padrone. Era necessario che fosse ben fatta per sé stessa, in sé stessa, di sé stessa, nel suo stesso essere. Una tradizione che rimonta al più intimo della razza, una storia, un assoluto, un onore, volevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. Ogni gamba di sedia, quantunque non tutte fossero in vista, era tanto perfetta quanto lo era quella che si vedeva. È lo stesso principio cui dobbiamo le cattedrali [...].
«Tutti gli onori convergevano in questo. La decenza e finezza dell’espressione. Il rispetto per il focolare domestico. Un senso del rispetto, di qualsiasi rispetto, dell’essere stesso del rispetto, per così dire. Tutto era una cerimonia costante. Spesso, d’altra parte, la casa si confondeva con la bottega, e l’onore della casa e quello della bottega erano un solo onore [...]. Tutto era ritmo e cerimonia, dalla luce dell’aurora. Tutto era esempio e insegnamento, tutto rispondeva a una tradizione, tutto concorreva alla consuetudine più sana. Tutto era elevazione interiore, e preghiera l’intera giornata, il sonno e la veglia, il lavoro e il parco riposo, il letto e la mensa, la zuppa e la carne, la casa e il giardino, la porta e la strada, il cortile e la soglia, e il piatto sulla tavola [...].
«E, come conseguenza, tutti gli splendidi sentimenti derivati e filiali. Il rispetto per gli anziani, per i genitori, per la famiglia. Un ammirevole rispetto per i bambini. Rispetto, naturalmente, per la donna: ed è davvero opportuno precisarlo, poiché oggi ci si preoccupa sempre meno di rispettare la donna, per sé stessa. Rispetto per la famiglia e il focolare. E, soprattutto, il piacere e il rispetto del rispetto stesso. Rispetto per l’utensile e per la mano, supremo utensile».
Péguy ha scritto II denaro, da cui abbiamo ripreso il passo che precede, nel 1912. Sebbene possa sembrare che le sue parole non si attaglino né all’epoca di Giuseppe di Nazaret né alla nostra, alcune sue osservazioni ben meritano un commento. Nell’infanzia Péguy vide artigiani che ancora lavoravano a casa propria. Casa e bottega erano un tutt’uno. Un artigiano modesto e però indipendente, non soggetto a un principale: questo sembra essere stato san Giuseppe. Compiti diversi, oggetti utili a scopi svariati, lavorati da cima a fondo, finché l’opera non fosse ben rifinita. Sì, una vita «semplice, normale, comune, fatta di anni di lavoro uguale, di giorni che si susseguono con apparente monotonia» (Josemaría Escrivá); ma nel contempo sempre nuovi, perché ogni giornata ha la sua irripetibile maniera per scoprire Dio nello svolgimento dell’opera quotidiana. Davvero importante è lavorare al cospetto di Dio: a tal punto che proprio in ciò consiste la differenza tra il mero lavoro, per buono che sia, e quel lavoro che, oltre a essere buono, trascende i limiti della natura per divenire mezzo di santificazione.
Un lavoro d’artigiano, di quelli che sembrano non conoscere spazio per la precipitazione. Un lavoro svolto senza impazienza, senza forzare i tempi, con tranquillità. Insomma un lavoro ben fatto, senza risparmiare le ore, perché la strada migliore non sempre è la più breve, ma anzi è talora la più lunga. E lui, Giuseppe, aveva tutto il tempo di questo mondo. Non lo stringeva l’ansia di produrre molto per guadagnare altrettanto, magari a costo di un lavoro affrettato e approssimativo. Aveva il necessario, e né lui né la Vergine bramavano nulla di più: davvero hanno dettato la misura della virtù cristiana della povertà, quella misura che san Josemaría ha ridestato alla mentalità dell’uomo contemporaneo in un punto di Cammino: «Distàccati dai beni del mondo. – Ama e pratica la povertà di spirito: contentati di quello che basta per trascorrere la vita con sobrietà e temperanza. – Altrimenti, non sarai mai un apostolo» (n. 631). Per questo, forse, far bene il lavoro riesce più facile a un uomo poco (o per nulla) ambizioso: ne avrà troppa stima per sbrigarlo come capita, e si preoccuperà di curare i dettagli e di rifinirlo per bene.
Non importa che un lavoro sia umile, niente affatto vistoso, poco apprezzato. I lavori più raffinati sono anche, solitamente, i meno necessari alla gran parte degli uomini, e per ciò stesso i più superflui. È più necessario, e rende un servizio maggiore, fare il pane piuttosto che disegnare un gioiello; è più utile un armadio che un soprammobile di porcellana, e per qualsiasi famiglia è più facile fare a meno di un elaborato lampadario di cristallo che di un tavolo.
È pur vero che vi sono compiti che gli uomini dicono nobili, e altri che essi considerano vili: arti liberali e mansioni servili, occupazioni intellettuali e mestieri manuali. Ma è altrettanto vero che agli occhi di Dio le cose che contano sono altre, perché «il lavoro, essendo stato assunto da Cristo, diventa attività redenta e redentrice: non solo è l’àmbito nel quale l’uomo vive, ma mezzo e strada di santità, realtà santificabile e santificatrice». Per questo motivo san Josemaría, cui si devono queste parole – ed è mia opinione che gli si debba altresì la più feconda chiarificazione del lavoro come vocazione cristiana, e insieme una delle più feconde sul piano delle conseguenze –, affermava che l’efficacia di un lavoro si misura dai risultati che ne derivano per la santificazione di chi lo svolge. Da qui sorge un’altra conseguenza che non può essere trascurata, la cui consapevolezza è altrettanto notevole e proficua: che l’importanza di un lavoro non consiste nella sua rilevanza esterna, nel fatto che sia di un tipo o di un altro, bensì nell’amore che si pone nel farlo, nell’amore con cui lo si svolge. Dunque un buon falegname è più ragguardevole di un cattivo professore, e il lavoro di una donna delle pulizie può essere, davanti a Dio, più insigne che quello di un ministro. Sotto la rustica parvenza di alcune occupazioni si cela un’intima nobiltà che passa inavvertita agli occhi degli uomini; ma non allo sguardo amoroso di Dio, che è più acuto e adotta un metro diverso per valutare le cose, il lavoro e le azioni umane.
Per noi, uomini qualsiasi che passiamo la vita immersi in un lavoro comune; per le donne che si affaccendano un giorno dopo l’altro nei medesimi compiti, a un medesimo ritmo e in una costante assenza di elogi, come se niente di ciò che fanno avesse la minima importanza; per gli operai che sudano in occupazioni che nessuno nota, perché prive di rilievo; per tutti coloro il cui lavoro è oscuro e privo di splendore, il lavoro di Giuseppe, artigiano di un villaggio di poco conto («Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?», Gv 1, 46), è un esempio e un conforto.
Il suo lavoro non fu comodo, non fu brillante; grazie a esso, però, mantenne quella piccola famiglia. Fu monotono, privo di grandi prospettive, non produsse capolavori; e tuttavia la sua costanza non venne meno, né il suo sforzo paziente e quotidiano. Egli non fu un uomo inquieto, scontento del suo dovere, propenso a passare continuamente da un’occupazione all’altra, sempre insoddisfatto e ansioso di trovare nel mutare delle situazioni quella pace che in realtà esiste solo nel cuore dell’uomo: quando non si ama il lavoro, infatti, è impossibile trovarvi soddisfazione nonostante qualsiasi cambiamento. E non è facile amare il lavoro se vi manca il riferimento a Dio e al piano di Dio.
Vero è che nello svolgimento del lavoro, o davanti al lavoro compiuto, non sempre è dato di sentire soddisfazione. Talvolta non potremo offrire a Dio altro che la fatica, la stanchezza conseguente allo sforzo, il lavoro di ogni giorno, sempre lo stesso, che non manifesta nemmeno una sfumatura di novità, o l’ombra di un merito che qualcuno saprà apprezzare. Una fatica niente affatto gloriosa come quella, per esempio, che può provare un atleta alla fine della gara: una stanchezza priva di gloria quanto il lavoro che l’ha provocata. Non importa. Giuseppe di Nazaret ha vissuto tutto questo nel suo lavoro, ed è passato anche per contrarietà di ben altro spessore. Anche Gesù ha conosciuto la spossatezza e la fatica della bottega, e la monotonia dei giorni senza rilievo e senza storia. Ciò nonostante, nessuna occupazione è mai stata più fruttuosa di quella di Giuseppe. Il grande Lope de Vega, nella commedia che scrisse sulla nascita di Cristo e sul ritorno dall’Egitto, ha saputo cogliere un aspetto tra i meno luminosi, ma non tra i meno importanti:
«Angelo:
Mille volte sia benedetta
la sua umiltà divina e santa,
perché tanto Giuseppe essa esalta
quant’egli a umiliarsi s’industria!
Voi vivete, Signore eterno,
del suo lavoro?
Gesù:
Egli mantiene la mia vita,
e io per suo mezzo
vivo, m’albergo e governo.
Di Giuseppe, mio padre legale,
tanta è la preminenza,
da dare sostegno a quel Dio
che è sostegno universale.
A Giuseppe dovrà il suolo
il sangue che io gli darò,
che venne dal suo lavoro.
Angelo:
Il cielo benedica il tuo nome!
Gesù:
Il sangue col quale io nacqui,
intero si deve a Maria;
quello che pulsa ogni giorno
a Giuseppe è dovuto».
E aveva ragione Péguy di aggiungere, parlando del lavoro: «Maestri, sacerdoti, genitori, tutti ci dicevano che un uomo che lavora bene e che sa ben comportarsi può stare sicuro che mai mancherà di nulla». In queste due cose sta la dignità del povero, e da qui viene la sua ...
Indice dei contenuti
- Premessa
- La figura di san Giuseppe
- Un uomo silenzioso
- Lo sposo di Maria
- Poiché era giusto
- Mentre rifletteva
- E prese con sé la sua sposa
- Trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino
- E lo chiamerai Gesù
- Simeone li benedisse
- Alzati e fuggi in Egitto
- Resta là
- Ebbe paura di andarvi
- Tornarono in cerca di lui a Gerusalemme
- Al vederlo restarono stupiti
- Tuo padre e io
- Non compresero le sue parole
- Stava loro sottomesso
- Il figlio del carpentiere
- Servo fedele e saggio
- Indice