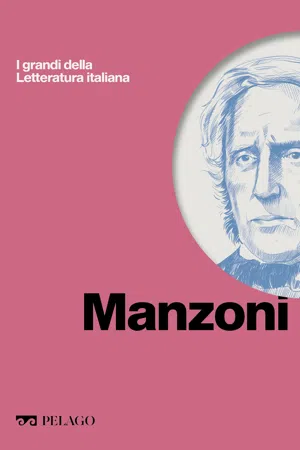
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Con
I promessi sposi, Alessandro Manzoni ha trasformato il romanzo storico da opera letteraria di pura evasione, ambientata in cornici scenografiche, con personaggi artificiosi e aristocratici e rivolta all'
élite intellettuale, in una narrazione vicina alla verità storica e con gli umili, e i loro ambienti, al centro della scena. Il suo obiettivo era la formazione morale della società italiana, ovvero la borghesia emergente dei primi decenni dell'Ottocento. Una formazione che riguardava la cultura e l'etica ma anche la lingua, quell'italiano di matrice toscana che ancora non era diffuso, di fatto, sull'intero territorio nazionale. E come in altre opere dell'ex teista Manzoni, su tutto aleggia il ruolo salvifico della Provvidenza, la «provida sventura», che non impone però il cieco abbandono ai disegni divini ma deve essere mediato – ed è questa la novità cruciale – dal comportamento e dalle responsabilità individuali.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
LiteratureCategoria
Education GeneralIL SUO MONDO E LE SUE IDEE
UN MILANESE EUROPEO
Per comprendere appieno Manzoni, bisogna subito cogliere la sua statura intellettuale europea. Pienamente milanese per nascita e per educazione, egli ebbe tuttavia la fortuna di conoscere profondamente la cultura francese: soggiornò infatti a Parigi insieme alla madre Giulia Beccaria, una prima volta dal 1805 al 1810 (seppure con frequenti intervalli dovuti a viaggi in Italia per vari motivi); una seconda volta, con tutta la sua ormai numerosa famiglia, dal 1819 al 1820.
La Milano degli ultimi decenni del Settecento e dei primi dell’Ottocento era la città culturalmente più vivace della penisola italiana:
è la città dei fratelli Verri, di Giuseppe Parini, di Vincenzo Monti, di Ugo Foscolo e poi dei primi romantici italiani (Carlo Porta, Silvio Pellico, Giovanni Berchet, Tommaso Grossi, Ermes Visconti ecc.), di riviste come Il Caffè prima e Il conciliatore poi.
Parigi, a sua volta, è la capitale culturale d’Europa: quando vi abita Manzoni vi si sente ancora l’influsso dei grandi illuministi francesi, da Voltaire a Diderot a D’Alembert a Rousseau (e vi resta ancora l’eco del celebre viaggio e delle accoglienze entusiastiche riservate al nonno Cesare Beccaria, l’acclamato autore del trattato Dei delitti e delle pene), vi abitano (sia pure emarginati, perché oppositori politici di Napoleone) gli idéologues, riuniti attorno a Claude Fauriel, il grande amico francese di Manzoni. A Parigi, attraverso le traduzioni e soprattutto grazie ai libri di Madame de Stäel, arrivano le opere e le idee dei romantici tedeschi, da Schiller a Goethe a Schlegel; a Parigi Manzoni conosce i romanzi di Walter Scott (in particolare Ivanhoe), che tanta importanza avranno sulla sua decisione di scrivere un romanzo storico.
Il giovane Manzoni è una spugna: introdotto, grazie a sua madre Giulia e al fatto di essere nipote di Cesare Beccaria, nei circoli culturali più avanzati di Parigi (e quindi di tutta Europa), legge e studia e discute di tutto, con grande voracità, confrontandosi in particolare con il suo amico Fauriel, di poco più anziano di lui, che viene in un certo senso a surrogare la figura paterna, che ad Alessandro è sempre mancata.
Inoltre, innesta i nuovi saperi e la nuova organizzazione della cultura diffusa dall’illuminismo francese e poi dal romanticismo tedesco sul solidissimo tronco della tradizione culturale e poetica latina e italiana, da lui studiate e assimilate a fondo durante i non felici ma fruttuosi otto anni di collegio, prima dai Somaschi poi dai Barnabiti. Ve lo aveva lasciato, quando aveva sei anni, la madre, che non voleva occuparsi di lui: nel 1792 si era separata dal marito e aveva iniziato una relazione con Carlo Imbonati, insieme al quale si sarebbe trasferita a Parigi nel 1796 e poi definitivamente nel 1798.
Manzoni si è allontanato da tempo dalla religione cattolica, pur conservando una forte tensione morale e una vaga inclinazione deista; e l’ambiente parigino in cui vive dal 1805 al 1810 è irreligioso, con sfumature che possono andare dall’ateismo dichiarato all’indifferenza al deismo.
Ebbene, proprio in questo ambiente così poco propizio, Manzoni si converte (o, meglio, ritorna) al cattolicesimo; e insieme a lui compiono lo stesso passo la moglie Enrichetta (calvinista, sposata nel 1808) e la madre Giulia. Richiamo questo fatto celeberrimo non per riaprire l’antica e mai risolta questione sulle modalità e sui motivi della conversione, riguardo ai quali Manzoni mantenne sempre il delicato riserbo che meritano certi avvenimenti interiori, ma per sottolineare come anche per questo motivo egli si collochi all’intersezione tra due mondi:
allo stesso modo in cui era milanese e parigino, fortemente italiano e convintamente europeo, così conosceva, anche per esperienza personale, sia le ragioni e il modo di pensare degli atei e dei protestanti sia la ricchezza e la profondità della religione cattolica.
Allo stesso modo, cresciuto ed educato nelle nuove idee illuministe, si trovò ad essere, se non il fondatore, certo l’esponente più autorevole del romanticismo italiano.
Questa sua collocazione al confine tra esperienze culturali, politiche, religiose diverse o addirittura opposte, che egli riuscì a metabolizzare e a mediare raccogliendo da ciascuna di esse gli elementi positivi per trarne una nuova sintesi, per alcuni decenni fece di lui lo scrittore più acclamato d’Europa dopo Goethe: quello stesso Goethe che vedeva nelle opere di Manzoni l’esempio più luminoso della Weltliteratur da lui patrocinata, cioè di quella letteratura mondiale che avrebbe dovuto fornire modelli e ideali per l’umanità futura.
Una prepotente vocazione poetica
Manzoni ha scritto opere di letteratura, di politica, di storia, di religione, di lingua, di filosofia: una produzione per lo più poco nota al grande pubblico, ma di cui, dopo le immotivate critiche mossegli in particolare nei decenni centrali del Novecento, si coglie ora l’importanza, per novità e per profondità.
Tuttavia, egli volle soprattutto essere poeta, e poeta originale:
già nel sonetto autoritratto del 1801 dichiara di amare «la gloria» (s’intende, quella poetica) e «il biondo iddio» (cioè, Apollo, dio della poesia); nel poemetto Urania (1809) confessa che il suo profondo desiderio è che «Italia un giorno / me de’ suoi vati al drappello aggiunga». Più di cinquant’anni dopo, Manzoni manderà alla poetessa francese Louise Colet, che era andata a trovarlo a Milano, quattro strofe di una sua poesia incompiuta e bellissima (si tratta di Ognissanti), accompagnata da una lettera (in francese) in cui rivela che «si tratta di un inno cominciato troppo tardi, e che ho lasciato incompiuto non appena mi sono accorto che non era più la poesia che mi veniva a cercare, ma io che mi affannavo a correre dietro a lei». È il 2 febbraio del 1860: a 75 anni, Manzoni rimpiange di non riuscir più a scrivere versi (in realtà, scriverà un’ultima poesia, in latino, nel 1868).
La concezione manzoniana di letteratura, pur avendo subito degli aggiustamenti, come è naturale in una vita così lunga e in autore così portato alla continua messa in discussione dei suoi stessi principi, può essere sintetizzata nelle righe scritte in una lettera del 2 giugno 1832 a Marco Coen, interessante perché mette a confronto il modello da rifiutare (che era poi quello seguito nei testi prima della conversione) e quello a cui aderire: «C’è una letteratura che ha per iscopo un genere speciale di componimenti, detti d’immaginazione; e dà o piuttosto cerca le regole per farli, e la ragione del giudicarli. Questa letteratura, non che io l’abbia posseduta mai, ma vo ogni giorno, parte dimenticando, parte discredendo quel poco che m’era paruto saperne. […] Ce ne ha un’altra, che è l’arte di dire, cioè di pensare bene, di rinvenire col mezzo del linguaggio, ciò che è di più vero, di più efficace, di più aggradevole in ogni soggetto, che si prenda a considerare o a trattare».
Come si vede, si tratta di una concezione molto ampia di letteratura, la cui modernità possiamo cogliere particolarmente in questi anni, in cui i confini non solo tra i generi, ma anche tra le discipline si sono fatti molto più labili (si pensi per esempio alla docufiction o alla non fiction).
L’insistenza sul vero come oggetto principale della letteratura permette di capire meglio il senso di un’altra convinzione manzoniana: che gli oggetti di cui essa si occupa sono gravissimi, cioè importantissimi e fondamentali per tutta l’umanità, non per i soli letterati:
«Tutto ciò che ha relazione con l’arti della parola, e coi diversi modi d’influire sulle idee e sugli affetti degli uomini, è legato di sua natura con oggetti gravissimi» (Prefazione al Conte di Carmagnola, 1820). La letteratura ha quindi responsabilità molto forti, che la collocano di conseguenza tra le scienze morali:
“ALLORA LE BELLE LETTERE SARANNO TRATTATE A PROPOSITO QUANDO LE SI RIGUARDERANNO COME UN RAMO DELLE SCIENZE MORALI.1”
Verità, libertà, originalità
Amore per la verità, amore per la libertà, ricerca di originalità: queste sono le costanti che caratterizzano tutta la produzione letteraria manzoniana.
Manzoni ha appena compiuto quindici anni quando scrive il poemetto Il trionfo della libertà (1801): vi si celebra la libertà portata a Milano dalla Rivoluzione francese, anche in opposizione alla rigida e reazionaria educazione ricevuta nei collegi religiosi. Ma è significativo che l’eroe di questo poemetto del 1801 non sia Napoleone, che già mostrava i segni della sua deriva dittatoriale, ma il generale Louis Charles Antoine Desaix, a cui le truppe francesi dovevano la vittoria nella fondamentale battaglia di Marengo, nella quale egli aveva trovato la morte.
A ottantatré anni, nel 1868, Manzoni scrive uno dei suoi ultimi testi, la poesia in distici latini Volucres (Uccelli): gli uccelli rinchiusi nella voliera dei giardini pubblici di via Palestro a Milano invidiano le anatre che possono volare libere («Beate le anatre, cui il cielo ride aperto e le acque dello stagno si aprono libere sull’ampia sponda…»).
Tema comune ai due testi è quindi la libertà. Da un capo all’altro della sua lunga vita, Manzoni è sempre stato animato da una tensione alla libertà che si manifesta in tutte le sue opere, assumendo diverse forme: la libertà politica, la libertà religiosa, la libertà dalle passioni, la libertà di giudizio, la libertà nelle scelte linguistiche, retoriche, formali.
La conversione permetterà a Manzoni di scoprire che queste diverse forme di libertà non sono altro che la conseguenza della libertà fondamentale, quella insegnata e donata da Cristo: cioè, la libertà dal peccato.
La stessa continuità si può cogliere a proposito dell’altro grande tema manzoniano, l’amore al vero: già nei Versi in morte di Carlo Imbonati (1806) Manzoni dichiara il proprio programma: «il santo vero / mai non tradir». Nel 1872, alla bella età di 87 anni, così descrive in due versi, scherzosi ma non troppo, le proprie condizioni: «Gambe, occhio, orecchio, naso e ahimè pensiero / non n’ho più uno che mi dica il vero». Il venir meno delle facoltà fisiche e mentali provoca in lui un solo cruccio: la difficoltà, conseguente al decadimento, di conoscere il vero.
La fedeltà al vero costituisce una sorta di faro che ha sempre guidato Manzoni, prima e dopo la conversione: anche in questo caso, la conversione non fa che ricondurre alla Verità di Cristo tutti i veri a cui Manzoni si è di volta in volta dedicato, sulla scorta delle parole da Lui dette nel Vangelo di Giovanni, 8, 32: «conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Questa tensione continua al vero storico non è altro che la manifestazione per dir così più visibile e più concreta della tensione verso un’altra verità, quella manifestata dalla Rivelazione, che fornisce la chiave per comprendere appieno l’uomo: «tutto si spiega con il Vangelo, tutto conferma il Vangelo», scrive Manzoni nella Morale Cattolica (1819, ristampata nel 1855): «i misteri conciliano le contradizioni, e le cose visibili s’intendono per la notizia delle cose invisibili».
Questo passo ci fa anche comprendere che Manzoni è arrivato alla fede mosso dalla necessità di capire: ha trovato nella Rivelazione non solo l’incontro con Cristo, con il Dio fatto uomo, ma anche una spiegazione razionale dei misteri e delle contraddizioni della vita dell’uomo. Gli esempi della fedeltà al vero sono innumerevoli, soprattutto nella versione della fedeltà al vero della storia: basti pensare alle minuziose ricerche storiche che Manzoni compie per le sue due tragedie (Il conte di Carmagnola, 1820; Adelchi, 1822) e per I promessi sposi (1827, 1840) e la Storia della colonna infame e, in vecchiaia, al documentatissimo Saggio comparativo sulla rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859.
Anche la terza costante è enunciata da Manzoni ben presto, già nel sonetto alla Musa del 1802 (aveva allora diciassette anni): «s’io cadrò sul colle ascreo, / dicasi almen: su l’orma propria ei giace». Cioè, dice Manzoni, se cadrò lungo la salita che porta alla gloria poetica, si possa almeno dire che ciò è avvenuto perché non ho seguito la via tracciata da altri, ma ne ho cercata una nuova.
Anche a questo programma Manzoni rimase sempre fedele, in tutti gli ambiti. In quello letterario, sperimentando forme e argomenti in gran parte (se non del tutto) nuovi: basti ricordare che fu il primo in Italia a scrivere tragedie senza le unità di tempo e di luogo e a scrivere un romanzo, che, per di più, ha come protagonisti dei personaggi di umile condizione; in ambito storico sottoponendo a verifica convinzioni storiografiche ai suoi tempi ritenute indiscutibili e approdando a conclusione diverse (basti pensare alla riabilitazione degli untori condannati dai giudici milanesi nel 1630 operata nella Storia della colonna infame); in quello generalmente culturale combattendo una strenua battaglia contro i luoghi comuni, in tutti i campi del sapere.
Fedeltà al vero, amore per la libertà, originalità di scrittura e di giudizio si fondono poi tra di loro in un unico, inscindibile impasto:
poiché è chiaro, ad esempio, che la scelta di forme metriche originali o di una lingua nuova per un genere nuovo non è altro che la necessaria conseguenza del desiderio di trovare le modalità metriche e retoriche e linguistiche più adatte a raccontare il vero che di volta in volta Manzoni assume come oggetto; e si radica in una attitudine di libertà grazie alla quale lo scrittore riesce a svincolarsi dai legami tanto delle idee ricevute e dei luoghi comuni quanto delle forme metriche e retoriche trasmesse dalla tradizione letteraria.
Libertà e politica
La libertà, che è frutto della verità, è un dono individuale, che si realizza innanzitutto nel rifiuto del peccato, il quale rende schiavi; ma è anche una aspirazione sociale, che investe quindi la sfera politica. Dio ha voluto e vuole che siano liberi non solo gli individui, ma anche le nazioni: e ciò deve valere pure per l’Italia, ai tempi di Manzoni divisa in numerosi Stati, tutti sotto il dominio straniero (eccezion fatta per lo Stato della Chiesa: ma Manzoni era contrario al potere temporale dei papi, convinzione che gli provocò non poche critiche in certi ambienti cattolici).
Spesso si dipinge Manzoni come un letterato pavido, rinchiuso nel suo particulare: ritratto sbagliatissimo. Infatti, egli dedicò tutte le sue opere e tutta la sua vita a perseguire (con i propri mezzi, s’intende, senza imbracciare fucili né scendere sulle barricate) la libertà e l’indipendenza dell’Italia. Tanto è vero che dovette sempre combattere con la censura del governo austriaco, che non solo apriva e leggeva tutte le sue lettere, ma anche interveniva sulle sue opere: dovette riscrivere parte del primo coro dell’Adelchi, perché troppo evidente era l’equiparazione tra i latini oppressi da Franchi e Longobardi e gli italiani oppressi dagli austriaci; non poté pubblicare il Cinque Maggio; i suoi contemporanei capirono subito che la situazione della Lombardia del Seicento sotto il malgoverno spagnolo descritta nei Promessi sposi adombrava la situazione contemporanea, eccetera.
Nel 1817 gli fu negato il passaporto e non poté quindi recarsi a Parigi, come avrebbe desiderato. Nel 1848 appoggiò le Cinque Giornate di Milano: il figlio Filippo, assieme ad altri figli di notabili milanesi, fu preso in ostaggio dagli austriaci, ma ciò nonostante egli firmò una petizione a Ca...
Indice dei contenuti
- Collana
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- L’alfabetizzazione etica di una società
- PANORAMA
- FOCUS di Pierantonio Frare
- APPROFONDIMENTI
- Piano dell’opera
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Manzoni di Pierantonio Frare, AA.VV.,AA.VV., Pierantonio Frare in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Literature e Education General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.