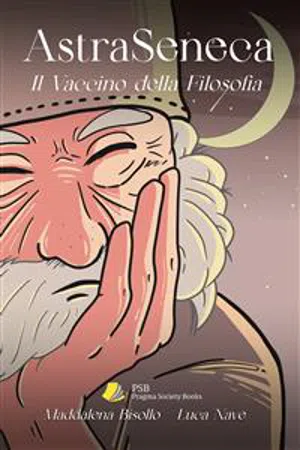
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
AstraSeneca. Il vaccino della filosofia
Informazioni su questo libro
Il volume presenta AstraSeneca, il vaccino della filosofia che predispone all’immunità dalle “malattie dell’anima”fin dai tempi della Grecia Antica. Contiene le istruzioni per l’autosomministrazione dell’antidoto preparato dalla farmacia dei filosofi.
Non serve recarsi nei centri per la somministrazione dislocati sul territorio né serve il ricorso a un somministratore esperto. Qui ognuno può fare da sé, può decidere spazi e tempi della prima somministrazione e di quelle - fortemente raccomandate - successive.
Il vaccino AstraSeneca è stato inventato in Grecia circa venticinque secoli fa. Da allora, è stato somministrato a migliaia di persone. Dichiariamo, quindi, ufficialmente e solennemente, che non è mai morto nessuno in seguito alla somministrazione e nessuno ha subìto gravi effetti collaterali.
AstraSeneca può avere effetti di trasformazione della propria visione del mondo ma ciascuno decide il livello di profondità del mutamento. Buona lettura e buon vaccino.
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Informazioni
Capitolo terzo. I rimedi di AstraSeneca
Presentazione del vaccino
“Le cose esteriori non giungono mai a toccare l’animo nostro, ma restano sempre immobili al di fuori, e ogni turbamento dipende dall’interiore valutazione” (Marco Aurelio, 1989, p. 3).
E ancora:
“Le cose per sé stesse non riescono a toccare l’anima nemmeno un po’, né vi penetrano né possono mutarla e smuoverla. È l’anima che da sola si muta e si muove e gli avvenimenti sono per essa tali, quali i giudizi che essa ne formula” (Id., p. 19).
L’obiettivo primario di AstraSeneca è agire direttamente sulle emozioni malsane. Poiché queste non esistono come cose in sé ma sono direttamente collegate con l’ideazione, con la valutazione e, in generale, con la visione del mondo del soggetto, esse possono essere controllate in modo efficace mediante i processi di un pensiero razionale, cioè di un modo di pensare sano che ha il potere di ridurre la potenzialità delle emozioni negative che generano sofferenza. La preminenza dei processi di pensiero, dell’aspetto razionale, sui moti e gli stati dell’animo, deriva dalla precisa convinzione che la fonte di ogni turbamento interiore risieda nell’“interiore valutazione” o “giudizio” che l’individuo dà degli eventi del mondo.
L’immunità nei confronti dei mali dell’anima passa attraverso una terapia delle idee. Ogni scuola ha le proprie teorie e le proprie specifiche terapie ma tutte collegano la terapeutica filosofica a una trasformazione profonda della maniera di vedere il mondo e di essere nel mondo del soggetto. I rimedi che presentiamo in questo capitolo - che rappresentano le componenti essenziali di AstraSeneca - hanno lo scopo di favorire questa trasformazione. Mutare il proprio modo di vedere il mondo e di interpretare gli eventi che accadono non è semplice e avviene lentamente. Modificare schemi mentali e comportamentali radicati può richiedere un laborioso percorso attraverso un processo di mutamento delle proprie abitudini mentali. “La vita mentale sana - scrive Seneca - è un dono della tenacia” (Seneca, 1974, p. 59).
Ribadiamo che purtroppo non esistono pillole di saggezza che possano garantire l’immunità dalle malattie dell’anima, la salute della mente e il benessere nella vita ma gli antichi filosofi hanno elaborato delle cure e degli esercizi spirituali che possono accompagnare lungo la trasformazione del proprio modo di pensare e di vedere il mondo.
Come usare AstraSeneca
Ribadiamo che l’aspetto positivo di AstraSeneca è che, di norma, non ha effetti collaterali dannosi. Come ogni vaccino, tuttavia, non potrà aiutare nell’immediato e il suo effetto si potrà vedere solo con il passare del tempo, ma la sua somministrazione avrà un’influenza positiva sullo sviluppo di una personalità sana ed equilibrata, per quanto apparentemente impercettibile possa essere. La sua azione terapeutica è di natura soprattutto preventiva, rinforza prevalentemente il sistema immunitario nel corpo, così i pensieri sani tonificano le difese della mente.
AstraSeneca non offre le sue migliori prestazioni nel momento in cui si tratta di superare situazioni di malattia in atto e di sofferenza cronica, ma contribuisce a evitare che tali situazioni si presentino. In caso di dolore acuto e di grave sofferenza psichiatrica in atto, i benefici di AstraSeneca sono limitati, a meno che le sue componenti non siano già radicati in noi. Vaccinarsi con la filosofia consente di dotarsi di logoi, di equipaggiarsi cioè di pensieri salutari che siano a portata di mano quando servono, che ci vengano in soccorso spontaneamente e automaticamente all’occorrenza, per non venire turbati e travolti dagli eventi (abbandono, separazione, lutto, malattia, morte, ecc.) e dalle passioni. In altri termini, AstraSeneca mira a variare i pensieri in matrici d’azione, a trasformare il logos in ethos.
In questo caso potremmo attingere ai pensieri e alle esperienze vissute e interiorizzate per riattivare immediatamente il sistema immunitario mentale di cui disponiamo.
AstraSeneca richiede diverse somministrazioni nel tempo, ma i tempi di somministrazione li può stabilire il soggetto che patisce le malattie dell’anima non il somministratore del vaccino. Senza un richiamo costante non avviene una “interiorizzazione” e una “incorporazione”, non si genera l’abitudine al pensare in maniera sana e, di conseguenza, non si genera alcun atteggiamento interiore in grado, nel momento del bisogno, di metterci in guardia automaticamente e con efficacia dal non cadere nella trappola delle emozioni malsane.
“Fare progressi significa rendere un pensiero parte di sé stessi, e grazie alla riflessione quotidiana, raggiungere il punto in cui i pensieri guaritori compaiono da sé e quando desideriamo siano a disposizione ovunque e immediatamente” (Seneca, 1974, p. 60).
1. La cura degli errori del giudizio e della rappresentazione
La cura del pathòs riguarda innanzitutto la seconda proposizione e consiste nel mostrare al soggetto afflitto a non ritenere giusta (cioè eccessiva o spropositata) la sua reazione, naturalmente prima che il pathòs si cronicizzi diventando disposizione morbosa inveterata ( arròstema); a questo punto si interviene sull’errore di giudizio espresso dalla prima proposizione che, spogliato dalla componente “pato-logica” non è più una passione ma kakìa, cioè stoltezza o ignoranza che possono essere curati con la filosofia.
La cura degli errori del giudizio impone di prestare attenzione al proprio discorso interiore, a ciò che ci diciamo continuamente nel dialogo tra sé e sé, anche se spesso non ne siamo consapevoli. È necessario controllare il discorso interiore con un’autoanalisi che ha lo scopo di stabilire se in esso non si sia insinuato un errato giudizio di valore andando così ad aggiungere alla rappresentazione comprensiva della realtà qualche elemento ad essa estraneo.
Questa cura consiste nel farsi una rappresentazione esatta, in un certo senso “fisica”, degli oggetti o degli avvenimenti. Scrive Marco Aurelio:
“occorre sempre dare una definizione o descrizione dell’oggetto che si presenta nella rappresentazione, al fine di vederlo in sé stesso, qual è nella sua essenza, messo a nudo tutto intero in tutte le sue parti […] e dire a sé stessi il suo vero nome e quello delle parti che lo compongono e nelle quali si risolverà” (1989, p. 37).
Il primo passo per mettere in atto questa cura consiste dunque nel definire l’oggetto o l’evento in sé stesso, così com’è, separandolo dalle rappresentazioni convenzionali che si possono acquisire dalla società e dagli altri. Le rappresentazioni che ciascuno si fa del mondo “colpiscono in pieno le cose, anzi le penetrano, le attraversano da una parte all’altra, di modo che si vedono le cose quali sono in sé stesse. Quando le cose appaiono troppo seducenti, mettile a nudo, scorgi la loro bassezza, spogliale di quelle storie che si narrano su di esse e di cui si inorgogliscono” (id.). La rappresentazione ha sempre un certo valore affettivo, poiché designa non solo l’immagine di un oggetto ma l’immagine di un oggetto accompagnata da un falso giudizio relativo all’oggetto stesso.
Questa cura cambia il nostro modo di valutare gli oggetti e gli eventi della vita. Nel valutare le cose, si applica un sistema di valori che spesso viene ereditato dalla tradizione ed è falsato dagli elementi passionali. È quello che Marco Aurelio chiama “vanità”, cioè “l’apparenza gonfiata dall’opinione”. Il metodo “fisico” per la definizione delle cose vuole eliminare l’antropomorfismo, ovvero “l’umano, troppo umano” che si aggiunge alle cose quando vengono rappresentate.
“Non dire a te stesso più di quello che le prime rappresentazioni ti fanno conoscere dell’oggetto. Ti riferiscono che un certo individuo ti diffama: ma con questo non ti si dice che tu ne sia danneggiato” (Id, p. 132).
Il meccanismo è il seguente: si presenta alla nostra conoscenza un certo fatto oggettivo, ad esempio “un tale ha detto certe parole che ci riguardano”. Questa è la prima rappresentazione a cui spesso si aggiunge, spontaneamente, una seconda rappresentazione che si esprime con un discorso interiore: “queste parole calunniose mi oltraggiano e mi danneggiano”. Al giudizio di esistenza in merito a ciò che accade si aggiunge allora un giudizio di valore, un giudizio che, secondo Marco Aurelio e gli stoici, non è fondato sulla realtà ma sulla rappresentazione di essa che si produce tramite la visione del mondo del soggetto. Per questo motivo è necessario separare la rappresentazione della realtà dall’emozione che essa genera (ossia dalla falsa rappresentazione) e che provoca in noi turbamento, tristezza o timore.
2. La cura dei valori
Gli antichi filosofi avevano compreso la stretta interazione tra i nostri giudizi di valore e la sofferenza dell’anima. I valori a cui aspiriamo e l’importanza che conferiamo loro possono generare un’eccessiva pressione fisico-psichica alla nostra mente. I valori possono essere, ad esempio, il denaro, la fama, la posizione sociale, la libertà, la famiglia, l’onore che, se non correttamente gestiti, sono forieri di sofferenza (alla fine di questo capitolo riportiamo un elenco dei principali valori a cui si può aderire, oggi come al tempo dei greci e dei romani).
Fin dall’antichità il termine valore è stato usato per indicare il prezzo di qualcosa – valore di scambio – o la sua utilità – valore d’uso –, ma anche come sinonimo di merito, nobiltà morale di una persona. In senso più generale, per valore si intende qualsiasi oggetto di preferenza o di scelta, sia individuale sia collettiva: qualsiasi cosa sia ritenuta oggettivamente importante o sia soggettivamente desiderata è o ha un valore.
I valori sono delle convinzioni profondamente radicate nella nostra anima. Da essi dipende il nostro giudizio su cosa riteniamo essere giusto, importante e che ci piace, e su cosa pensiamo essere invece sbagliato e che ci farà stare male . Essi hanno dunque un enorme impatto sulla nostra vita e condizionano, a livello più o meno inconscio, le nostre decisioni e la nostra condotta.
Ognuno decide a quali valori aderire ma i nostri valori non vengono scelti ad arbitrium; derivano dalle pulsioni naturali che spingono all’autoconservazione, al riconoscimento e alla stima degli altri, all’amore, al potere, alla procreazione, al desiderio, ecc. Essi possono venire trasmessi dall’esterno, dai genitori, dall’appartenenza a un gruppo, dalla società, dalla pubblicità o dalle aspettative altrui. Tuttavia, al di là della loro provenienza, essi vincolano il soggetto solo dal momento in cui accettiamo di farli nostri, e questo accade tramite i pensieri e le brame abituali che li rendono parte di noi stessi e della nostra vita.
Li confermiamo, realizziamo, alimentiamo e curiamo attraverso le nostre azioni e aspirazioni quotidiane. Il pensiero coinvolto nel processo di determinazione dei valori, nella scelta e nell’azione, deve quindi intervenire in questo processo modificandolo laddove causi sofferenza.
Il pensiero salutare inizia tramite l’analisi della tavola dei valori che a cui si è scelto di aderire e che guidano la propria vita. Talvolta non siamo pienamente consapevoli dei valori che governano la nostra vita e guidano le nostre azioni. Per individuarli è possibile porsi queste domande: cosa è veramente importante nella vita? A cosa miriamo affannandoci in questo modo? I valori che adottiamo ci sono stati imposti dall’educazione ricevuta o dalla società? Corrispondono ai nostri veri bisogni? Come dobbiamo valutare questi obiettivi rispetto alla visione generale della nostra vita e degli scopi che perseguiamo? Sono fini a sé stessi? Oppure, forse, li bramiamo solo perché pensiamo possano esserci utili per raggiungere quelli che sono i nostri veri obiettivi, ossia la gioia, la soddisfazione e la serenità? Vale la pena, ad esempio, mettere in gioco la nostra salute per raggiungere il benessere economico, la carriera, il successo personale o il riconoscimento sociale?
I giudizi di valore che attribuiamo a determinate cose, eventi e persone, in specifiche circostanze, possono generare forti emozioni, sentimenti e inclinazioni che sembrano sorgere in maniera spontanea o inconsapevole. In realtà le emozioni, i sentimenti e le inclinazioni possono influenzare in maniera decisa la nostra vita solo nel momento in cui apriamo loro uno spazio all’interno della nostra visione del mondo e diamo loro il consenso - non sempre razionalmente ponderato - di determinare le nostre azioni e comportamenti.
La decisione di lavorare quattordici ore al giorno o di spendere buona parte dello stipendio con il gioco d’azzardo sono comportamenti determinati dai valori a cui decidiamo di aderire, magari inconsapevolmente e magari nascondendoli anche a sé stessi. Fino a un certo limite, fintanto cioè che questi comportamenti non rivelino che abbiamo “perso la ragione” e il controllo di noi stessi e della nostra vita, c’è la possibilità di citare questi valori in giudizio e determinare con il pensiero critico il loro reale valore per noi. La ricerca del “valore reale” che attribuiamo a determinate cose o alle persone non è finalizzata alla ricerca di un valore oggettivo e valido per tutti, bensì del valore per noi, all’interno della nostra visione del mondo e nella nostra gerarchia dei valori.
Per scoprire quali sono i tuoi valori scegli dieci termini tra quelli elencati nella lista seguente, quelli che più rispecchiano la tua visione del mondo. Se vuoi sapere quali sono i tuoi valori fondamentali, dalla lista dei dieci valori scegline tre.
Aiutare l’altro, Ambizione, Amore, Approvazione, Avventura, Comodità, Coraggio, Creatività, Crescita, Dignità, Divertimento,
Fama, Famiglia, Fede, Felicità, Fiducia, Generosità, Giustizia, Gratitudine, Impegno, Integrità, Intelligenza, Investire, Lavoro, Libertà, Lealtà, Migliorare, Onestà, Orgoglio, Pace, Passione, Potere, Realizzazione, Rispetto, Saggezza, Salute, Sicurezza, Sincerità, Spiritualità, Successo, Tenacia, Verità, Vitalità
3. L’esame di coscienza.
“La conoscenza dell’errore è l’inizio della salvezza […], la coscienza della propria debolezza è il punto di inizio della filosofia” (Epitteto, 2017, p. 25).
L'esame di coscienza è una pratica, già presente tra i pitagorici, che permette di rendersi conto quotidianamente della misura in cui si adempie o meno ai propri doveri e ai propri valori lungo il percorso che conduce alla salute e al benessere della psiche. È dunque un mezzo per valutare il proprio progresso sulla “via della perfezione”, ovvero sulla via del conseguimento della padronanza di sé e del dominio ottenuto sulle proprie passioni.
Questo esercizio spirituale è profondamente diverso dall’esame di coscienza della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa, dove assume la valenza di una pratica spirituale, propedeutica al sacramento della penitenza, con cui il credente ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- AstraSeneca
- Indice dei contenuti
- Rassicurazione per il lettore
- Avvertenza
- Premessa
- Introduzione
- Capitolo primo. La filosofia di AstraSeneca
- Capitolo secondo. Le diagnosi delle malattie dell’anima
- Capitolo terzo. I rimedi di AstraSeneca
- Capitolo quarto. Gli ospedali dell’anima
- Conclusione
- Bibliografia