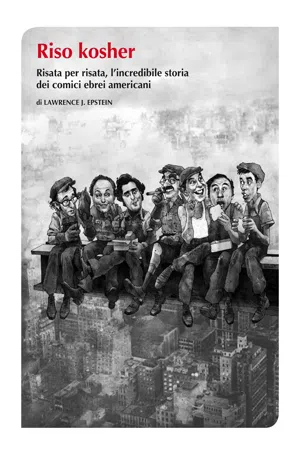![]()
8. “E POI LE UOVA CHI ME LE FA?”
Registi comici ebrei
A quelli che confondevano Woody Allen con il personaggio comico che interpretava, la sua carriera cinematografica sarebbe potuta apparire alquanto bizzarra. Un regista, dopotutto, non può permettersi di essere un pasticcione nevrotico anche sul set. Il vero Allen, però, è molto più abile della macchietta che interpreta. Determinazione e padronanza del mestiere sono stati elementi fondamentali per costruire la sua carriera cinematografica, considerato che fare film è un’impresa di squadra alquanto impegnativa. A volte Allen si è trovato in situazioni che avrebbero gettato nel panico il proprio alter ego cinematografico. Alcune scene del primo film che diresse, Prendi i Soldi e Scappa, furono girate all’interno del carcere di San Quintino. All’epoca quella struttura ospitava quattromila detenuti, uomini che, come spiegò in seguito Allen a Dick Cavett, “non vedono una donna da anni, figuriamoci un ebreo slavato”. Effettivamente le guardie carcerarie avevano avvertito il regista: “Se la prendono in ostaggio, faremo tutto quello che è in nostro potere per tirarla fuori, tranne aprire i cancelli”. I detenuti, comunque, si comportarono in modo collaborativo e amichevole.
Nella sua carriera cinematografica Allen è tornato più volte sul tema dell’identità ambigua: “Sono stato spesso accusato di essere un ebreo che odia se stesso”, ha avuto occasione di scrivere, “e se è vero che sono ebreo e che non mi piaccio molto, non è per «mia» convinzione”. Il regista mette in bocca una battuta analoga al personaggio di Harry a Pezzi e John Baxter, in una recente biografia, sostiene che Allen non presenta peculiari elementi ebraici nella sua vita personale. L’attore si conosce bene e potrebbe certamente avere ragione in merito a quel che dice di se stesso, ma i suoi personaggi, per esempio Harry Block, tendono a ignorare alcuni criteri essenziali che definiscono la loro ebraicità. Percepiscono l’essere ebrei come appartenenza a un gruppo religioso ma al tempo stesso non accettano il punto di vista della religione, oppure come appartenenza a un gruppo etnico ma si sentono distanti dagli altri membri di quel gruppo, a cominciare dalla famiglia. Non prendono in considerazione, in definitiva, l’essere ebrei come l’appartenenza inevitabile a un gruppo minoritario, con le tipiche apprensioni psicologiche causate dall’essere parte di quel particolare gruppo e dagli schemi di pensiero che alla fine emergono da tale collocazione emotiva. I personaggi di Allen non sono ebrei da un punto di vista religioso o etnico, ma per coscienza e temperamento.
Naturalmente, nel recitare i propri monologhi, Allen ha rivelato qualcosa di molto vicino all’indole ebraica facendo assurgere gli ebrei stessi a simbolo di tutti quanti sono alienati. In una certa misura quel sentimento è ancora presente nei suoi film, pur essendosi modificato tra gli stessi ebrei. Prima di essersi diffusamente integrati nella vita americana, gli ebrei avvertivano un forte senso di alienazione in quanto vittime. Era un atteggiamento che Allen trovava congeniale. Tuttavia, nel momento in cui la generazione dei suoi genitori aveva fatto di tutto per essere accettata e la sua stava per esserlo, questa alienazione si era attenuata. Ma i personaggi di Allen non si trovano a proprio agio nemmeno con questa nuova identità ebraica, perché conservano pur sempre una coscienza ebraica in una terra avvertita come straniera, traboccante di congegni ostili e di donne irraggiungibili, eccentriche o infedeli. La crisi di identità della sua generazione viene perfettamente fotografata nei suoi film.
Gli ebrei americani hanno trovato nelle pellicole del regista uno specchio delle enormi tensioni cui erano sottoposti mentre la loro nuova identità si andava delineando. Dopotutto sebbene gli ebrei rappresentino il popolo eletto e rivestano pertanto un’importanza storica straordinaria, gli ebrei americani sono gente comune, perfino statisticamente insignificante. Gli ebrei che vivevano in un mondo ebraico potevano spesso fare affidamento su una storia e un destino condivisi, su riferimenti culturali e famigliari e perfino su una coscienza collettiva. Gli ebrei che vivevano in America possedevano una storia condivisa limitata, a volte riferimenti culturali e famigliari in conflitto tra loro, specie quando quei riferimenti riguardavano le esperienze e le festività cristiane, e mancavano di una coscienza condivisa. Anche quelli che ce l’avevano fatta – a diventare buoni cittadini, ad aver successo da un punto di vista economico, o a integrarsi nella società – spesso si sentivano impantanati fra due mondi in conflitto. Per di più anche l’accettazione da parte della società yankee presentava i suoi problemi. Gli ebrei americani erano sempre più liberi di inseguire i propri sogni fino ai limiti delle loro formidabili capacità. Erano considerati dalla coscienza collettiva americana come modelli di sobrietà, intelligenza e umorismo, buoni vicini e buoni coniugi. Quel successo, però, scatenava inevitabilmente in questi un senso di colpa, perché comportava l’accettazione dei ritmi di un calendario laico che li privava della sensazione di vivere secondo i tempi dell’ebraismo. I loro nonni e genitori, che avevano lottato così strenuamente, il cui senso della yiddishkeit non era stato eroso dall’opulenza dell’Eldorado, rappresentavano la memoria di quel mondo emotivo che si stavano lasciando alle spalle. Mentre l’America li accoglieva, essi si allontanavano, in modo sostanziale, dal loro retaggio.
Il tema ricorrente dell’adulterio, così centrale nell’opera di Woody Allen, non rifletteva solo le sue tensioni sessuali o l’etica sessuale che si stava delineando nella vita americana, ma rispecchiava sostanzialmente l’intuizione che gli ebrei avessero abbandonato quella che lui considerava un’autentica coscienza ebraica, in favore di uno stile di vita che aveva trasformato radicalmente e in peggio quella coscienza. Il pubblico ebraico vedeva nell’adulterio la propria infedeltà all’essere ebrei.
Paradossalmente, proprio quando molti di loro cominciavano a lasciarsi alle spalle il continuo riferimento a una presunta identità religiosa, la cultura cominciò a porre nuovamente l’accento sull’aspetto etnico. Spinti dal movimento per i diritti civili, gli africano americani trovarono nella cultura tradizionale la forza per affrontare le diseguaglianze economiche e sociali. Il moto di orgoglio che avevano mostrato fu contagioso e molti altri gruppi, compresi gli ebrei, cominciavano a provare quella sensazione, o sentirono che avrebbero dovuto provarla. Gli ebrei che si identificarono nella lotta dei neri per ottenere la parità, vissero in prima persona questo senso di colpa, che ricordava loro quell’identità etnica di cui stavano cercando di disfarsi.
Anche se molti, come Allen, sperimentarono la via della psicanalisi, in realtà, forse, avrebbero avuto bisogno di una etnoterapia. Come i personaggi interpretati dall’attore, non comprendevano la profondità del rapporto che li legava al loro specifico retaggio etnico: rifiutavano la teologia e le pratiche religiose, ritenendo erroneamente che così facendo si sarebbero allontanati dall’ebraismo, senza rendersi conto che sarebbero rimasti ebrei anche senza la religione o l’adesione a un gruppo. Analogamente ai personaggi di Allen, avevano bisogno di un senso chiaro di appartenenza e di un modo per integrare quell’identità ebraica apparentemente rifiutata nell’identità americana. Troppo spesso accettarono le valutazioni della maggioranza su di loro: potevano essere accusati di odiare se stessi, e spesso lo furono.
Non sorprende quindi che i personaggi di Allen tengano in massimo conto il coraggio, l’indipendenza e le imprese artistiche. Sono proprio questi, infatti, gli obiettivi di una persona concentrata sul superamento delle tensioni identitarie attraverso l’audacia e l’acume delle azioni individuali. Come i personaggi di Allen (e forse come l’attore stesso) hanno amaramente scoperto – e come molti ebrei americani laici impararono in seguito –, quell’impegno eroico non era tuttavia sufficiente a sconfiggere le potenti forze sociali all’opera.
Sfortunatamente i personaggi di Allen non hanno mai fatto tesoro delle esperienze, non riuscendo mai a vincere le proprie ansie.
A volte la loro conflittualità emerge dai nomi stessi. Ne Il Dittatore dello Stato Libero di Bananas, per esempio, il personaggio interpretato da Woody Allen si chiama Fielding Mellish, la quintessenza del nome di battesimo wasp abbinato a un cognome tipicamente ebreo. Lo stesso accade per altri ruoli, come il Cliff Stern di Crimini e Misfatti (ovviamente, il nome Cliff, che significa “scogliera”, ha anche il valore simbolico di trovarsi sull’orlo del precipizio).
I film di Allen riscuotevano successo anche fra i gentili laici e gli intellettuali di città i quali, a metà degli anni Settanta, stavano a loro volta attraversando una crisi identitaria simile, esattamente nel momento in cui l’influenza e il successo del regista erano all’apice. Diversamente dagli ebrei, quei gentili non si stavano allontanando da un nido etnico, attirati dalle abbaglianti lusinghe che l’America faceva baluginare davanti ai loro occhi, anche se sostanzialmente stavano abbandonando uno stile di vita fino ad allora assodato. I loro genitori, forgiati dalla Seconda guerra mondiale e dalla necessità di ricostruire il Paese all’indomani del conflitto bellico, si erano concentrati sul lavoro, la famiglia, il senso del dovere e della responsabilità. Quei genitori credevano che una parte fondamentale della loro identità consistesse nel sublimare le proprie passioni nell’interesse dei figli. Ma questi non manifestavano lo stesso senso di responsabilità e, crescendo, misero al primo posto la libera espressione del proprio Io e la realizzazione personale. Questa nuova centralità dell’Io portò a un aumento esponenziale del numero dei divorzi, a un proliferare del riconoscimento e dell’affermazione di diritti di vario genere e, cosa ancor più importante, alla definizione del senso della vita come scoperta e cura del Sé. Capovolgendo totalmente la prospettiva dei genitori, la nuova generazione ritenne che l’Io non dovesse essere represso per prendersi cura degli altri. Scoprì la ribellione nelle esperienze sessuali e uno strano appagamento nel sentirsi alienata rispetto alla politica e alle proprie radici religiose. I giovani erano alla ricerca di valori alternativi e, quando non riuscirono a trovarli, ne crearono di nuovi.
I gentili si riconobbero nell’Io frammentato di Woody Allen: la loro inadeguatezza a conciliare il senso di responsabilità con la centralità dell’Io li faceva identificare profondamente con gli ebrei. Tuttavia il regista avrebbe offerto la perfetta immagine comica del dilemma di quella generazione, ma non la soluzione per affrontarlo.
Naturalmente, il pubblico dei gentili di Allen era circoscritto rispetto a quello di altre stelle del cinema. Il fatto che si trattasse essenzialmente di un pubblico di cittadini e intellettuali spiega il loro interesse: in qualunque cultura gli intellettuali rappresentano una minoranza, e gli ebrei erano per loro un modello cui era naturale guardare, in quanto gruppo minoritario di talento che era riuscito a sopravvivere.
È alquanto semplicistico giudicare i personaggi di Woody Allen incapaci di risolvere il conflitto d’identità o di accettare la propria identità ebraica. In realtà la forza dei suoi film è quella di un prisma che riflette, distorcendola, una vastissima gamma di reazioni da parte del pubblico. Ma è utile vedere la tensione verso la ricerca di un’identità come il perno attorno al quale si affannano i personaggi dei suoi film. Caratteristica tanto più evidente nelle sue prime pellicole e quando Allen cerca di realizzare film seri, concentrandosi sul risultato artistico piuttosto che sul successo commerciale.
Prendi i Soldi e Scappa (1969) è una serie di episodi visivi e verbali intrecciati tra loro e collegati da una trama incentrata su quello che, forse, è il criminale più incapace del mondo, Virgil Starkwell, interpretato dallo stesso Allen. Attraverso uno stile documentaristico il regista racconta la storia della vita di Starkwell. Anche qui medita sull’accettazione e l’assimilazione, per esempio quando il narratore dice del personaggio: “Vuole solo appartenere a qualcosa, fosse pure una gang del quartiere”.
Starkwell viene messo in prigione dopo una maldestra rapina in banca in cui presenta, fra l’altro, un messaggio di minaccia illeggibile al cassiere che lo legge come “Vi tengo sotto giro”, invece che “Vi tengo sotto tiro”. In prigione si sottopone volontariamente a un esperimento per ottenere una riduzione della pena. Uno degli effetti dell’esperimento è che “per diverse ore si trasforma in un rabbino”. La frase è accompagnata da un’inquadratura scontata, ovvero Allen vestito da ebreo chassidico. Anche se da ultimo trova l’amore, Starkwell è però incapace di rinunciare alla propria vita criminale e alla fine lo vediamo mentre cerca di fuggire di prigione. In realtà l’unica cosa che desidera è scappare: da se stesso, dai genitori che lo disapprovano, da una società che non riesce a trovargli una collocazione. In una famosa scena i genitori si nascondono dietro la maschera di Groucho, celando non solo i propri volti, ma anche il proprio vero Io. Intrappolato in un mondo indifferente con un’identità che non riesce a comprendere, Virgil cerca la redenzione attraverso l’amore, che però gli è negata. In realtà, nella versione originale del film, alla fine della storia la coppia veniva uccisa.
Il Dittatore dello Stato Libero di Bananas (1971) è la storia di un collaudatore industriale che si trova invischiato in una rivoluzione in un paese del Sudamerica. Come Prendi i Soldi e Scappa, il film era in origine una sequenza di episodi comici. Un soldato viene torturato facendogli ascoltare il motivetto “The Naughty Marietta”. Il giornalista sportivo Howard Cosell fa una telecronaca in diretta, non di un evento sportivo, bensì di un omicidio e della prima notte di nozze del personaggio di Allen, commentata come se stessimo assistendo a un incontro di boxe. Fielding parla come Groucho Marx e Allen, avvocato di se stesso, si lamenta così: “Obiezione, Vostro Onore: questo processo è una parodia, è la parodia di un’impostura, di una beffa, di un’impostura di due parodie di una beffa! È un processo illegale: si rende conto che non c’è un solo invertito nella giuria?” Ancora una volta Allen canzona gli intellettuali: in una scena si nasconde dietro una copia di Commentary mentre una donna viene rapinata in metropolitana. E, di nuovo, i suoi genitori hanno il volto coperto da maschere. Una ridicola barba rossa cela la sua identità di persona insignificante e con quel travestimento grottesco appare alla sua ex ragazza come un amante seducente.
Nel film successivo di Allen, Il Dormiglione (1973), il personaggio che interpreta si allontana completamente dalla vita newyorchese. Allen stava affinando la propria abilità nel padroneggiare la parodia, nel conciliare le gag con una storia vera e propria e nell’evitare barzellette che sarebbero risultate efficaci solo se lette in un libro, piuttosto che recitate sullo schermo. Il Dormiglione, che è ambientato nel futuro, nel 2173, contiene una varietà di gag e battute classiche di Allen, come quando il protagonista, Miles Monroe, professa la propria mancanza di eroismo annunciando che una volta è stato picchiato da Tom e Jerry. Sostiene di credere “nel sesso e nel decesso, due cose veramente fondamentali nella vita, ma almeno, dopo la morte, non hai la nausea”. Allen avrebbe ripreso temi simili nel film successivo, nettamente meno esplicito, intitolato Amore e Guerra (1975).
Ma il film spartiacque di Allen è stato Io e Annie (1977), che ha rappresentato il passaggio dalla semplice commedia all’interesse per un personaggio particolare: un maschio ebreo, intellettuale e laico che vive a New York. Allen colloca finalmente il proprio protagonista in uno scenario più realistico, inserisce chiari elementi autobiografici e, cosa ancor più importante, non passa da una gag all’altra, le distribuisce, focalizzandosi più sui rapporti umani che ...