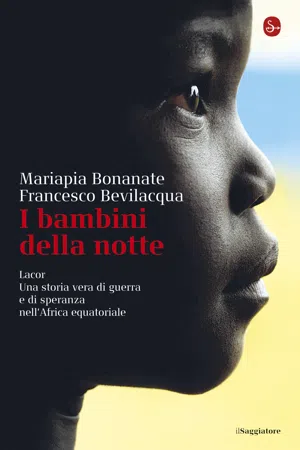![]()
1
Quando l’airbus della Brussels Airlines parte dalla capitale belga per il Nord Uganda e buca la cortina delle nuvole nel silenzio sospeso del decollo, di colpo mi vedo. Vedo il mio doppio, come riflesso in uno specchio. Che cosa ci fa quell’uomo con i capelli spruzzati di bianco, che contrastano con la freschezza del volto, su un aereo diretto verso un paese in guerra? Come ha potuto lasciare la moglie, due figli poco più che adolescenti, sicurezze e impegni, le comodità di una vita privilegiata, per andare incontro a situazioni cariche di pericoli e di rischi? O è un folle, o deve essergli accaduto qualcosa di misterioso che ha annientato tutte le considerazioni razionali, le prudenze del buon senso. Un impulso travolgente che lo ha trascinato in un’avventura al buio della cui portata sembra non rendersi conto.
Faccio fatica a pensare che quell’uomo sono io. Avverto una dissociazione lacerante, una sensazione di stordimento fisico. Come non sentissi più il corpo, non ritrovassi più i pensieri. È scomparsa quella lucidità, molto apprezzata sul lavoro, che mi permetteva di arrivare con rapidità, prima degli altri, al nocciolo delle cose e delle situazioni. E che mi dava tanta sicurezza.
Le ore di viaggio corrono veloci in questo straniamento. Non sono molte. Nove, con la sosta a Kigali, in Ruanda, dove i visi distesi dei passeggeri, che scendono e salgono, il loro vociare cordiale, la normalità di gesti quotidiani, mi riportano con stupore e angoscia al genocidio che, soltanto pochi anni prima, ha insanguinato il paese, con un milione di morti in cento giorni. La maggior parte massacrata a colpi di machete. A guardare quei passeggeri così sereni, persino festosi, pare impossibile sia accaduto davvero.
Quando l’aereo atterra a Entebbe, il cuore mi batte forte. A breve conoscerò un mondo nuovo: tutto mi sembra irreale, ma l’odore aspro, tipico dell’Africa, che mi ha accolto negli altri viaggi in questo continente, mi dice che è tutto vero. Me lo dice quel cielo piovuto di stelle palpitanti, intensamente luminose, che soltanto qui, vicino all’equatore, è visibile per intero nella sua sconfinata vastità. L’arrivo alla guest house di Kampala, dove sostano le persone dirette al Lacor Hospital, è un momento magico. Nel silenzio della notte che avvolge, come una seta morbida, mi pare di avvertire presenze invisibili, sguardi nascosti che mi scrutano. Sono i sensi, catapultati in una dimensione sconosciuta, a darmi queste percezioni?
Nella piccola stanza con il pavimento di laterizi rossi, le pareti spoglie, imbiancate di calce, il letto spartano, fatico a dormire. Per il caldo, il sudore e l’assalto delle zanzare. Subentra una grande stanchezza, la testa è come compressa da un cerchio di ferro. Ritorna il disagio provato sull’aereo. Sono un incosciente che ha messo a repentaglio gli equilibri familiari e lavorativi? Eppure, continuo a sentire dentro di me un richiamo più forte delle paure e della stanchezza.
La notte trascorre veloce, l’alba è folgorante. Emerge di colpo dal buio, senza preavviso. Esco nel grande giardino che circonda la casa. Mi travolge la bellezza di una natura colorata ed esuberante nella grande varietà dei fiori e delle piante. Le palme si stagliano maestose contro l’azzurro del cielo, il cinguettio degli uccelli ha suoni sconosciuti. L’intensità dei profumi, diversi da quelli della notte, mi entra nella pelle. Sono emozionato e sempre più confuso nell’attesa di quanto sta per accadere.
Due guardiani siedono immobili sul muretto. I loro visi, scolpiti dagli anni, non hanno età. Mi guardano discreti, ma interessati. Accenno a un saluto, rispondono con un grande, cordiale sorriso. Nell’aprire il cancello, hanno movimenti misurati. Inizio a capire che qui il tempo ha passi lenti, fanno la differenza con i nostri ritmi frenetici.
Con la jeep dell’ospedale, venuta a prendermi, attraversiamo Kampala, già brulicante di persone che spuntano da ogni parte per accamparsi ai bordi della strada, in una densità di corpi, voci e richiami che diventa più caotica quando affianchiamo la bidonville che circonda la capitale. Ci aspettano trecento chilometri di strada, tormentata da buche e cunette, da deviazioni che riducono la velocità al minimo. In lontananza le colline si moltiplicano come onde morbide di un mare verde. I fiori gialli delle acacie sono fari luminosi nella natura selvaggia. Ma, via via che ci allontaniamo dalla dolcezza delle colline di Kampala, il paesaggio umano è sempre più desolante. Poche le capanne, isolate e malandate, baracche fatiscenti, persone vestite di stracci, i visi emaciati, i corpi prosciugati. Sguardi smarriti, sfuggenti, appesi a una sofferenza che ha spento ogni sorriso. Sulla jeep c’è un silenzio imbarazzante. Nessuno dei tre ugandesi che viaggiano con noi parla. Hanno occhi tristi e assorti. Sono ripiegati su se stessi, come volessero difendersi da un pericolo imminente.
All’improvviso, un forte scrosciare d’acqua riempie l’aria. È il grande Nilo che arriva dal lago Vittoria e forma delle cascate sonore. Uno spettacolo che abbaglia. Chiedo di fermarmi per godere da vicino quello scorcio di bellezza sublime, ma l’autista mi risponde con voce decisa: «No, non è possibile, siamo in zona di guerra. Ci fermiamo fra poco, al check point dei militari». Fino ad allora avevo conosciuto la guerra soltanto sui media. L’avevo vista scorrere sugli schermi in quella dimensione virtuale che ne anestetizza gli aspetti più drammatici e truci. Avevo letto reportage giornalistici e libri, ma non mi ero mai trovato dentro un conflitto reale. Adesso c’ero.
Al posto di blocco i militari, tesi e nervosi, ci lasciano passare senza controlli. Conoscono molto bene la croce blu dell’ospedale sul cofano dell’automezzo. Subito dopo l’autista aumenta la velocità. Mi spiega che, in quel tratto, c’è sempre il pericolo di un’imboscata dei guerriglieri del Lra (Lord’s Resistance Army), l’«Esercito di resistenza del Signore» di Kony. Bisogna procedere il più veloce possibile per evitare di trovarsi nel bel mezzo di uno scontro a fuoco.
Ho paura. Una paura mai provata prima. Dallo stomaco sale a chiudermi la gola. Faccio fatica a respirare, il corpo è come paralizzato. Per fortuna l’autista, fra un sobbalzo e l’altro, aggredisce la strada senza incertezze. Il suo viso, assorto nella guida, non pare preoccupato più di tanto. Deve averci fatto l’abitudine. Mastica un chewing gum, come se, in quel momento, fosse l’unica cosa importante. La sua sicurezza mi dà coraggio, cerco di rilassarmi e riprendo a guardare fuori dal finestrino. Il paesaggio nel sole di mezzogiorno è splendido, con la luce che dilata i contorni delle cose, ma le strade sono deserte, le poche capanne disabitate. L’ultima ora di viaggio trascorre senza incidenti. L’autista ha rallentato l’andatura, guida più rilassato.
Dopo avere attraversato Gulu, altri tre chilometri di terra rossa. Procediamo con difficoltà per le enormi buche. Ancora desolazione e baracche vuote. Mi sento fuori posto con gli abiti puliti, le scarpe sportive, il corpo ben nutrito. Sono un uomo che arriva da un mondo lontano e non sa neppure perché si trova lì. L’autista si ferma di fronte a un grande e solido cancello di ferro, suona il clacson. Un ragazzo viene ad aprirlo, sorride con timida gentilezza, ci saluta in acoli. Siamo arrivati al Lacor Hospital.
![]()
2
Appena il cancello si chiude alle nostre spalle, mi sembra di entrare in un sortilegio. Cambia tutto, magicamente tutto. Anche l’aria sembra più leggera. Dopo avere attraversato un paesaggio privo di presenze umane, ferito da tanti segni di povertà, mi accoglie una piccola città, animata e popolatissima, con case e porticati ariosi, costruiti con mano attenta. Mi impressiona il contrasto con quanto ho appena visto. Fuori un vuoto desolante, anche se immerso in una rigogliosa natura. Qui, una comunità laboriosa e vivace. Un’isola nel deserto. Infermiere con la divisa candida e la crestina in testa entrano ed escono dai reparti, salutano con un sorriso. I medici, tutti ugandesi, sono eleganti con le loro cravatte colorate che spiccano da sotto il camice. Gruppi di persone, accampate nei cortili, hanno acceso bracieri sui quali preparano i pasti per i familiari ricoverati. Le donne lavano indumenti che appendono su stenditoi improvvisati, i bambini giocano a rincorrersi. C’è aria di famiglia. Altre persone, sedute davanti ai reparti, sono in paziente attesa di entrarvi con i loro fagotti. L’impressione, che si coglie subito, è quella di una vita ben organizzata attorno a una struttura imponente, dove ciascuno assolve ai propri compiti con impegno e cura, sotto la guida di una regia invisibile, ma attenta ed efficace.
Su questa isola si irradia e si deposita lo sguardo protettivo e buono dei personaggi in camice bianco che sorridono dai grandi murales che dominano l’interno della meeting room. Sono Lucille e Piero Corti. Accanto a loro, con una luce nello sguardo che gli illumina tutto il viso, il dottor Matthew Lukwiya. Le tre figure emanano serenità e protezione. Rassicurano. Sono come legate da un filo invisibile che in seguito scoprirò.
Capisco ora l’entusiasmo e l’ammirazione con cui l’amico medico mi parlava di queste tre persone, raccontando la storia del Lacor Hospital. Senza di loro l’ospedale non sarebbe mai esistito in tutta la sua straordinaria grandezza. E continua a esistere, anche dopo la loro scomparsa. Loro sono lì, non se ne sono mai andati. È una percezione che non deriva da un ragionamento. L’avvertono i sensi per quella trasmissione di energie che passano da un corpo all’altro e che la morte non riesce a cancellare. Mi stavano aspettando. Sono felice di essere arrivato.
Il sopraggiungere di un ragazzo che viene scaricato da un carretto – avrà una quindicina d’anni – interrompe i miei pensieri. Ha una gamba ridotta a un ammasso informe di carne sanguinolenta. Il resto del corpo è lacerato da ferite. L’hanno raccolto per la strada, dove è saltato su una delle tante mine, sparse nei campi, nascoste nel terreno per uccidere. Lo mettono su una lettiga per portarlo al pronto soccorso.
Lo seguo, ammirato dal coraggio con cui, senza lamentarsi, sopporta la sofferenza atroce che deve provare. Il suo volto, che a tratti si contrae per il dolore, esprime una fierezza adulta. Mi colpisce il corpo frantumato eppure integro nell’eleganza e nella dignità del comportamento. Rimango inchiodato accanto a lui, mentre l’infermiera che lo assiste presta le prime cure con mani esperte. Il ragazzo si è accorto della mia presenza. Ci parliamo con gli occhi. I suoi cercano di sorridermi, i miei sono come pietrificati. Un dialogo silenzioso che nel trascorrere dei minuti diventa più intenso. Come se ci conoscessimo da sempre.
In quegli istanti avverto quanto lo strappo con la mia vita precedente stia diventando definitivo. Il ragazzo, saltato su una mina, non è più un’immagine di carta. Una notizia letta distrattamente su un giornale o vista in un reportage televisivo. È lì, vivo, con la sua povera carne lacerata, vittima di una guerra che fino ad allora ignoravo, ma che ora mi assale con la sua realtà crudele. Mi penetra attraverso lo sguardo smarrito di questo adolescente, attraverso la sua disperata richiesta di aiuto. È un essere umano come me, soltanto con un destino diverso, per quel sorteggio dell’esistere che ora ci lega in un sentimento di umana appartenenza. Mai prima avevo percepito questo sentimento in modo così acuto e chiaro. Dopo pochi minuti lo portano in sala operatoria. Mi diranno che sono riusciti a salvargli la vita, ma hanno dovuto amputargli la gamba.
Mi metto alla ricerca di Elio Croce, il fratello laico comboniano, responsabile tecnico dell’ospedale, sempre in prima linea in ogni circostanza. Un mito, una leggenda. Sarà lui ad affiancarmi nelle giornate che trascorrerò al Lacor Hospital. Mi aspetta nella casa che divide con altri confratelli e mi abbraccia con il calore di un vecchio amico. Non si perde in convenevoli, ma mi scruta con uno sguardo affettuoso che mi conquista. Ha la sobrietà dell’uomo di montagna, rimasto fedele alle sue radici, l’umanità calorosa di chi vive per gli altri. Mi invita: «Francesco, vai a riposarti, sarai molto stanco».
La stanza che mi hanno destinato è gradevole, essenziale. Appoggio lo zaino e mi stendo sul letto, ma non riesco a riposarmi. Sono inquieto. Saranno gli effetti dell’antimalarico o l’emozione per quanto ho vissuto fino a quel momento. Decido di alzarmi e mi incammino verso l’ospedale.
Sono le sei e mezzo del pomeriggio, in giro meno persone che al mattino. All’improvviso un rumore assordante di passi, di piedi nudi sul terreno, uno scalpiccio, sempre più vicino, un vociare infantile, allegro e vivace. Incuriosito, arrivo all’ingresso dell’ospedale dove ci sono il cancello e il muro di cinta. Sta entrando una moltitudine incredibile di persone, soprattutto bambini. Molti di loro portano con agilità sulle spalle un fratellino o una sorellina. Alcune bambine, piccolissime, hanno sul dorso un fardello con un neonato. Negli occhi di tutti la gioia di chi si sente arrivato in un luogo sicuro e protetto.
Colpito da questo spettacolo, non mi sono accorto che Elio è alle mie spalle: «Sono i night commuters, i bambini della notte. Vengono a cercare rifugio dentro le mura dell’ospedale e si accampano nei cortili per sfuggire alle violenze dei guerriglieri che li obbligano a diventare bambini soldato. Molti hanno fatto dieci, quindici chilometri di strada, ma sono pronti ogni sera a ripercorrerli. I loro fratelli e amici sono stati rapiti dai soldati di Kony, durante gli assalti notturni ai villaggi, per essere portati nel suo esercito».
Folgorato, rimango davanti al cancello per un’ora, fino al tramonto che ha tonalità di rosso abbagliante e si consuma in pochi minuti per la vicinanza dell’equatore. Come se qualcuno all’improvviso avesse spento il sole con un interruttore. Il buio è subito profondo, compatto. Intanto i bambini continuano a fluire come un fiume inarrestabile. Sono migliaia. Un piccolo esercito allegro e disciplinato, che non crea ingorghi, ognuno sa dove dirigersi. Sporchi e laceri, indossano pantaloncini consunti. La maglietta, con più buchi che tessuto, lascia scoperte ampie parti del corpo. Non hanno quasi niente con sé. I più fortunati una stuoia, altri un quaderno con la copertina nera. Come faranno i cortili dell’ospedale a contenerli tutti? Il vociare adesso è diventato simile allo stormire impetuoso dei rami di una foresta sferzati dal vento. Quel rumore, nel silenzio che avvolge l’ospedale, crea un’attesa inquieta.
Un infermiere mi porta alla guest house per cenare. Ci sono alcuni medici. Hanno il viso stanco, mangiano frettolosamente, ricurvi sul tavolo, senza parlare. Soltanto un rapido e cordiale saluto al nuovo venuto. Prima avevo fame. Dopo le ultime emozioni, mi si è chiuso lo stomaco. Lascio quasi tutto nel piatto. Mi apparto in un angolo, dove mi raggiunge Elio: «Vai a letto presto, domani mattina, all’alba, passo a prenderti».
Accenno un mezzo sorriso, mi guardo attorno smarrito. Al termine della cena Elio, con fare disinvolto che rivela un’abitudine, prende un vassoio dove raccoglie gli avanzi rimasti nei piatti. Sorpreso, gli chiedo: «Che cosa ne fai?». «Li porto ad alcuni ammalati che non mangiano da giorni. La prima conseguenza della guerra è la fame. E di questi tempi, sono pochi coloro che riescono a mangiare.»
Ammutolisco. Un pugno allo stomaco. Penso alla nostra permanente sazietà. Vado a dormire, ma dopo un’ora mi sveglio di soprassalto. Faccio fatica a capire dove sono, le immagini della giornata si affollano nella mente. D’impulso mi alzo ed esco. Tutto tace, più nessun vocio, un tappeto impenetrabile di corpi in un silenzio compatto, sotto un cielo illuminato dalla luna piena che stende una luce irreale su quel mare immobile di esseri viventi. I bambini sono così tanti che c’è chi dorme sui gradini di accesso ai reparti. Soltanto alcuni hanno una coperta, la maggior parte nulla che li ricopra. Durante la notte la temperatura scende di molti gradi. E spesso su quel tappeto umano arrivano piogge violente.
All’improvviso, sotto la tenue luce di una lampadina, vedo un gruppetto con in mano un quaderno dalla copertina nera. Mi avvicino, osservo incuriosito. Con mozziconi di matite fanno i compiti per il giorno dopo. Sono le tre di notte. Uno di loro mi tira per un lembo dei pantaloni. È steso per terra, senza coperta, la maglietta è un enorme grande buco. Mi guarda con due occhi dolcissimi, e, in un sussurro, mi dice in inglese: «Munu», in acoli «uomo bianco», «perché sei venuto?».
«Non lo so. E tu perché sei qui? Come ti chiami?»
«Sono Dan, ho nove anni, sono il primo di cinque fratelli. Mio padre e mia madre sono morti di Aids. Veniamo da mesi a dormire in questo cortile. Il nostro villaggio è stato più volte assalito dai guerriglieri, finora ci siamo salvati. Camminiamo ogni giorno due ore, e altre due per ritornare nella nostra capanna, ma siamo contenti di farlo perché qui la notte è sicura.»
«Che classe frequenti?» gli chiedo stupito di quel dialogo così spontaneo e inatteso.
«Nessuno di noi cinque va a scuola, non abbiamo soldi per le school fees, ma qui faccio i compiti con ragazzi che la frequentano, così ho imparato a scrivere e a leggere. Spero un giorno di riuscire ad andarci.»
Poi aggiunge: «Mangiamo una volta al giorno quel poco che riusciamo a trovare. Spesso saltiamo anche questo pasto, ma quando arriviamo al Lacor gli altri dividono con n...