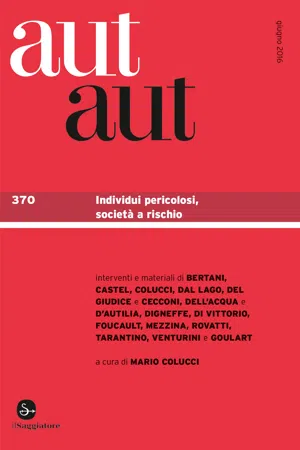![]()
Materiali
![]()
L’evoluzione della nozione di “individuo pericoloso” nella psichiatria legale del XIX secolo (1978)
MICHEL FOUCAULT
Comincerò riportando alcune frasi scambiate l’altro giorno presso la corte d’assise di Parigi. Veniva giudicato un uomo accusato di cinque stupri e di sei tentativi di stupro, distribuiti tra il mese di febbraio e il giugno 1975. L’accusato era pressoché muto. Il presidente gli domanda:
“Ha cercato di riflettere sul suo caso?”.
Silenzio.
“Perché, a ventidue anni, si scatenano in lei simili violenze? Lei deve compiere uno sforzo analitico. Solo lei possiede le chiavi di se stesso. Me lo spieghi.”
Silenzio.
“Per quale motivo lo rifarebbe?”
Silenzio.
Allora un giurato prende la parola ed esclama: “Ma, insomma, si difenda”.
Non vi è nulla d’eccezionale in un simile dialogo, o, per meglio dire, in questo monologo interrogativo. Probabilmente potremmo ascoltarlo in molti tribunali e in molti paesi. Ma, se l’osserviamo con un po’ di distacco, non può che suscitare la sorpresa dello storico. Ecco un apparato giudiziario destinato ad accertare dei fatti delittuosi, a identificare il loro autore e a sanzionare questi atti infliggendo le pene previste dalla legge. Ora, in questo caso ci sono dei fatti accertati, un individuo che li riconosce e dunque accetta la pena che sta per essergli comminata. Dovrebbe andare tutto per il meglio nel migliore dei mondi giudiziari. I legislatori, i redattori del Codice della fine del secolo xviii e dell’inizio del secolo xix non avrebbero potuto sognare una situazione più limpida. Eppure la macchina si blocca, il meccanismo s’inceppa. Come mai? Perché l’accusato tace. Su che cosa tace? Sui fatti? Sulle circostanze? Su come si sono svolti gli eventi? Su ciò che in quel frangente avrebbe potuto provocarli? Niente affatto. L’accusato si sottrae dinanzi a una domanda essenziale per un tribunale di oggi, ma che sarebbe suonata ben strana centocinquant’anni fa: “Ma lei chi è?”.
E il dialogo che ho appena citato prova chiaramente che a questa domanda non è sufficiente che l’accusato risponda: “Sono io l’autore dei crimini in questione: punto e basta. Giudicatemi, giacché questo è il vostro dovere, e se volete condannatemi”. Gli si chiede ben di più: oltre l’ammissione, è necessaria una confessione, un esame di coscienza, una spiegazione di se stesso, uno svelamento di sé. La macchina penale non può più funzionare solamente con una legge, un’infrazione e un autore responsabile dei fatti. Ha bisogno d’altro, di un materiale supplementare. I magistrati e i giurati, ma anche gli avvocati e il pubblico ministero, non possono fare realmente la loro parte se non viene fornito un altro tipo di discorso: quello che l’accusato tiene su se stesso o quello che consente di fare sul proprio conto, grazie alle sue confessioni, ai suoi ricordi, alle sue confidenze ecc. E se questo discorso viene a mancare, il presidente si accanisce, la giuria si irrita; l’accusato viene incalzato, sollecitato, non sta al gioco. Ricorda quei condannati che devono essere portati di peso alla ghigliottina o alla sedia elettrica perché trascinano le gambe. Bisogna che camminino da soli almeno un po’, se davvero vogliono essere giustiziati; bisogna che parlino un po’ di se stessi, se vogliono essere giudicati.
L’argomento impiegato di recente da un avvocato francese in un caso di rapimento e omicidio di un bambino mette bene in evidenza come questo elemento sia indispensabile alla scena giudiziaria, come non si possa giudicare, non si possa condannare, senza che esso venga fornito in un modo o nell’altro. Per tutta una serie di ragioni, questo caso ebbe una grande risonanza, non soltanto per la gravità dei fatti, ma perché nel processo era in gioco il ricorso o l’abbandono della pena di morte. Prendendo posizione contro la pena di morte, più che a favore dell’accusato, l’avvocato fece valere il fatto che si sapeva ben poco di lui e che nel corso degli interrogatori o delle perizie psichiatriche non era emerso nulla. E fece questa riflessione stupefacente (la cito in modo approssimativo): “Si può condannare a morte qualcuno che non si conosce?”.
L’intervento della psichiatria in ambito penale è avvenuto all’inizio del secolo xix, a proposito di una serie di casi simili tra loro, verificatisi tra il 1800 e il 1835.
Il caso riferito da Metzger: un ex ufficiale in pensione si è affezionato al figlio della sua affittacamere. Un giorno, “senza nessun motivo e senza che fosse in gioco nessuna passione, come può essere la collera, l’orgoglio, la vendetta”, si getta sul bambino e lo colpisce per due volte con un martello, senza ucciderlo.
Il caso di Sélestat: in Alsazia, durante il rigidissimo inverno del 1817, sotto la minaccia della carestia, una contadina approfitta dell’assenza del marito, che se ne è andato a lavorare, per uccidere la loro figlioletta, tagliarle una gamba e cuocerla nella minestra.
A Parigi, nel 1825, una serva, Henriette Cornier, va a trovare la vicina dei suoi padroni e le chiede insistentemente di affidarle per un po’ la figlia. La vicina esita, acconsente e poi, quando torna a riprendere la bambina, scopre che Henriette Cornier l’ha appena uccisa, le ha tagliato la testa e l’ha buttata dalla finestra.
A Vienna Catherine Ziegler uccide il figlio bastardo. In tribunale spiega di essere stata spinta da una forza irresistibile. Viene assolta per follia e liberata. Ma lei dichiara che farebbero meglio a trattenerla in prigione, perché lo rifarà. Dieci mesi dopo, partorisce un bambino che uccide immediatamente e al processo dichiara di essere rimasta incinta al solo scopo di uccidere il neonato. Viene condannata a morte e giustiziata.
In Scozia un certo John Howison penetra in una casa, uccide una vecchia che non conosce e se ne va senza aver rubato nulla, ma non cerca di nascondersi. Arrestato, nega contro ogni evidenza; ma la difesa sostiene che si tratta del crimine di un demente, giacché privo d’interesse. Howison viene giustiziato e, retrospettivamente, sarà interpretato come un ulteriore segno della sua follia il fatto che avesse detto a un funzionario lì presente che aveva voglia di ammazzarlo.
Nel New England Abraham Prescott uccide, in aperta campagna, la madre adottiva, con la quale aveva sempre avuto buoni rapporti. Rientrato a casa, scoppia a piangere di fronte al padre adottivo; questi lo interroga e Prescott confessa il suo crimine senza nessuna difficoltà. In seguito spiega di avere avuto un mal di denti improvviso e violento e di non ricordare più nulla. L’inchiesta stabilirà che aveva già aggredito i genitori adottivi durante la notte, ma che si era pensato a una crisi di sonnambulismo. Prescott è condannato a morte, ma al tempo stesso la giuria consiglia la commutazione della pena. Viene giustiziato ugualmente.
Gli psichiatri dell’epoca – Metzger, Hoffbauer, Esquirol, Georget, William Ellis e Andrew Combe – si riferiscono di continuo a questi casi e ad altri del medesimo genere.
Per quale motivo, nell’ambito di tutti i crimini commessi, proprio questi casi sono sembrati significativi e hanno rappresentato la posta in gioco delle discussioni tra medici e giuristi?
1) In primo luogo bisogna sottolineare che essi presentano un quadro molto diverso da quello che fino ad allora aveva costituito la giurisprudenza della follia criminale. Schematicamente, fino alla fine del secolo xviii, il diritto penale sollevava la questione della follia solo nei casi in cui era posta anche dal Codice civile e dal diritto canonico. Vale a dire quando essa si manifestava sotto forma di demenza e di imbecillità oppure sotto forma di furia. In entrambi i casi, che si trattasse di uno stato definitivo o di un’esplosione passeggera, la follia si manifestava con indizi numerosi e abbastanza facilmente riconoscibili (al punto che si discuteva sulla reale necessità di farla certificare da un medico). Ora, è importante sottolineare come lo sviluppo della psichiatria criminale non si sia realizzato perfezionando il problema tradizionale della demenza (per esempio, discutendo sull’evoluzione progressiva della demenza, sul suo carattere globale o parziale, sulla sua relazione con alcune incapacità innate degli individui) e neppure analizzando più da vicino la sintomatologia della furia (le interruzioni, le ricomparse, gli intervalli). Tutti questi problemi, con le discussioni connesse protrattesi per anni, sono stati sostituiti da un problema nuovo: quello dei crimini che non sono preceduti, accompagnati o seguiti da nessuno dei sintomi tradizionali, riconosciuti e visibili della follia. In ognuno dei casi si insiste sul fatto che non c’era nessun precedente, nessun disturbo preesistente del pensiero o del comportamento, nessun delirio; che non vi era nemmeno l’agitazione o il disordine caratteristici della furia; il crimine scaturiva da quello che poteva essere chiamato il grado zero della follia.
2) Il secondo tratto comune è talmente evidente che non è il caso di dilungarsi. Non si tratta di delitti leggeri, ma di crimini gravi; sono quasi tutti omicidi, accompagnati talvolta da strane crudeltà (il cannibalismo della donna di Sélestat). È importante notare che, in un certo senso, la psichiatrizzazione della delinquenza si è realizzata “dall’alto”. Anche questa è una rottura rispetto alla tendenza fondamentale della giurisprudenza precedente. Più un crimine era grave, meno conveniva porre la questione della follia (per lungo tempo ci si è rifiutati di prenderla in considerazione quando si trattava di un crimine sacrilego o di lesa maestà). Si ammetteva facilmente l’esistenza di tutta una regione comune alla follia e all’illegalità nel caso dei delitti minori (piccoli atti di violenza, vagabondaggio), e, almeno in alcuni paesi come la Francia, si reagiva con l’ambigua misura dell’internamento. Ora la psichiatria riesce a penetrare con tutte le sue forze nella giustizia penale, non attraverso la zona confusa del disordine quotidiano, ma affrontando il grande evento criminale, estremamente violento ed estremamente raro.
3) Questi grandi assassinii hanno inoltre in comune il fatto di compiersi sulla scena domestica. Sono crimini di famiglia, di casa o, al massimo, di vicinato. Genitori che uccidono la progenie, figli che uccidono i genitori o i protettori, servitori che uccidono il figlio della famiglia o del vicino ecc. Questi crimini, è evidente, mettono a confronto individui appartenenti a generazioni differenti. La coppia bambino-adulto o adolescente-adulto è quasi sempre presente. Il fatto è che, all’epoca, questi rapporti d’età, di luogo, di parentela sono considerati al contempo sacri e naturali, persino i più innocenti, quelli che, tra tutti, dovrebbero essere i meno investiti dall’interesse e dalla passione. Più che crimini contro la società e le sue regole, sono crimini contro natura, contro quelle leggi che riteniamo inscritte direttamente nel cuore umano e che sono il cemento delle famiglie e delle generazioni. La forma dei crimini che, all’inizio del secolo xix, appariva pertinente per sollevare la questione della follia è dunque il crimine contro natura. L’individuo nel quale follia e criminalità si congiungono e pongono il problema dei loro rapporti non è l...