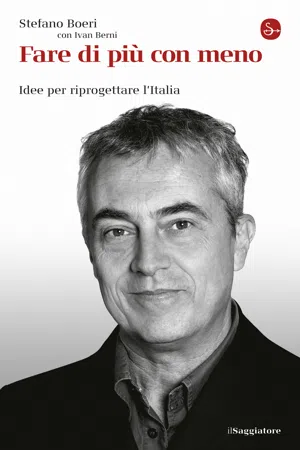![]()
Un dialogo
Milano e la Politica
IVAN BERNI
Due anni fa, nel settembre 2010 hai scelto di candidarti per le primarie a sindaco del centrosinistra a Milano. Qualche mese dopo questa improvvisa «virata», hai deciso di non interrompere la tua brevissima carriera politica e di candidarti a capolista del PD a sostegno di Giuliano Pisapia. E infine, nel giugno 2011, dopo lo straordinario successo che ha cambiato Milano – e che ti ha dato più di 13mila preferenze, un record assoluto per un candidato della sinistra – sei stato chiamato in giunta con le deleghe assessorili alla Cultura, Moda, Design e Expo. Come mai un architetto e docente che ha lavorato e insegnato in tutto il mondo – negli USA, in Russia, in Cina, in Brasile – e che per anni ha promosso ricerche sulla vita nelle grandi metropoli del mondo, decide a un certo momento di investire la sua vita su un’unica città?
STEFANO BOERI
Da tempo, da molti anni avevo l’idea di una politica vissuta in primo piano e della candidatura a sindaco di Milano come un progetto di vita. Milano non è solo la mia città, il luogo dove le strade riverberano ricordi e dove in mille facce scopro e riconosco il tempo della mia vita. Milano è anche un’ossessione scientifica. Ogni mia idea di architettura, ogni ricerca sulla condizione urbana, ogni numero delle riviste che ho diretto, ogni mia lezione in giro per il mondo, hanno sempre parlato di Milano. Di Milano città apparentemente limpida, di semplice lettura, dove la geografia ha assorbito la storia: la montagna bianca del Duomo al centro di un’unica grande piazza, quasi una radura; da qui partono strade antiche come telai attorno a cui, come onde concentriche, sono cresciute le sequenze della storia urbana; l’impronta della Milano romana e di quella celtica, il perimetro delle mura medioevali, i brani rinascimentali e quelli seicenteschi, il grande periodo dell’impero sforzesco e le nuove geografie della modernità – con le grandi infrastrutture civili ottocentesche (le ferrovie, il macello, l’ortomercato, il carcere…) e subito dopo le fabbriche e i quartieri operai; e infine la barriera corallina di migliaia di edifici solitari e ammassati che negli ultimi trent’anni ha avvolto e annullato i bordi della città.
IB
Una città di apparente semplicità, che nasconde pulsioni complesse. Che anticipa tendenze, crea movimenti ma che è anche capace di reazioni conservatrici e fughe in avanti. Una città che può anche essere cattiva con chi non la capisce…
SB
Milano non è in verità una città semplice; e neppure didascalica. Dentro a una geografia limpida vive un caleidoscopio invisibile di energie e spostamenti. Reti di potere che parlano con il mondo usando discorsi coltivati in un grappolo di palazzi di cemento bugnato compresi in poche centinaia di metri quadri di città. Ma anche migliaia di famiglie che, qui come in nessun altro luogo d’Italia, sperimentano la plasticità del vivere insieme. E una moltitudine di piccole e medie imprese che, come un motore diffuso e silenzioso, uniscono il destino per investire sul loro lavoro; e giovani, tantissimi giovani che, qui più che in qualsiasi altra città italiana, offrono il loro tempo alla causa dei più fragili. Il grande fascino di Milano, la mia grande ossessione, stanno nel miracolo di una complessità inafferrabile; qualcosa che va oltre la morfologia visibile della città, senza mai davvero negarla.
Milano ha un’anima polifonica e inafferrabile dentro un corpo solido e fisso. Milano è, per questo miracolo, l’ho sempre saputo, un laboratorio per le idee politiche; per idee che vanno ben oltre il suo territorio. Perché Milano chiede per sé idee speciali; idee capaci di decifrare sulla sua superficie le tracce e gli indizi generati da un mondo invisibile e complesso. Milano ha bisogno di quel tipo particolarissimo di idee che gettano un ponte tra le cose concrete del corpo e i desideri infiniti dell’anima, tra le cose da fare e capire oggi e i sogni e le visioni per domani. Per questo Milano è stata ed è oggi, sarà sempre, un laboratorio eccezionale per la Politica. Per quelle particolarissime idee, insieme semplici e complesse, volanti nel cielo e infilate come una trivella nel suolo, che fanno la politica migliore.
IB
Gran parte dei tuoi progetti di architettura e urbanistica sono stati pensati e realizzati a Milano. Non bastava? Perché mettersi a far politica?
SB
La «virata» del settembre 2010 è nata dall’accumulo di energie, anno dopo anno, spese nel tentativo di misurare, verificare l’utilità sociale delle mie scelte professionali; avendo sempre Milano come campo di sperimentazione e verifica. Progettando Milano sono nate idee spaziali e politiche come l’orto botanico planetario per Expo, il metrobosco (una cintura di tre milioni di nuovi alberi attorno a Milano),18 le case in legno riciclabili e prodotte dalle foreste lombarde per l’edilizia sociale.19 Pensando a Milano come laboratorio sono nati i progetti di Multiplicity20 sull’Europa, sul Mediterraneo, sui «dispositivi di confine»; ma anche le ricerche universitarie sulle «cronache dell’abitare»21 e sull’anticittà.
Per molti anni, lo spazio della politica è stato per me quello dell’architettura. Ma tutto questo a un certo punto non mi è più bastato.
Il grande investimento politico nei miei progetti di architettura, oltre che generare equivoci di ruolo, rischiava di diventare un ripiego all’assenza di una scelta decisa – insieme coraggiosa e per alcuni aspetti personali, anche un po’ irresponsabile – nella politica. Per dirlo con altre parole: questo eccesso di politica nella professione da un certo punto in poi mi è sembrato un’arma spuntata, un investimento insufficiente. Ho capito che continuare a orientare verso la politica i progetti, le ricerche, gli scritti non sarebbe più bastato a soddisfare quell’ossessione per Milano, che nascondeva anzi, meglio, incarnava l’ossessione per la politica.
Ecco dunque la «virata», con Milano come boa e una corrente fortissima a spingermi subito fuori (con la sconfitta alle primarie per la candidatura a sindaco) dalla rotta migliore, bella e diretta e lineare. E un timoniere incerto, che però da un certo punto in poi si accorge che sul timone, a tenerlo fermo, ci sono mille mani oltre la sua; e che la rotta non è mai lineare e che si corregge di continuo; e che questa sensazione di forza collettiva che ti sospinge è il senso profondo della politica – e per alcuni della vita stessa.
Riformismo radicale
IB
L’intenzione di questo libro è somigliare a un diario di bordo che racconta il tuo percorso attraverso due anni appassionanti della storia italiana; ma anche a un manifesto che accompagna un nuovo periodo del tuo impegno politico. Ti ho spesso sentito parlare della necessità in Italia di un riformismo radicale; qualcosa che è all’apparenza un ossimoro. La vulgata politica di questo paese associa infatti a riformismo l’idea di una chimera molto invocata e molto tradita. Chiunque può dichiararsi riformista perché il riformismo è stato stiracchiato come un elastico da tutte le famiglie politiche. Tutti vogliono riforme, nessuno le fa. O meglio, le fa o prova a farle il «tecnico» Monti. Ovvero un governo d’emergenza composto da non eletti, nato sulle macerie del fallimento della politica. E quel poco che si fa appare sempre – ironia della sorte – invariabilmente meritevole di una riforma immediata.
SB
Riformismo radicale significa costruire delle politiche di trasformazione che da un lato aspirino ad anticipare un mondo migliore e ne sappiano raccontare l’ampiezza e la novità – anche quando è radicalmente diversa dal presente, ma che dall’altro lato siano in grado di tradurre queste idee visionarie in una serie di azioni possibili; oggi, subito, qui.
Ma c’è qualcosa di più: l’idea di riformismo radicale riguarda anche la sfera etica e chiede, insieme, ostinazione e duttilità. Essere riformisti, in una società complessa, significa avere il coraggio di puntare a un obbiettivo di alto profilo, condividerlo, elaborare delle politiche per raggiungerlo; ma essere riformisti significa anche, da subito, da quando si comincia ad applicarle, sapere guardare agli effetti di queste politiche; anche a quelli indiretti e laterali, a quelli meno prevedibili e lontani.
Riformismo radicale significa, in altre parole, saper correggere in corsa le politiche attivate se necessario, senza mai perdere di vista l’obiettivo all’orizzonte e la sua utilità sociale. Significa sostituire a un’etica dell’azione – che si accontenta di riconoscere una coerenza tra intenzioni e azioni – un’etica delle responsabilità – che si interroga sugli effetti quotidiani del nostro agire politico, anche su quelli indiretti, laterali, a prima vista trascurabili.
Ma c’è di più: questo processo di continuo adattamento delle politiche quotidiane a una visione del futuro è possibile soltanto nella massima trasparenza. Perché ogni modifica delle politiche deve essere comunicata in tempo reale ai suoi destinatari – utenti, promotori, interlocutori della politica – e motivata nella necessità di raggiungere prima e meglio l’obbiettivo condiviso. E discussa. Il che implica una rivoluzione nel modo convenzionale, chiuso, di far politica.
IB
Tentiamo una definizione di politica che incarna questo concetto di riformismo radicale.
SB
Il riformismo radicale è la traduzione in politica del concetto di «fare di più con meno». Credo che le politiche che uniscono pragmatismo e visione, che sanno affrontare con realismo le nuove condizioni create dalla crisi e sanno vedere opportunità anche in un contesto di difficoltà, siano tutte politiche di riformismo radicale. Ma, insisto, le idee riformiste devono avere i piedi per terra e la testa nel cielo; radicali nelle ambizioni e nell’ostinazione, riformiste nel saper graduare, e se serve correggere in corsa, ogni passo. A volte, anche solo per difendere delle condizioni date, bisogna saper rilanciare. Penso all’idea delle scuole pubbliche aperte al quartiere, alle associazioni, ai giovani; ogni ora del giorno, ogni giorno dell’anno, per ogni età della vita. Un’idea potente che ha accompagnato molte stagioni della sinistra italiana, senza però mai diventare una politica attiva ed efficace. Durante la campagna elettorale di Milano abbiamo provato a declinare questa visione a partire dallo studio di alcune esperienze concrete di scuola aperta. E abbiamo capito che non bastava raccogliere queste esperienze, pur eroiche; occorreva un innesco forte. Occorreva lanciare la visione della scuola pubblica come la nostra prima e più importante infrastruttura sociale, diffusa e capillare come altre infrastrutture (alla pari delle strade, delle fognature, dei viadotti…), ma capace di sprigionare una straordinaria utilità sociale. Solo se concepite e supportate come infrastrutture sociali, le scuole pubbliche possono essere un nodo delle reti sul territorio; il luogo dove un quartiere, con le sue articolazioni, i suoi comitati, le sue espressioni più o meno organizzate discute e si incontra. Sono convinto che si debba abbandonare un concetto di infrastruttura riferito solo all’immagine di un supporto trasportistico, che ospita e genera flussi di merci e persone. Anche un insieme di elementi diffusi, isolati, può avere una natura infrastrutturale, reticolare. Pensiamo a come entrano in rapporto l’urbanistica e il design. La costruzione di una rete di strade, in ambito urbano, non garantisce di per sé un miglioramento della qualità urbana; addirittura, in qualche caso, può essere un elemento di degrado. Mentre a volte una buona segnaletica e un buon arredo urbano possono fare molto di più. La somma, la rete di elementi individuali, anche se minuti, genera infrastruttura.
La scuola pubblica e altre infrastrutture diffuse
IB
Sei anche andato più in là, lanciando l’idea di trasformare le scuole pubbliche milanesi in veri e propri Municipi di quartiere. È un progetto estendibile a una dimensione nazionale e, soprattutto, ti pare credibile in questi tempi di massicci tagli alla formazione?
SB
Oltre che svolgere la loro funzione pedagogica, le scuole pubbliche italiane possono diventare i terminali di un decentramento non burocratico. Ma c’è di più: richiamare la presenza geograficamente diffusa delle scuole pubbliche e dunque il loro ruolo di sensori nel territorio, e non solo di emittenti di sapere, è il modo più efficace per proteggere la scuola pubblica dall’aggressività di politiche che in questi anni hanno spostato investimenti ingenti verso le scuole private. Per conservare il loro ruolo di luoghi intergenerazionali e interculturali di scambio di saperi, è importante oggi ampliare la gamma delle prestazioni sociali delle scuole pubbliche, pur conoscendo il momento di grande sofferenza e difficoltà che attraversano: il drastico taglio dei finanziamenti all’edilizia scolastica, le difficoltà del corpo insegnante. Per evitare che la crisi completi un progressivo annientamento della scuola pubblica italiana, dobbiamo letteralmente «fare di più con ...