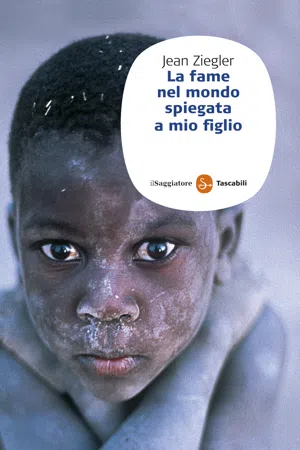I
Non capisco come, con l’avvicinarsi dell’anno Duemila e su un pianeta così ricco come il nostro, tanta gente continui a morire di fame.
Hai ragione, Karim! E visto che facciamo questa discussione durante la primavera del 1999, quando una terribile carestia colpisce la Somalia, questo fatto è ancora più evidente.
Il telegiornale ha iniziato a diffondere nell’indifferenza più assoluta, almeno così mi sembra, immagini di spettri somali, uomini, donne, bambini che, su gambe magre, fuggivano barcollanti dal sud della Somalia. Le hai viste queste immagini?
Per questo dico che è rivoltante!
Vedi, credo che in Occidente, nei paesi dove vivono molti ricchi, nessuno abbia preso semplicemente atto di questo orrore. O, per la precisione, ne abbiamo preso atto ma non si è verificata in noi alcuna rivolta della coscienza. Niente! La lenta distruzione, il martirio senza fine di queste famiglie somale fanno parte, come dire, di una sorta di normalità. Quanto hai visto in queste ultime sere e che adesso, all’inizio di gennaio, è già scomparso dagli schermi, mentre la tragedia prosegue e s’ingrandisce, non è che l’aspetto più «presentabile» della carestia in Somalia. In realtà questa carestia innalza montagne di cadaveri nella Somalia del sud, a Galcasc, Cola, Dugiuma, Gherille. E queste vittime non le vedi. Nessuno le vede. Le telecamere di TF1, della RAI, della ZDF e della BBC sono a centinaia di chilometri da là, nell’Ogaden, all’entrata dei campi etiopici. Quelli che tu vedi sono, almeno temporaneamente, i sopravvissuti; sono quelli che hanno avuto la forza sufficiente per attraversare la frontiera e raggiungere uno dei feeding centers, i campi di accoglienza, nell’Ogaden per l’appunto.
Dove si trova l’Ogaden?
È la vasta provincia etiopica più vicina alla Somalia, ed è in gran parte popolata da pastori e contadini somali. L’imperatore Menelik d’Addis Abeba ha conquistato, più di ottant’anni fa, questa parte dell’antica Somalia e l’ha annessa con la forza al suo impero. Di fatto, oggi l’Etiopia è povera come Giobbe. Inoltre, l’attuale governo di Addis Abeba che, dopo una guerra di oltre vent’anni, è succeduto agli imperatori Amhara e a un dittatore militare, è anch’esso nuovamente in guerra! Questa volta contro il suo vicino settentrionale: la Repubblica d’Eritrea.
Tutto questo per dirti che le poche decine di migliaia di sopravvissuti ai massacri della Somalia del sud arrivano in un paese oggi sull’orlo della catastrofe. Molti campi d’accoglienza delle regioni etiopiche di Dolo, di Kallalo non sono più che campi di raccolta in attesa della morte.
Ma cosa fa il governo somalo? Tutte queste decine di migliaia di vittime della siccità, queste famiglie di pastori nomadi le cui bestie sono morte, sono dopotutto cittadini somali.
Effettivamente è difficile da capire. La Somalia è più grande della Francia di quasi 100000 km2, ma ha una popolazione nettamente inferiore: meno di dieci milioni di persone. Oggi l’economia è in ripresa nel nord. Nelle regioni dell’Hargeysa, nella valle del Nogal e in molte altre vaste contrade di questo immenso paese, i pozzi sono pieni, i raccolti buoni e le greggi abbondanti.
E, ciò nonostante, il governo non fa nulla per le decine di migliaia di compatrioti agonizzanti?
Il problema sta nel fatto che da oltre dieci anni la fiera Somalia (che pure è abitata da un solo popolo, che parla una sola lingua, condivide una sola religione e non conosce le lacerazioni etniche di tanti altri paesi africani) non ha più un governo degno di questo nome. Clan rivali si combattono a colpi di cannone, di kalashnikov, di coltello, e ognuno è guidato da un signore della guerra che ambisce a una sola cosa: il potere assoluto, la ricchezza, le greggi per il suo clan.
Là, al sud, dove imperversa la fame, c’è un piccolo porto: Merca. I combattimenti ne hanno già distrutto le banchine. I battelli carichi di riso inviati dalle organizzazioni internazionali sono ancorati al largo. Scialuppe primitive e fragili trasportano i sacchi al porto. Sui moli del porto in parte distrutti, giovani armati, spesso con gli occhi lucidi per il kif, prelevano la loro decima. Caricano i sacchi sugli autocarri per rivenderli ai mercati del nord. E, cosa ancora più deprecabile, Mogadiscio, uno dei porti meglio equipaggiati di tutto l’oceano Indiano, originariamente costruito da colonizzatori italiani, dispone di gru, silos, nastri trasportatori e bacini d’acqua profonda capaci di accogliere e stoccare migliaia e migliaia di tonnellate di merci al giorno. Questo porto moderno si trova un po’ a nord di Merca, dunque non lontano dalle zone dove si muore. Ma Mogadiscio è paralizzata. Il porto è chiuso. I signori locali combattono a ogni angolo. Risultato: l’aiuto internazionale non arriva. Le navi straniere, per paura del saccheggio, non attraccano. Gli equipaggi – e li capisco – temono per la loro vita. La cattura d’ostaggi è un’impresa fiorente in Somalia!
Questi signori della guerra sono criminali, assassini del loro stesso popolo!
Esattamente.
Miscuglio di tabacco e canapa indiana in uso nel Nordafrica. [N.d.T.]
II
Quante persone al mondo, oggi, rischiano di morire di fame?
La FAO (Food and Agriculture Organization), l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite, nel suo più recente rapporto stima siano state più di trenta milioni le persone morte per fame nel 1998. Nello stesso anno gli esseri umani che hanno sofferto di denutrizione grave e permanente sono stati più di 828 milioni. Si tratta di uomini, donne e bambini che, a causa della penuria di alimenti, hanno subìto lesioni irreversibili, e sono condannati a morire in un arco di tempo più o meno breve o a vegetare in un grave stato di handicap (cecità, rachitismo, sviluppo insufficiente delle capacità celebrali ecc.).
Prendiamo l’esempio della cecità: ogni anno sette milioni di persone, spesso bambini, perdono la vista, la maggior parte di loro per mancanza di un’alimentazione sufficiente o in seguito a malattie legate al sottosviluppo. Nei paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina vivono 146 milioni di ciechi. Nel 1999, Gore Brundtland, direttrice dell’Organizzazione mondiale della sanità, presentando a Ginevra il suo piano «Vision 2000», affermò: «L’80% delle lesioni alla vista sarebbero totalmente evitabili». In particolare, con una regolare assunzione di vitamina A nei bambini in età prescolare. In breve: ogni anno circa un quinto dell’umanità viene deliberatamente annientato dalla denutrizione e dalla fame. Nel 1990 erano 822 i milioni di persone gravemente colpite dalla fame; nel 1998 erano divenuti 828. Queste statistiche hanno una doppia chiave di lettura. Prima lettura: le vittime della denutrizione nel mondo aumentano incessantemente, soprattutto nei paesi del sud del pianeta. Tuttavia se si paragonano le morti per denutrizione con l’aumento demografico della popolazione mondiale, si osserva una lieve flessione: nel 1990 il 20% dell’umanità soffriva di sottoalimentazione acuta: otto anni più tardi, la percentuale era «solo» del 19%.
Dove vivono le persone colpite dalla carestia?
Nell’Est e nel Sud dell’Asia ne sono gravemente colpiti uomini, donne e bambini in numero pari al 18% della popolazione. In Africa, il loro numero sale al 35%. Nell’America Latina e nei Caraibi è pari al 14%. I tre quarti dei «gravemente sottoalimentati» del pianeta vivono nelle campagne. Un quarto sono abitanti delle bidonvilles raggruppate intorno alle megalopoli del Terzo Mondo.
Come mai? Sono dunque gli abitanti delle campagne, i contadini che producono il cibo a soffrire maggiormente della sua mancanza?
Eh sì! L’Africa subsahariana, per esempio, possiede una classe contadina formidabile, lavoratrice, dotata di una sapienza ancestrale, energica e capace di lavorare fino alla sfinimento. E sono soprattutto questi contadini che non riescono mai a saziare la fame in tutta la loro vita. Sono spesso loro a morire in seguito a malnutrizione o a essere vittime delle grandi carestie.
L’Africa è il continente più colpito?
No, in cifre assolute è l’Asia. Sono 550 milioni le persone colpite gravemente dalla sottoalimentazione che vivono nel continente asiatico contro i «soli» 170 milioni dell’Africa subsahariana.
Il nostro continente, l’Europa, è al sicuro dalle devastazioni della fame?
Niente affatto! Anche qui la fame ha fatto la sua apparizione, in particolare nei paesi dell’Europa orientale e tra le rovine della vecchia Unione Sovietica. L’isolamento e l’estrema povertà colpiscono soprattutto gli anziani inattivi, le donne sole, i bambini in tenera età. I sistemi statali di assistenza sociale (come d’altra parte anche le agricolture collettiviste, sovvenzionate e protette artificialmente) sono affondati nella tempesta della liberalizzazione selvaggia. Questo capitalismo brutale, spesso di stampo mafioso, lascia senza difese i membri più vulnerabili della società. Ti faccio un esempio.
Nel 1997, una commissione di nutrizionisti, di medici, di antropologi, incaricati da Boris Eltsin di valutare i danni prodotti dalla fame e dalla sottoalimentazione cronica nei popoli della Federazione russa, ha pubblicato le seguenti conclusioni: nelle classifiche della speranza di vita media, gli uomini della Federazione occupano oggi la centotrentacinquesima posizione nel mondo, le donne la centesima. La speranza di vita media degli abitanti della Federazione è ormai ampiamente inferiore a quella di tutti gli abitanti dell’Europa o dell’America del Nord. Mentre prima del 1991, data della caduta dell’Unione Sovietica, la situazione era perlopiù identica per i russi, gli europei e gli americani, oggi la speranza di vita media dei russi (compresi i siberiani e tutte le altre popolazioni della Federazione) è addirittura inferiore a quella dell’insieme delle popolazioni asiatiche, eccezione fatta per i cambogiani e gli afgani. Un cittadino della Federazione muore diciassette anni prima di uno svedese e tredici anni prima di uno americano.
Ancora una cosa: si può morire di fame anche in un paese ricco. La Russia ne è un buon esempio. La Federazione russa è oggi la prima produttrice al mondo di oro, di uranio, di petrolio e di gas naturale. Inoltre, è la seconda potenza nucleare del pianeta. Ci sono anche altri esempi di questo paradosso: il Congo possiede alcuni dei più favolosi depositi minerari del pianeta. Ma lì, oggi, migliaia di persone muoiono di fame. In Brasile un’oligarchia assassina monopolizza i centri nevralgici delle ricchezze. Il paese è tra i maggiori esportatori di cereali del mondo e tuttavia negli stati del nordest la sottoalimentazione provoca ogni anno vere e proprie stragi.
III
Da dove arriva la fame?
Viene dalla notte dei tempi! Accompagna l’umanità sin dai suoi primordi. È stata l’ossessione quotidiana degli uomini dell’età neolitica. Le città di Ur e Babilonia venivano devastate da carestie ricorrenti, mentre una fame spaventosa spopolava periodicamente le campagne degli antichi greci e romani. Nel Medioevo milioni di servi della gleba, di contadini liberi, di abitanti delle città, sono morti di inedia con le loro mogli e i loro figli. Per tutto il XIX secolo le carestie hanno ucciso centinaia di migliaia di esseri umani in Cina, in Africa, in Russia e nell’Impero Ottomano. Karl Marx credeva che la mancanza oggettiva di cibo avrebbe accompagnato l’umanità ancora per molti secoli. Tutta la sua teoria politica ed economica, tutta la sua visione sociale del mondo si basava su questa ipotesi: i beni disponibili sul pianeta non bastano a coprire i bisogni elementari e insopprimibili degli uomini. Per questo la lotta per il cibo – le guerre, i conflitti, le rivolte causate dalla fame – è perpetua.
Secondo Marx, lo sarà per i prossimi secoli. Nel pensiero marxista la coppia maledetta padrone schiavo accompagnerà...