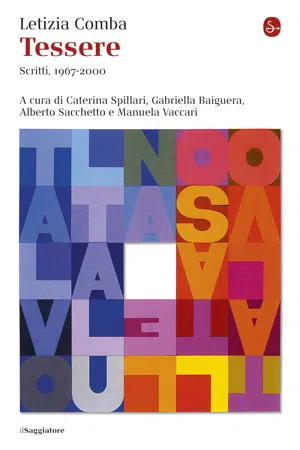Premessa
di Renato A. Rozzi
Ho conosciuto Letizia nel 1968 a Gorizia, nel manicomio diretto da Basaglia, unica donna nella sua équipe e l’unica senza laurea in medicina. Mi dissero che era una psicologa (solo in seguito ci sarebbe stata una laurea e una legittimazione di questo ruolo), e che si prendeva cura del «C donne: l’ultimo reparto chiuso» (è il titolo del suo essenziale scritto nell’Istituzione negata). Letizia si era schiusa come psicologa attraverso quell’esperienza: era una donna libera, che dava subito un forte segno di sé.
Quel reparto aveva contribuito ad aprirlo da qualche mese ma veniva pur sempre considerato assai difficile, la sua gestione precedente pesava ancora. Letizia si era caricata il peso di quelle donne che avevano cominciato a essere considerate persone. Ciò dice molto della sua figura: coraggio, serietà, dedizione, il vero prendersi cura. Da questo insieme femminile altamente significativo iniziava qualcosa di cui la storia delle donne in Italia dopo il decollo economico deve tenere conto.
Una delle prove di chi era Letizia è per me il nostro colloquio (anch’io «psicologo» altrettanto solo) quando siamo usciti da quel reparto: abbiamo parlato dell’abbandono che quelle donne esprimevano, del loro modo diverso dagli uomini di vivere quella condizione. Sarebbero arrivate soltanto dopo qualche anno altre conferme di ciò che lei aveva intuito (per esempio gli influssi della scuola inglese – Bowlby ecc. – sul concetto di perdita dell’attaccamento): Letizia era già entrata in quelle donne, nel loro ripiegamento in un mondo interno desolato (gli uomini avevano almeno la possibilità di esternare aggressivamente di più).
L’apertura di quel reparto era stata molto discussa (quanti allora ce n’erano in Italia, altrettanto chiusi?): si stava cominciando a capire meglio in che modo la donna aveva serrato dentro di sé – nella propria casa interna – quel dolore che da sempre limitava così tanto il suo essere al mondo. Io avevo già la mia scorza, ma è stato importante l’incontro con quella Letizia-testimone, sola, scontrosa, schietta, con un pudore orgoglioso che la faceva sembrare soltanto oggettiva mentre al contrario cercava di restituire soggettività a tutti. Si sentiva quanto questo atteggiamento fosse fondato nel suo profondo, nella sua potenziale religiosità. Allora stava cominciando a rivelarsi possibile una liberazione in tante direzioni, in una delle quali Letizia era già andata avanti.
Una prova di quell’atmosfera liberatoria è nelle due assemblee di comunità tra medici e infermieri e pazienti qui riportate. È un esempio di finezza nell’analisi del lavoro remunerato degli ospiti, un esempio di attenzione, pazienza, rispetto, ricerca della comprensione reciproca. Ospiti, infermieri, medici parlano dal proprio ruolo ma con una fondamentale parità di fondo. Colpisce soprattutto il livello «sindacale» che, discutendo la loro condizione di lavoro, mostravano quarant’anni fa questi ospiti dell’istituzione totale, ai quali nessuno aveva mai dato la parola: quel salto liberatorio ci dice quanta fiducia creativa si sprigionava allora da un’iniziativa che nell’istituzione goriziana era normale, altrove inesistente.
Con la prefazione a L’io diviso di Laing e soprattutto quella a Normalità e follia nella famiglia di Laing ed Esterson, Letizia entra a fondo nel rapporto fra il sano e il malato, fra chi cura e chi è curato, andando incontro al bisogno crescente d’approfondire questo tema. Si comprende la forza problematica che esce dalle sue pagine introduttive alle undici interviste a famiglie del libro di Laing ed Esterson, se si tiene presente la spinta rinnovante nei rapporti umani di quel momento storico, in particolare l’annunciarsi di un nuovo modo di intendere le difficoltà della famiglia. Questo messaggio critico ebbe risonanza soprattutto in una parte femminile del movimento giovanile. Finalmente a sinistra si parlava della sofferenza psicologica, e non solo dei bisogni materiali e della centralità della fabbrica e del lavoro, e si dava evidenza alla soggettività sia individuale sia collettiva che stava anche politicamente emergendo dalla trasformazione della nostra società, una soggettività che, se liberata, si rivolgeva a tutti noi, perfino dall’interno dei «lager» psichiatrici.
È quest’atmosfera di radicale rinnovamento socioculturale che ha consentito a Letizia di approfondire il rapporto tra lo psichiatra e «colui che viene chiamato schizofrenico», e ciò pur nella consapevolezza che «il discorso sulla malattia mentale rimane irrisolto» (solo in quel momento, tra l’altro, l’ancora esigua e troppo ortodossa psicoanalisi italiana cominciava a pensare che lo psicotico non fosse inavvicinabile, e a non tenersi più discosta dal problema anche sociale della malattia mentale).
Al centro di questa nuova azione conoscitiva viene posta la famiglia e la sua corresponsabilità nelle difficoltà gravi di uno dei suoi membri. Questo tema è affrontato da Letizia con radicalità, senza però cadere nelle generalizzazioni politiche surriscaldate dalle posizioni solo antipsichiatriche tipiche di quel periodo. Di fronte all’immaturità di tanta parte del movimento giovanile Letizia ha sempre sentito il suo compito costruttivo, anticipatore: la sua ricerca conferma che la malattia mentale esiste e non può essere negata, ma conferma anche le nostre responsabilità personali, e mette in luce il processo sociale che le determina. Invece di parlare soltanto di una famiglia malata, essa preferisce parlare di una «famiglia debole» o «diversa», travolta dalle contraddittorie richieste dei familiari e della società.
Allargando lo spazio critico Letizia individua nella posizione di Laing ed Esterson un limite, «l’assenza dell’analisi della società, e perciò di un discorso politico». Attraverso la cultura che essa propone, il Sessantotto ci appare anche come il modo concreto e non solo polemico (come capitava nell’estremismo di allora), di affrontare la violenza presente nella famiglia. La violenza continuava ad attraversare quell’improvvisa, inaspettata società affluente, e la famiglia era uno dei punti in cui la violenza sociale più nascosta si rivelava, diretta sulla vittima designata («che prima era normale, poi cattiva, e infine pazza»).
Oggi ci rendiamo conto che queste erano le prime prove del fatto che con quel confuso passaggio della nostra società d’allora dalla penuria al consumo non si stavano davvero superando democraticamente le contraddizioni e le sofferenze precedenti: esse si riproducevano pur in forma diversa anche in una società che diventava ricca ma rimaneva avida e disuguale. Di qui veniva la scoperta che stava avvenendo ciò che Letizia definisce una «relativa preminenza delle contraddizioni soggettive su quelle obiettive». È una consapevolezza decisiva: rende non più sovrastrutturale il mondo psichico di cui si occupa la psicologia. Ed è evidentemente una critica non solo a ogni potere ma in particolare all’oggettivismo della cultura comunista. Con una nuova efficacia teorico-pratica la posizione fino allora laterale delle scienze della psiche acquistava una sostanza diversa.
È questa l’apertura conoscitiva e politica che allora è caduta sulle spalle degli anticipatori come Letizia: quante difficoltà però in questo ruolo critico, che affermava come politicamente decisivo il terreno soggettivo, pur validato da una scienza non ancora socialmente convincente e approvata. Una figura come la sua inoltre era guardata con sospetto perché filosofa di provenienza, e politicizzata, e perché era indipendente sia dalla cultura comunista sia da quella cattolica nelle cui mani si accentravano i poteri sui fatti soggettivi. Letizia in più è una donna e la sua presenza tra le donne del manicomio è una novità che mette in luce qualcosa di inaspettato e apre a conoscenze nuove (un esempio: Letizia trae dalla dimenticanza un tema particolare, quello del corpo femminile, le suggestioni allora le venivano per lo più dalla cultura francese, da Sartre ecc.).
Per il potere culturale-politico di allora non contano però a sufficienza né l’approfondimento di nuovi temi né i primi riusciti cambiamenti realizzati nell’istituzione totale, insomma le prime importanti conferme teoriche e pratiche. Con lo spegnersi dell’ondata liberatoria giovanile, anche per l’impegno di ricerca e d’insegnamento di Letizia le cose si fanno più difficili. Non è un caso che alcuni anni dopo ho dovuto difenderla dal ripetersi del tentativo di espulsione dall’insegnamento universitario da parte degli scienziati della psicologia. Era una docente irreprensibile, stimolante ma rispettosa, molto colta ma minoritaria (e sorridendo aggiungo: troppo seria).
Per giudicarla ci voleva quel coraggio conoscitivo che non caratterizzava certo quelle dominanti figure della psicologia accademica avverse a ciò che avveniva fuori dalla loro cerchia di potere. Oggi questa pubblicazione permette un giudizio più giusto su Letizia come psicologa in quegli anni in cui la nostra società dava il via all’attuale utilizzazione indiscriminata, incontrollabile, degli psicologi. Un modello alto, severo e generoso di psicologia come il suo andava nella direzione contraria all’attuale sconosciuta massa degli psicologi (quasi sessantamila solo nell’Albo). In queste sue caratteristiche, in cui si avvertiva anche l’ascendenza valdese (li chiamavo con simpatia i protestanti di sinistra), Letizia incarnava il reale «prendersi cura» non solo psicoterapeutico, che dovrebbe essere un metro di misura anche degli psicologi d’oggi.
Psicoanalista, ha fatto ricerca di psicologia del lavoro all’Olivetti di Ivrea; ha insegnato Psicologia sociale e dell’età evolutiva alle università di Urbino e Verona. È stato uno dei primi a unirsi a Franco Basaglia, a Gorizia, nel 1967.
Il lavoro rende liberi?
Alcuni problemi posti dal lavoro dei ricoverati nelle istituzioni psichiatriche, e dalla retribuzione di questo lavoro, sono stati argomento di discussione per le due assemblee di comunità svoltesi il 7 e 9 gennaio 1967, alle quali hanno partecipato pazienti, medici ed infermieri; se ne trascriverà integralmente la registrazione commentando i passaggi che sono sembrati di maggior interesse.
Non è molto usuale che le persone più direttamente interessate al problema – i pazienti lavoratori – si trovino a discuterne insieme: ma non vi è alcun dubbio che il lavoro, anche se sotto forma di «ergoterapia», sia vissuto dal paziente come un importante punto di riferimento della sua vita quotidiana ospedaliera; un punto di riferimento nel quale egli spesso finisce per investire un valore e un significato che trascendono quelli propriamente terapeutici. E, dalla parte delle istituzioni, da sempre è stato fatto non poco perché il lavoro del paziente assumesse una posizione centrale, e alla fine insostituibile, nella loro struttura. Nel secolo XIX, in epoca prepositivistica, il lavoro faceva già parte dei principi del trattamento morale del paziente negli ospedali, allora aperti; poi l’orientamento ufficiale della psichiatria positivistica mutò, al riguardo: ma non per questo molti pazienti cessarono di collaborare con la loro attività silenziosa, nel chiuso degli ospedali; e infine, per opera soprattutto di H. Simon (1929) una quadrata ideologia medica propose una rivalutazione del lavoro nelle istituzioni psichiatriche, reinvestendovi un valore «terapeutico»; con Simon, esso è divenuto un mezzo di «terapia più attiva» del malato, uno specifico per ricostruirne e riplasmarne la personalità attraverso varie tappe scalari di attività lavorativa. Da allora l’«ergoterapia» è in ogni ospedale psichiatrico. Mutuando l’ideologia ergoterapica la psichiatria asilare postsimoniana ha agevolato una suddivisione in classi dei pazienti che ne venivano in contatto: da un lato coloro che si riteneva possibile curare con altri mezzi, per restituirli al più presto «reintegrati» alla società; poi quelli che rimanevano rinchiusi come oggetti passivi di assistenza; e coloro, infine, che avrebbero riacquistato lentamente la loro libertà all’interno dell’ospedale, lavorando nella – e per la – istituzione, reintegrandosi ed adattandosi in tal modo alla microsocietà istituzionale.
È molto probabile che alla base delle contraddizioni inerenti al lavoro dei ricoverati stia il tentativo di stabilire una equazione fra due entità – lavoro e terapia – che per almeno un aspetto appaiono irriducibilmente incommensurabili. Infatti l’attività lavorativa del paziente da un lato può essere un’azione sociale più o meno spontanea, e in quanto tale principalmente terapeutica; dall’altro però essa è sempre reale forza lavorativa, energia prodotta, che può essere alienata solo o con un libero contratto o con un atto di imposizione. Dinnanzi a questa contraddizione la istituzione è sempre ambigua, perché ha bisogno contemporaneamente di entrambe le caratteristiche del lavoro: del suo aspetto terapeutico per mobilitare la partecipazione attiva del paziente alla interazione terapeutica, e del suo esser sempre anche forza-lavoro, per muovere e tenere in vita il funzionamento del meccanismo istituzionale. L’etica prevalente non consente all’istituzione di scambiare dichiaratamente il lavoro con la prestazione terapeutica o assistenziale (e poi, come attuare questo scambio se il partner del contratto non esiste in realtà, dato che è privato, per definizione, della sua libertà?); l’istituzione non può quindi che identificare i due termini del problema: dunque il lavoro è terapia. Le idee di H. Simon si rivelano subito risolutive: con il lavoro-terapia il malato riacquisterà la sua libertà, lavorerà senza contratto per essere in grado di stipulare ancora un vero contratto di lavoro, ma una volta reso libero, in un futuro non precisabile.
Il lavoro rende liberi, dunque? Nelle due assemblee sono accennati molti tentativi di risposta a questo interrogativo implicito, talora contraddittori, che spesso dimostrano una presa di coscienza ancora assai parziale; soprattutto sarebbe inutile cercarvi una risposta negativa, una chiara denuncia o, meno ancora, espressioni «toccanti» di autocommiserazione: anche perché non è questo un discorso obiettivo e distaccato sul lavoro i...