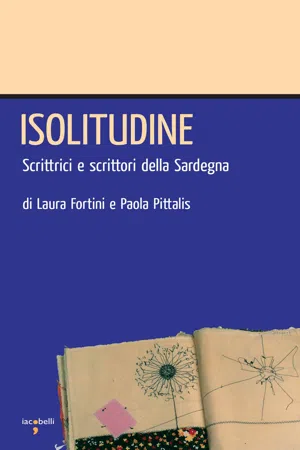Salvatore Mannuzzu
e la grazia terrena*
Laura Fortini
Qualsiasi mappa – quella appena tracciata non vuol essere altro – è di per sé arbitraria: risponde a convenzioni che, costituendone la chiave, devono rendersi esplicite.
Salvatore Mannuzzu, Le ceneri del Montiferro
Parola in figura o dell’ekphrasis novecentesca
Chiunque si sia misurato con la lettura di Alice, il romanzo di Salvatore Mannuzzu pubblicato nel 2001, sa che le prime pagine provocano una sorta di stranito malessere, un andirivieni tra la scrittura e la copertina del libro stesso inusuale e desueto, non solo per lo stile narrativo cui siamo abituati con altre opere di questo autore, ma più in genere nella narrativa contemporanea.
Il primo capitolo, con il titolo oggettivo “Il relitto” si apre, infatti, su di una voce narrante interna che afferma di avere davanti a sé «una fotografia piuttosto antica, riprodotta sulla carta patinata d’una rivista inglese uscita, invece, verso la metà degli ultimi anni Novanta» (Mannuzzu 2001, p. 5). Vi è una breve didascalia della fotografia: «relitto del brigantino francese Alice. Penisola di North Beach, foce del Columbia River, 1909». Null’altro. Non parole, solo l’immagine, che la voce narrante cerca adesso di descrivere: «Ciò mi aiuta, penso, a vederne tutti i particolari, anche i più minuti cui finora non ho badato – minuti però (chissà) non irrilevanti: può darsi che enunciandoli io riesca a capire sino in fondo i motivi della mia attenzione» (ivi, cors. mio).
È l’enunciazione, sembra di capire, ciò che ci condurrà a mo’ di bussola nei vasti anfratti del romanzo, e ci apprestiamo, quindi, da buoni e buone lettrici a metterci comodi nella nostra immaginaria poltrona (presunta o reale che essa sia), per goderci il piacere della parola che scorre, che ci conduce con il suo suono in quella sorta di pensiero parlante che è la narrazione, che al suo meglio diviene forma e architettura del mondo. Ma, aggiunge subito dopo il narratore, non è possibile «adeguare le parole a ciò che gli occhi vedono: rimane uno iato incolmabile, come fra qualità irrimediabilmente diverse. Ma è pure vero il contrario: le parole forniscono un apporto che è vano cercare altrove; forse anch’esso, in qualche modo, riguarda la cosa vista: non meno della sua immagine (o quasi)» (ivi).
Forniti di tale avvertenze all’uso continuiamo la lettura, seguendo le parole scritte nella descrizione della pagina gualcita che riproduce la fotografia del relitto di un bastimento a vela, controluce. Sappiamo già, da lettori mediamente avvertiti, che il suo ruolo è importante, tanto da dare il titolo al romanzo intero, e quindi siamo, con le dovute cautele, ben predisposti a comprenderne la valenza, il valore intrinseco che essa darà alla narrazione. Ma man mano che le pagine successive si addentrano nella descrizione meticolosa dell’immagine del bastimento a vela, arenato su una proda desertica, su cui «spira attorno un’aria definitiva di abbandono» (ivi, p. 6), tre le presenze umane, due minuscole e un uomo dinanzi che sovrasta il tutto, un dubbio ci assale e incominciamo a tornare indietro, guardando con più attenzione di quanto si sia fatto fino a quel momento la copertina del romanzo, occhieggiandola un po’ sospettosi, quasi increduli, per poi rivolgerci al risvolto di copertina per leggervi, con un sospiro di accoglienza, «Relitto del brigantino francese Alice. Penisola di North Beach, foce del Columbia River, 1909». A questo punto il movimento è quello della rilettura per confrontare, un po’ febbrilmente, la descrizione nelle parole della voce narrante con l’immagine che si ha davanti: eccola, la fotografia! Ecco il brigantino... ecco... Quell’andirivieni un po’ convulso produce, ha prodotto, uno stranito malessere, per la scarsa abitudine che si ha con la lettura altalenante, sempre tesa, semmai, la lettura, alla fine piuttosto che all’indietro.
Ho cercato di mantenere nella memoria, tenendola cara, quella prima impressione di straniamento, perché penso che essa sia importante per la lettura complessiva di quest’opera e perché essa va persa nel corso della lettura e rilettura di Alice. Lo straniamento ci diviene, infatti, progressivamente sempre più familiare e cessa perciò di essere tale grazie alla reiterazione della immagine del brigantino, vera parola in figura – come si sarebbe affermato negli Emblemata del Cinquecento per arrivare fino alla qualità del pensiero visivo di Arnheim – che racchiude un significato recondito, la cui chiave, altresì password nel corso della narrazione, costituisce fondamento e specifica del discorso narrativo dell’opera che si sta leggendo. Parola in figura che costituisce una sorta di narratio obliqua nell’ambito del romanzo, una funzione questa che molto ricorda l’ekphrasis, topos figurativo che riprendendo il precetto oraziano dell’ut pictura poesis descrive in parole un’opera d’arte, e presente nei vari scudi, bassorilievi, padiglioni, di poemi che vanno dalla Teogo...