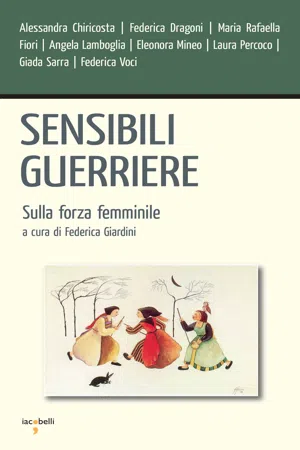La forza e la grazia. Per una genealogia
Federica Giardini
È la forza che contrasta la violenza, parola di donna. Questo punto di partenza può apparire scorretto o paradossale. Per rendersene conto basta partire dall’attualità e dall’intreccio tra la guerra, esercizio legittimo della forza, la violenza, che è sempre quella altrui a denunciarne la connotazione irrimediabilmente negativa, e il potere, violenza incivilita, che si esercita negli spazi contigui dell’arbitrio e del dominio. Guerra, violenza, potere – e vincitore e vinto, carnefice e vittima, dominatore e dominato – sono posizioni antiche.
Ma non lo sono le parole che le definiscono e le ordinano, a partire da un fatto: le donne vi si trovano come oggetto di parole altrui – il che non è una novità (Collin et al. 2000), se non per la diffusione e visibilità del fenomeno – o come soggetto di tali parole. In effetti, prendere parola su di sé oggi non significa sempre o soltanto mettersi in una posizione di forza, tutt’altro. Talora, una donna assume se stessa e il proprio genere come oggetto di violenza o di dominio. Soggetto dunque di discorso, ma oggetto della forza e violenza altrui: questa la sequenza che oggi va per la maggiore – che sia per ragioni di sicurezza interna o di polizia internazionale.
L’esempio più immediato che viene in mente è la composizione retorica di questi elementi nei mesi che, dopo l’11 settembre 2001, prepararono l’intervento militare occidentale in Afghanistan e poi la guerra contro l’Iraq, quando capi di stato o chi per essi rivendicavano la libertà femminile dei loro Paesi e la necessità di riscattare le donne vittime di altri regimi. Allora, la retorica tradì solo in minima parte la propria incongruenza: portavoce di parlamenti a stragrande maggioranza maschile facevano proprio il valore della presenza delle donne per accusare altri regimi di violenza patriarcale. E, dunque, muovevano guerra. Il discorso è potuto passare per via di un raddoppio del confine di alterità: a Occidente gli amanti della libertà femminile, in Medio Oriente i suoi persecutori. Rappresentazione povera, prima trappola che imbriglia l’immaginazione, quella che apre strade alle passioni, alle spinte del corpo e lo restituisce a se stesso: noi donne occidentali saremmo le sorelle fortunate, per grazia del riconoscimento altrui, di altre invece dominate.
La cosa, come accade per le retoriche, è insieme vera e falsa. Che per noi ci sia libertà femminile è un fatto, ma la parola che può pesare è quella delle donne stesse: va detto a che condizioni e, soprattutto, in quali rapporti con la libertà e l’illibertà di altre donne nel mondo, lasciando che siano loro a dire di forze e debolezze.
Come spesso accade nell’immaginario, che procede per coppie di opposti, la riviviscenza della figura della vittima si è accompagnata alla rinascita della donna violenta. Basti pensare alle cronache che hanno indugiato sulle madri infanticide, alla scandalosa soldata americana di Abu Ghraib e alle “fidanzate di Allah”, o alle serie televisive sulle donne assassine e ai tanti film che hanno ricreato il personaggio della vendicatrice (DWF 2009). Su questa contiguità femminile alla violenza – che si articola secondo gli stili più diversi, dal ritorno dell’arcaico a un contemporaneo senza precedenti – si aggiunge il ritorno di parole del femminismo sulla violenza negli scontri di piazza in cui una donna si ritrova ammutolita in una situazione che salta tutte le mediazioni:
Fino al giorno prima parlavano, poi sul crinale dei bancomat presi d’assalto e di macchine incendiate il filo che teneva assieme il dialogo donne/uomini nel movimento si è interrotto: gli uomini parlano e rivendicano (non tutti) quelle modalità guerresche, le donne (in gran parte) tacciono, non trovano mediazioni per quel che avrebbero da dire. (Cosentino 2010).
Ma è ancora possibile distribuire così la partecipazione alla violenza? E davvero la violenza è solo quella senza parole, è quella che si manifesta come irruzione solo e immediatamente fisica? A pensare alla partecipazione delle studentesse alle ultime manifestazioni contro la riforma dell’università, mi appare necessario riaprire la lettura dell’esperienza e dei tempi correnti, dipanare i fili che si sono confusi tra violenza esercitata e subita – esiste una violenza incivilita che è quella del potere e che, pur non presentandosi nella forma dello scontro fisico, ha grandi effetti sui corpi e sulle passioni – e, soprattutto, ascoltare e osservare la spinta del desiderio di donne più giovani, che cercano forza e la esprimono nel prendere posizione rispetto a un’ingiustizia virulenta che si esercita sui bisogni più elementari, fin nel corpo (Mercandino 2011).
Ad arricchire ulteriormente la terra su cui ci muoviamo, arrivano le parole di donne che invece assumono una propria forza. Ne è un esempio, che viene da lontano, la lettura della nota “femminilizzazione della società” come momento di esplosione ed espansione delle capacità di ciascuna (Paolozzi 2010). Il piano su cui ci mettono queste osservazioni è un terreno scivoloso: quante volte si sono sentite obiezioni che richiamavano a una realtà prossima dove le donne sono tutt’altro che in posizione...