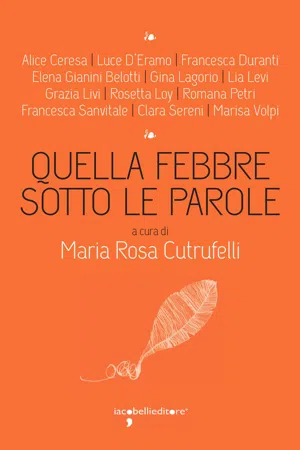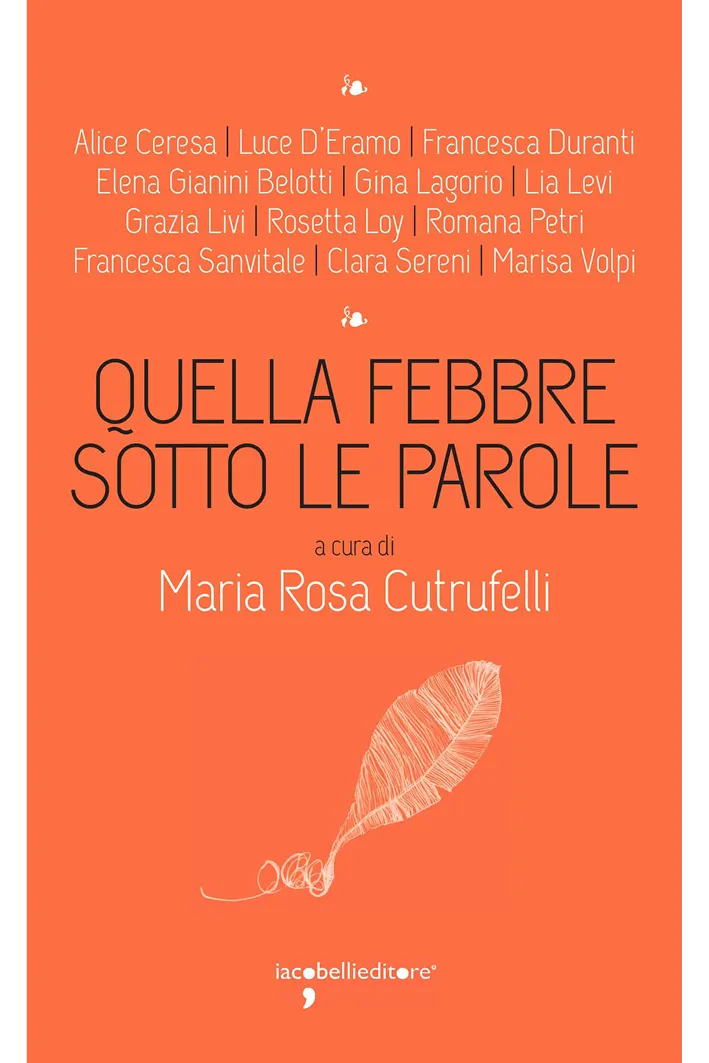Il disegno di copertina è di Mariella Biglino
© 2020 iacobellieditore®
Tutti i diritti riservati
prima edizione elettronica: Aprile 2020
prima edizione stampa: Agosto 2016
www.iacobellieditore.it
isbn elettronico: 978-88-6252-580-0
isbn stampa: 978-88-6252-321-9
Quella febbre
sotto le parole
a cura di
Maria Rosa Cutrufelli
con
Alice Ceresa, Luce d’Eramo,
Francesca Duranti, Elena Gianini Belotti, Gina Lagorio, Lia Levi,
Grazia Livi, Rosetta Loy,
Roman Petri, Francesca Sanvitale,
Clara Sereni, Marisa Volpi
iacobellieditore
a Marisa, con nostalgia
Introduzione
Anna Maria Crispino a colloquio
con Maria Rosa Cutrufelli
Giornalista, grande viaggiatrice, autrice di romanzi, racconti, reportage, testi radiofonici e persino di un libro per bambini: Maria Rosa Cutrufelli ha sempre avuto il gusto di praticare tutti i generi che la scrittura mette a disposizione, di esplorarli dall’interno e magari di rovesciarli per trovare la forma e le parole giuste per dire quello che le sta a cuore. Ma anche di promuovere e valorizzare la scrittura di altre donne, organizzando eventi sin dagli anni Ottanta, quando il discorso sull’écriture feminine italiana muoveva ancora i suoi primi passi – basti ricordare, a mo’ di esempio, l’Almanacco di Firmato Donna Scritture, scrittrici (1988).
Non che non ci fossero le scrittrici, anzi. Il secondo Novecento ha visto una crescita costante della loro presenza sulla scena letteraria ed editoriale nazionale, ma spesso all’ombra del neutro maschile “scrittore”, per la supponenza dei critici, certo, ma forse anche per il timore delle stesse scrittrici di essere sospinte nel recinto della letteratura “sentimentale” – se non “rosa” tout-court – e di conseguenza collocate in serie B.
D’altronde però, già dagli anni Settanta la nuova ondata del femminismo aveva aperto la via per una rivalutazione delle “pioniere”, per una diversa attenzione alle contemporanee e persino per una maggiore “autorizzazione” all’espressione per le aspiranti scrittrici: è del 1975 la fondazione della casa editrice La Tartaruga di Laura Lepetit in un contesto di plurime iniziative editoriali “firmate” donna. Ma ancora la cittadella della critica letteraria, nei giornali e riviste autorevoli e nei dipartimenti di italianistica delle università, continuava a resistere strenuamente agli studi delle donne (Women’s Studies) che altrove, specie nel mondo anglofono, erano già una realtà diffusa e assai vitale.
È tuttavia proprio a partire dagli anni Settanta e Ottanta che emerge in Italia una nuova generazione di lettrici, oltre che di autrici, che si fa anche “pubblico” attento ed esigente di un’editoria che non può non tenerne conto: si prepara quel graduale “sorpasso” delle lettrici sui lettori – specie nel campo della narrativa – che nel tempo si è consolidata in tutte le fasce d’età e che oggi, secondo le statistiche, in un Paese che legge complessivamente poco (42% della popolazione dai 6 anni in su), vede una percentuale di donne (48,6%) molto maggiore rispetto a quella degli uomini (35%).
Inoltre, lo stesso femminismo italiano sembra cambiare pelle negli anni Ottanta: meno movimentista e più consapevole di dover trovare radici e fondamenta, una genealogia di riferimento, una efficace rete di relazioni, per evitare quell’andamento carsico – fatto di momenti di grande visibilità seguiti da lunghe fasi di inabissamento – che in Italia ma anche in tutta Europa ha contraddistinto la presenza delle donne sulla scena pubblica (politica, sociale e culturale) dalla Rivoluzione francese in poi. Sono gli anni in cui, come un’onda impetuosa, nascono (e a volte anche muoiono) case delle donne e consultori, collettivi più strutturati e associazioni, centri di documentazione e biblioteche, librerie e gruppi di lettura, studio e ricerca. E altre riviste, collane, piccole case editrici – alcune dalla vita effimera, altre ancora oggi in attività.
Nel 1990 Maria Rosa Cutrufelli porta a compimento un progetto a lungo maturato, la rivista Tuttestorie, che diventa presto un luogo d’elezione per il dibattito sulla scrittura delle donne, ma anche un forum di confronto tra donne e uomini in letteratura. Come ricorda oggi quell’esperienza?
Maria Rosa Cutrufelli - Le prime amiche che condivisero il mio progetto furono Marisa Rusconi, giornalista culturale de l’Espresso, e Rosaria Guacci, che lavorava alla casa editrice La Tartaruga con Laura Lepetit. Entrambe abitavano a Milano, perciò le riunioni di redazione si tenevano lì. Ogni volta prendevo il treno e andavo da loro, ospite di Marisa, che ci accoglieva tutte nel suo grande appartamento pieno di libri e di fiori, dove si discuteva fino a cadere sfinite. Poi si mangiava insieme: sembra un dettaglio insignificante, invece era un rito che cementava il nostro essere “gruppo”. Per le donne, il cibo non è mai un argomento di scarso rilievo: la cultura del cibo fonda la socialità umana e le donne sono al centro di questo nucleo originario di relazioni. La letteratura, d’altronde, è anche un po’ “la cucina delle streghe”, o almeno così si dice (non per niente un numero di Tuttestorie s’intitolava: “Bere, mangiare”). Purtroppo Marisa è morta troppo presto e non ha potuto seguire il cammino della rivista fino in fondo, ma la sua intelligenza ha continuato a nutrire Tuttestorie (e me) anche dopo.
All’inizio dunque eravamo un piccolo gruppo di lavoro, ma potevamo contare su una larga rete di scrittrici, intellettuali, giornaliste, studiose, interessate come noi al dibattito attorno alla scrittura e al posto che le donne occupano nel mondo letterario. In quegli anni, era una questione all’ordine del giorno: ricordo per esempio un Salone del libro di Torino (sotto la presidenza di Beniamino Placido) dedicato al tema.
Il nostro obiettivo era duplice. Da un lato, volevamo recuperare la memoria delle grandi scrittrici, dare spazio alle giovani, diffondere il lavoro che veniva fatto attorno alla produzione letteraria a firma femminile e produrre cambiamento introducendo nella cultura il “punto di vista” delle donne.
Dall’altro, volevamo coinvolgere gli uomini nel dibattito e “costringerli”, in un certo senso, a prendere posizione. Ci sembrava importante sentire la loro voce. Interrogarli. E farlo da un punto di forza: ossia da un luogo nient’affatto neutro, poiché venivano interpellati da una rivista diretta e prodotta da donne. Devo dire che ben pochi si sono sottratti al confronto: ci hanno regalato racconti, interviste, piccoli saggi. Sono stati generosi. Ma la loro partecipazione... Ecco, era sempre un po’ distratta. Esterna. Come se la cosa non li riguardasse davvero. E a tutt’oggi temo che sia ancora così: a noi la loro presenza interessa; la nostra, a loro, molto meno.
Era sicuramente un obiettivo troppo ambizioso per le nostre forze (e le nostre risorse) ma, quando si sogna, tanto vale sognare in grande!
A.M.C. - I testi delle 12 scrittrici che qui abbiamo raccolto rispondono, ciascuno a suo modo, alle domande e alle questioni che la rivista poneva: cosa spinge una donna a scrivere, come lo fa e perché. Una sorta di indagine comparata sul “laboratorio” che ciascuna deve allestire per sé in modo da potersi dedicare alla scrittura.
M.R.C. - Vorrei precisare che i dodici testi sono stati scritti per una rubrica specifica di Tuttestorie, che s’intitolava: “Scrivere”. La domanda alla base della rubrica era molto semplice: al giorno d’oggi, la famosa “stanza tutta per sé” rivendicata da Virginia Woolf è una realtà? O le donne scrivono ancora in cucina, come Jane Austen e tante altre dopo di lei? E basta avere quella benedetta “stanza tutta per sé” per sentirsi a proprio agio durante il lavoro della scrittura?
La domanda era questa, ma le autrici (per fortuna, aggiungo col senno di poi) sono andate molto oltre, come r...