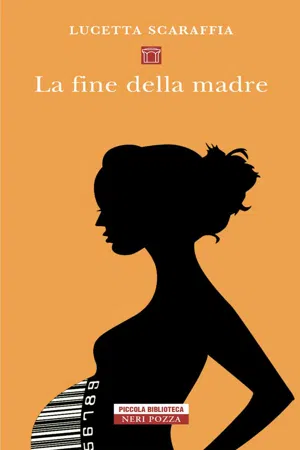
- 158 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La fine della madre
Informazioni su questo libro
Un nuovo diritto non previsto né codificato da alcuna legge si è prepotentemente affacciato, nel nostro tempo, sulla scena: il diritto al figlio.
Per molti è un semplice passo in avanti sul piano della libertà individuale, reso possibile dall'inarrestabile progresso delle tec-noscienze. Per l'autrice di queste pagine è il segno di una trasformazione antropologica di vasta portata in cui sono in questione i punti nevralgici della condizione umana, a cominciare dalla generazione.
Nulla più delle modificazioni linguistiche e giuridiche è in grado di mostrare la profondità di questa trasformazione. In molti paesi i termini stessi di «madre » e «padre» vengono cancellati; la frase «nato da...» viene sostituita da «figlio di..»; la «parentela» sparisce e si affermano nuovi termini sessualmente neutri, quali «genitorialità», «progetto genitoriale» ecc. Infine, una nuova formula giuridica, il contratto di affitto dell'utero, rende giuridicamente disponibile ciò che in tutte le legislazioni occidentali è sempre stato giudicato indisponibile: il corpo umano.
Il risultato è che la scena della generazione muta radicalmente. Comprende ora, oltre ai due genitori, i donatori o la donna che affitta l'utero, i medici addetti alle operazioni necessarie, le istituzioni che mediano i rapporti fra i cosiddetti «donatori» con gli aspiranti genitori; i legali, indispensabili per definire la «proprietà » del bambino e l'eventuale anonimato del donatore. Un teatro in cui scompare un'unica figura: la madre, quale detentrice unica, secondo Lucetta Scaraffia, di quella capacità di procreare che da sempre gli uomini hanno invidiato alle donne.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La fine della madre di Lucetta Scaraffia in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Studi di genere. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Studi di genereIl rispetto del corpo materno
Tante foto simili
È una foto che ha fatto il giro del mondo: a Baton Rouge, negli Stati Uniti, durante la manifestazione per protestare contro l’uccisione di alcuni giovani di colore da parte della polizia locale, una giovane donna nera, con un abito lungo, da sola riesce a fermare la carica di un plotone di poliziotti in assetto antisommossa. È una foto carica di tensione: la giovane è armata solo del suo coraggio, della sua determinazione, ma ciò basta per fermare la violenza. La prima domanda che ci si pone, guardando questa immagine così forte, è se la stessa cosa sarebbe accaduta se al posto della ragazza ci fosse stato un uomo, se pure coraggioso e disarmato quanto lei. La risposta che ci nasce immediata è no. Probabilmente i poliziotti l’avrebbero messo da parte, più o meno rudemente, e avrebbero proceduto nella carica. È questo infatti quello che è successo nel 1989 in piazza Tienanmen, dove un ignoto studente, da solo, ha cercato di fermare l’assalto.
Cosa spinge questi uomini preparati allo scontro ad abbassare le armi? La risposta a questa domanda è complessa, ma sicuramente si può sintetizzare in una frase: il rispetto per il corpo della donna, per il corpo materno. Per un corpo che rappresenta il futuro, rappresenta la possibilità di un nuovo inizio. Per un corpo carico di potenza simbolica, che rimanda ciascuno alla propria origine, cioè alla indispensabile relazione di ogni essere umano con un altro, la madre.
Di foto come queste ce n’è tante, e tutte molto simili.
La potenza materna impersonata dalle donne ha sempre generato reazioni di paura e di fragilità negli uomini, perché nascere e far nascere è sempre stato solo appannaggio delle donne, del loro corpo, capace di generare sempre nuovi inizi. È un movimento libero – Hannah Arendt proprio per questo associa la nascita alla libertà – e ha un carattere di inatteso, di sorpresa. È il senso del futuro, il dinamismo creatore della vita umana.
È uguale per tutti, ma è generato da un rapporto unico e personale fra due esseri umani, una madre e un figlio, un rapporto unico e insostituibile che arricchisce ogni vita di donna di un significato più ricco di mistero e di grandezza di quella di un uomo. Che il mistero e la grandezza li deve cercare e costruire, non li ha ricevuti in dono. Perciò, scrive Françoise Héritier1, in ogni società umana gli uomini hanno cercato di bilanciare questa potenza femminile tenendo le donne sotto il loro potere, controllandole, cercando di attribuirsi la proprietà dei figli.
La rivoluzione femminista iniziata nell’Ottocento, al di là di una veste semplicemente emancipazionista, conteneva in germe una grande possibilità: quella di portare i valori femminili nello spazio pubblico, di farli riconoscere validi per tutti per la loro importanza straordinaria e innovativa. Si tratta di valori come il dono gratuito di sé, del proprio corpo ma anche in molti casi della propria vita, per un altro essere umano, valori come la consapevolezza dell’importanza della relazione umana di cura e di affetto nella costruzione dei rapporti: una diversa gerarchia di priorità, che avrebbero potuto seriamente mettere in crisi la società concepita al maschile. Se questo non è successo, è perché l’ingresso delle donne negli spazi a loro preclusi è avvenuto con una modalità rigida e condivisa da tutti: quella di assimilarsi alla cultura maschile, e soprattutto di dimenticare la dimensione della maternità. Ma evidentemente non bastava. Appena si è aperta una possibilità di sminuire se non cancellare la madre – anche a opera di scelte sbagliate delle donne stesse – il processo si è messo in moto. L’utero in affitto, il dono degli ovociti e presto, probabilmente, l’utero artificiale, stanno trasformando la straordinaria esperienza di generazione materna in un processo a tappe controllabili e replicabili, un meccanismo che, attraverso alcuni accorgimenti scientifici, può essere tenuto sotto controllo dagli uomini, per la prima volta nella storia umana.
Anche se oggi, a una prima apparenza, in questo momento di crisi dei tradizionali ruoli sessuali – non può scomparire l’uno senza che anche l’altro, formatosi nella complementarietà, non vada in pezzi – sembrano trionfare valori femminili come dolcezza, benevolenza, tenerezza rispetto a quelli tradizionalmente attribuiti al genere maschile, il vero bersaglio della trasformazione, quello che sta scomparendo attaccato da ogni parte, è il ruolo materno.
L’aborto
A privare di valore la maternità purtroppo hanno dato un notevole contributo le donne stesse, e in particolare il femminismo degli anni Settanta che, concentrandosi sul corpo e sulla sessualità femminile, ha finito per concentrarsi su un programma unico: liberare la donna dalla schiavitù della procreazione per costruire così, anche nel privato e nei rapporti fra esseri umani, una totale uguaglianza con gli uomini. Per garantire alle donne la possibilità di vivere una sessualità totalmente libera e quindi priva del timore della procreazione, non bastava infatti l’apertura agli anticoncezionali. Qualsiasi metodo di controllo può fallire, quindi deve essere libero e accessibile anche quello che dovrebbe essere considerato l’estremo rimedio, cioè l’aborto.
Che l’aborto – delitto punito dallo stato solo dopo la Rivoluzione francese, cioè quando la coscrizione universale rese prezioso ogni essere umano – dovesse tornare a essere depenalizzato, senza dubbio era giusto: è un tale dolore, fisico e psichico, per le donne che non ha senso infierire ancora su di loro. Ma è assurdo e gravemente sbagliato farne un diritto, e per di più farne il diritto che certifica e conferma la libertà delle donne. Un movimento politico e culturale così importante e così radicale quale è stato il femminismo ha commesso un errore fatale nel pensare di legare il suo trionfo alla liberalizzazione dell’aborto, cioè alla cancellazione di fatto della maternità. Come si può fondare qualcosa di vivo sulla morte? Come si può pensare che, sul lungo periodo, le donne avrebbero vinto una battaglia di giusto riconoscimento negando la propria specificità, cioè la maternità? Vincere a quelle condizioni è stato terribile, ha costituito una zavorra simbolica che ha intossicato il femminismo il quale, infatti, come movimento vivo e creativo, non è sopravvissuto che pochi anni a questa triste vittoria.
Il fatto poi che la decisione dell’aborto venisse lasciata sempre e solo alla madre, ha avuto anch’esso gravi conseguenze. Ha fatto sì che da una parte fosse accentuata la solitudine femminile al momento della scelta e dell’intervento abortivo, e che dall’altra si infrangesse il difficile equilibrio di coppia creatosi intorno al destino di un figlio. Negare valore alla maternità ha avuto come effetto collaterale anche quello di cancellare il già labile istituto della paternità.
Quando non c’era un nome importante da tramandare, un patrimonio da trasmettere, la paternità si riduceva spesso a povera cosa, non di rado a un esercizio di autoritarismo che generava nei figli ribellione e fuga. Ma togliere ogni responsabilità alla parola del padre rispetto al diritto di venire al mondo di un figlio significa creare un abisso fra uomini e donne. Un abisso provocato dalla richiesta, da parte delle donne, di assegnare a loro ogni potere sulla procreazione, senza pensare che spezzare equilibri antichi avrebbe avuto dei costi pesanti, avrebbe costituito un serio pericolo per la società nel suo complesso.
Le reazioni maschili sono state molte, dalla sempre più frequente fuga dei padri dal loro ruolo per arrivare ai femminicidi. Tugdual Derville, fondatore di una associazione attiva in Francia che affianca le donne che hanno abortito, così descrive il problema: sostiene che alla solitudine delle donne si accompagna la solitudine degli uomini perché l’aborto è un “luogo” che infrange l’alleanza e la complementarità: «L’aborto riunisce i due mali della società occidentale: la solitudine delle madri e lo smarrimento dei padri»2.
Con la battaglia dell’aborto il movimento di liberazione voleva liberare la donna in ogni madre ma, mettendo ogni decisione nelle sue mani, l’ha anche liberata dal rapporto con l’uomo, condannandola alla solitudine.
Certo, all’inizio il programma non era questo: la rivalutazione del corpo femminile aveva significato anche una rivalutazione della maternità nei suoi aspetti più concreti, come il parto e l’allattamento. Non a caso, nel 1975, proprio mentre si susseguivano le manifestazioni a favore della legalizzazione dell’aborto, era uscito negli Stati Uniti, e prontamente tradotto in Italia, il libro di Adrienne Rich, poetessa e femminista, che metteva al centro l’esperienza materna e soprattutto il momento del parto, che si domandava cosa avesse significato per gli uomini il fatto che «l’unica esperienza unificatrice, incontrovertibile, condivisa da tutti, uomini e donne, è il periodo trascorso a formarci nel grembo di una donna. Per tutta la vita e persino nella morte conserviamo l’impronta di quella esperienza»3.
In quegli stessi anni si assisteva a una denuncia da parte delle donne dell’espropriazione del momento del parto realizzata dai medici, che si erano totalmente sostituiti alle ostetriche, rompendo una rete tradizionale di rapporti e di complicità femminili, e soprattutto medicalizzando un evento naturale anche quando non era necessario.
Un medico francese, Fréderick Léboyer, scrisse un libro, Per una nascita senza violenza4, che conobbe uno straordinario successo proprio perché si batteva a favore di un parto più umano, che evitasse l’illuminazione violenta e l’ambiente rumoroso che accoglieva il nuovo nato negli ospedali. Il bambino doveva essere accolto con delicatezza, e immediatamente accostato al seno della madre. Leboyer, in un linguaggio semplice, metteva a disposizione di tutti una riflessione elaborata a contatto con la cultura indiana e in sintonia con le proteste delle femministe.
Parallelamente a questo momento di riflessione sul parto, si sviluppava all’interno del movimento una corrente di pensiero – definita “della differenza” – volta a contrapporre alla tendenza prevalente nel processo di emancipazione, cioè quella all’omologazione con il modello maschile, una riscoperta della specificità femminile legata alla maternità. In Italia la teorica più importante di questa corrente femminista, la filosofa Luisa Muraro, autrice di un libro fondamentale, L’ordine simbolico della madre (1991), scriveva nella post-fazione alla seconda edizione del 2006 che in sostanza il femminismo della differenza si era battuto per salvare «il privilegio della vicinanza delle donne con il corpo materno», cioè per indicare una strada che potesse «rendere possibile qualcosa della potenza materna»5. Lungi dal mortificare il valore dell’esperienza materna, Muraro partiva infatti dal presupposto che «la madre è, universalmente, il nome della relazione che è condizione della vita umana»6.
Ma le priorità dei movimenti erano diverse, e centrate sul rifiuto della maternità, come ricorda una recente ricostruzione della storia del parto e del generare di Nadia Filippini che, in un capitolo dedicato alla liberalizzazione dell’aborto e della propaganda anticoncezionale, proclama: «Si tratta di leggi importanti, che segnano una tappa cruciale nella storia delle donne, una specie di habeas corpus che fonda la cittadinanza femminile sul principio di autodeterminazione del proprio corpo»7.
Di fatto, il femminismo che è divenuto opinione comune fonda la libertà delle donne sull’aborto, cioè sulla negazione del valore della maternità. Le conseguenze si vedono nel tempo lungo: non solo nella grande difficoltà che incontrano le giovani donne di oggi ad avere un figlio, ma anche nelle difficoltà teoriche in cui si dibatte oggi il femminismo di fronte a una evidente esperienza di sfruttamento come è quella dell’affitto dell’utero. Il diritto di aborto, cioè la libertà di disporre anche in negativo del proprio corpo proclamata come unico fondamento della libertà della donna, è arrivato infatti a indurre anche teoriche del pensiero della differenza, studiose della maternità come la femminista francese Antoinette Fouque, a giustificare la gravidanza per conto terzi.
Fouque, in una lunga intervista rilasciata alla rivista «le débat» nel 2009, sostiene che l’utero in affitto è una tappa fondamentale di liberazione della donna, dopo quella dell’aborto, cioè una tappa nel percorso di autodeterminazione. Pur partendo dall’affermazione che la procreazione costituisce il punto inespugnabile della differenza fra i sessi, a suo avviso la gestazione surrogata è l’ultima tappa di quel processo di liberazione iniziato con l’aborto perché permette di non chiudere la procreazione nella maternità, né di chiudere la donna nella madre. Per Fouque, la gravidanza per altri costituirebbe altresì un baluardo contro l’utero artificiale: quelli nati in questo modo – scrive – saranno forse «gli ultimi figli di carne e sangue prima dell’utero artificiale»8.
Da un altro punto di vista, invece, una femminista italiana come la sociologa Daniela Danna, che si dichiara – se pure con qualche ambivalenza – contraria all’affitto dell’utero, fonda parte del suo argomentare proprio sul fatto che i contratti con i committenti privano la gravida della libertà di decidere l’aborto, che può solo essere deciso insindacabilmente da loro, i “proprietari” del feto. Lo slogan fondamentale «il corpo è mio e lo gestisco io», che potrebbe ai suoi occhi funzionare per giustificare l’affitto dell’utero, entra però in contraddizione con gli ostacoli posti alla libertà di decidere sull’aborto, a suo tempo il caposaldo della rivolta femminista.
Danna si rende conto poi che i medesimi contratti propongono una condizione ancora più insidiosa nei confronti della libertà di aborto, quella per i committenti di essere riconosciuti genitore prima della nascita: «Per il diritto vigente essere riconosciuti come genitore prima della nascita di un essere umano è un’aberrazione, perché fino alla nascita un essere umano è solo una potenzialità di persona che, rimanendo all’interno del corpo di un’altra, non può essere ancora “figlio” di nessuno!»9 Cogliendo perfettamente il problema: in questa clausola infatti il diritto d’aborto è messo in discussione dal riconoscimento effettivo che nel ventre della gravida c’è già un essere umano, del quale si può stabilire la genitorialità, e non un “progetto di vita”.
Muraro, nel suo L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto, invece non cavalca la questione dell’aborto, anche se le sue argomentazioni si muovono in un’ottica strettamente femminista. «Qui non si tratta di proibire, si tratta di non sbagliare»10 afferma la filosofa, la quale vede in questa pratica ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Trama
- Autore
- Collana
- Frontespizio
- Colophon
- Prefazione
- Due padri
- Donne in vendita
- Il rispetto del corpo materno
- Catalogo Neri Pozza Editore