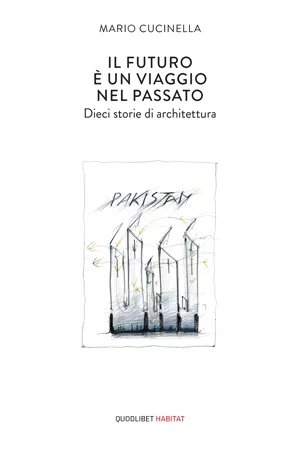1.
Il giardino che non c’era
Garnish, il giardino subtropicale sull’isola Ilnacullin in Irlanda (51° N, 9° O)
Il giardino che non c’era è la storia di un generale appassionato di piante tropicali e del suo amico giardiniere.
Si arriva a Garnish con un piccolo battello dal villaggio di Glengarriff, nella baia di Bantry nella contea di Cork. Ci sono arrivato dalla penisola di Dingle, attraversando la baia di Ballyheige dove si trova una spiaggia lunga diversi chilometri chiamata Banna Beach. Sono stato in quella spiaggia con il mio blowkart, un triciclo a vela che nelle giornate di vento atlantico spazza qui i luoghi senza tenerezza. Puoi volare a sessanta chilometri all’ora a pochi centimetri dalla sabbia e dal mare. Puoi sentire che il vento, alternando raffiche e calma, può spazzarti via in un istante, e sentire il sale del mare che viaggia con esso e che arriva da lontano. Un viaggio di migliaia di miglia marine. (Corrente del Golfo.)
Il battello lascia il piccolo porticciolo e passa a fianco ad alcune brulle isolette per poi approdare davanti all’isola contornata da conifere giganti. Ma la storia è di straordinaria bellezza ed empatia, nata dal desiderio di John Annan Bryce, ammiraglio delle forze navali britanniche e collezionista di piante tropicali (le raccoglieva nei suoi viaggi), e del suo amico Harold Peto, architetto paesaggista. I britannici, ai quei tempi, i primi del Novecento, occupavano l’Irlanda (giusto per dovere di cronaca) e conquistavano terre lontane.
Alcuni anni fa chiesi a un professore irlandese, prof. John Olley, di raccontarmi i dettagli di questa storia meravigliosa, e ho potuto così incontrare per la prima volta quello che considero un bellissimo racconto di rigenerazione territoriale:
Oggi quella che un tempo era un’isola brulla e spazzata dal vento – Ilnacullin, nel sud-est dell’Irlanda – è un lussureggiante giardino subtropicale. A partire dalla prima metà del XX secolo, la sua evoluzione secondo il progetto di Harold Peto, architetto e paesaggista, ha creato la capacità di riparare l’isola dal vento atlantico, preservandone però l’umidità e creando così un nuovo equilibrio ambientale attraverso un microclima in grado di far crescere una varietà prodigiosa di piante di origine esotica, la cui vitalità e le cui dimensioni sarebbero inconsuete nella loro stessa regione di origine.
Per prima cosa fu piantato un anello di cespugli a crescita rapida, resistenti alla salsedine e al vento, a proteggere il perimetro dell’isola. I cespugli, proteggendo dal forte vento le piccole piante di conifere, hanno permesso loro di crescere e di essere sufficientemente forti per resistere ai venti modificando la direzione del vento e delle piogge battenti. Così nel giro di alcuni anni, almeno dieci, Peto è riuscito a creare una nuova condizione per poter piantare le prime collezioni di piante tropicali. In quella costa, il vento della Corrente del Golfo porta a miti temperature, tanto da permettere alle piante di ritrovare il loro ambiente naturale.
Si selezionarono poi delle specie capaci di adattarsi facilmente alla modificazione climatica ottenuta in principio.
Mentre queste piante crescevano, alterando la configurazione del riparo e dell’equilibrio energetico e idrico, il suolo veniva preparato per un altro gruppo di piante, più esotiche e delicate. Il microclima si è evoluto progressivamente: il sito diventava un punto di partenza sempre più favorevole per la generazione successiva di vita vegetale.
Mentre le piante crescevano, il rigoglio e la decadenza della vegetazione cominciò a produrre humus, arricchendo il suolo e creando un equilibrio idrico ideale e un potenziale di conservazione peculiare, il tutto protetto e stabilizzato dalla stessa crescita della vegetazione che ne era all’origine.
I problemi iniziali della mancanza di suolo fertile e di fonti idriche naturali hanno finito per recedere.
In una prima fase, l’architetto e designer di giardini Harold Peto realizzò un progetto per una casa e per il giardino. A dare al giardino la sua struttura doveva provvedere la creazione di viali e di assi accentuati e segnati da spazi architettonici e da costruzioni di ispirazione italianeggiante.
La coerenza del progetto originario fu frammentata e sopraffatta dalla vegetazione in evoluzione, che dava vita a una propria struttura. L’originario schema di giardino all’italiana fallì. Le condizioni di partenza dell’isola non potevano consentire la sua attuazione; occorreva per forza evolversi.
Il giardino subtropicale si è sviluppato ed evoluto in un processo continuo di risposta informata alle condizioni e alle opportunità del momento. Per ogni nuova pianta il giardiniere trovava la migliore collocazione possibile, in modo da arrecare beneficio alla pianta senza per questo diminuire l’accesso alla luce e all’acqua della sua vicina.
Gli spruzzi di acqua salata e i venti furono placati e, attraverso il succedersi dei piantamenti e la crescita delle singole specie, è emerso un luogo di delizia olfattiva, uditiva e visiva. Ogni aggiunta ha contribuito a creare qualcosa di nuovo, ma ha richiesto il contributo dell’esistente.
Questo processo, per il fatto di svolgersi nel tempo, è l’antitesi del progetto originario: un processo evolutivo, in quanto ogni singola parte è stata aggiunta per rendere possibile una complessità sempre crescente e uno straordinario risultato d’insieme.
Nel 1734 Lady Anne Conolly scrive al padre dall’Irlanda a proposito della sua nuova residenza, Castletown: «il bosco è a una certa distanza dalla casa, e non la ripara, dal momento che è assai rado». Alla fine dello stesso secolo Emily, duchessa di Leinster, sorella e vicina di Louisa Conolly, scrive che la foresta di Castletown «vale un patrimonio per la gente che ci vive in inverno, a parte la sua bellezza in estate, perché è delizioso fare una passeggiata o una cavalcata tanto incantevole in un luogo riparato dai venti e su un terreno asciutto». L’area boscosa crebbe, contribuendo al comfort all’interno della casa e nelle sue vicinanze. Il terreno circostante divenne un’estensione della casa - un luogo esteticamente piacevole da abitare. Il bosco aveva creato un microclima caratteristico e la sua influenza si estendeva oltre i suoi confini. Il biologo Richard C. Lewontin suggerisce che «dobbiamo sostituire la concezione adattativa della vita con una concezione costruzionista. Non è che gli organismi, una volta trovato un ambiente, debbano scegliere tra adattamento e morte. In realtà essi costruiscono il loro ambiente». L’ambiente in cui costruiamo è esso stesso costruito. Progettare e costruire soltanto in risposta alle condizioni esistenti significa rinunciare a un’opportunità. Una sensibilità verso l’ambiente che aderisca alla formula «tocca la terra con leggerezza» finisce con il deludere. L’atto del costruire cambia le proprietà del sito, la sua capacità di riparare, di riflettere la luce e la sua massa termica e perciò, nello stesso momento in cui trasforma le condizioni esperite dai siti e dagli edifici circonvicini, altera le condizioni che l’edificio stesso sperimenterà.
L’architettura tradizionale implicava in genere una conoscenza intima della sua collocazione e del suo potenziale in termini di sostenibilità. A ciascun edificio, e a un intero insediamento, corrispondeva un paesaggio. Le abitazioni erano fatte una per una dalla terra su cui sorgevano e la loro pianta e forma erano configurate nel modo più favorevole. Oggi le abitazioni tradizionali, adattate al clima, alla cultura e al contesto, vengono via via soppiantate da abitazioni informate da mode d’importazione e da una conoscenza astratta, insensibili alla sottile sapienza che si ottiene attraverso un’esperienza profonda della natura del microclima locale e delle sue potenzialità in termini di adattamento e manipolazione. Oggi per ogni edificio ci sono altri paesaggi, quelli che si estendono oltre il sito in cui sorge. Un edificio ha un’«impronta» più estesa della sua pianta, un’impronta che lo collega ad altri luoghi. Il costruire fa sì che si consumino materiali e risorse energetiche. Anche abitare un edificio significa consumare risorse e produrre rifiuti da smaltire. La «biografia» dei materiali e dell’energia usata è importante. Quanta energia è stata consumata nell’estrazione dei materiali, nella loro lavorazione ed elaborazione, nel loro trasporto e assemblaggio nell’edificio finale? La longevità dei materiali e la loro capacità di contribuire a far sì che un edificio in uso abbia un impatto ambientale moderato diventano elementi significativi. Come si possono scrivere i vari capitoli della biografia di un materiale in modo da contribuire alla sostenibilità? C’è un modo per far sì che la produzione di materiali diventi un punto di forza e rechi vantaggio all’ambiente e alle sue risorse piuttosto che consumarlo? Nel xviii secolo il bosco di Castletown provvedeva amenità e riparo, ma avrebbe potuto essere una fonte di materiali e di energia. Se gestito, avrebbe potuto costituire una fonte rinnovabile di legname da costruzione e di combustibile per la produzione di calce. All’interno di una visione complessiva del paesaggio del Demesne avrebbe potuto essere parte integrante dell’estetica del progetto e un punto di forza dal punto di vista funzionale. Si può progettare un paesaggio per realizzare un luogo in cui abitare: alterare il suo microclima, creare condizioni amene e fornire fonti materiali rinnovabili per la costruzione e il processo di occupazione del territorio. Le cave rappresentano una fonte essenziale di pietra da costruzione, pietrisco e calcare per la produzione di calce e derivati. Si tratta di un’attività di forte impatto ambientale, e come tale è diventata controversa.
Qualsiasi richiesta di permesso di sfruttare una cava esige che si proponga un piano di recupero a conclusione dei lavori. Questo piano di rado è concepito come un tutt’uno con il processo di estrazione.
Con il grado di evoluzione raggiunto dalle attuali tecniche di brillamento è possibile scolpire il terreno della cava in modo da produrre un valore aggiunto: la topografia finale può, attraverso il suo aspetto, l’inclinazione e la capacità di riparare, creare un microclima unico e benefico, un luogo adatto a ospitare colture, attività ricreative o edifici. Il processo di estrazione diviene il preliminare ingegneristico necessario a creare in loco qualità speciali. Quanto spesso si modellava il terreno in passato? I fianchi delle colline venivano terrazzati per poter essere coltivati. Per creare le cavee dei grandi teatri dell’antica Grecia si modificava la topografia. A Dublino, nel XVI secolo, si scavò il letto del fiume Dodder, un affluente del Liffey, per estrarre il granito impiegato nella ricostruzione della cattedrale di Christchurch.
La cava divenne parte del processo di regimazione dell’acqua e dello sfruttamento del fiume come fonte di energia per i mulini. Il parco parigino di Buttes-Chaumont, progettato da Alphand nel 1866, fu realizzato sfruttando il paesaggio drammatico e pittoresco delle miniere di gesso. Più di recente una cava di caolino in disuso in Cornovaglia è diventata sede dell’Eden Project. In questo caso, però, il sito è stato più un punto debole che un punto di forza. Il suo uso fu più un gesto polemico di risanamento ambientale che uno sfruttamento delle potenzialità peculiari della topografia della zona circostante per la creazione di speciali microclimi adatti alla coltivazione di piante provenienti da ogni parte del globo. Per questioni di sicurezza, una cava in produzione deve prevedere un’area cuscinetto tra la zona delle operazioni e il paesaggio circostante. Questo cordone, in assenza di interventi, diviene ricco di flora e di fauna. Non subisce l’attacco dell’agricoltura intensiva, con le sue monocolture e l’uso incessante di prodotti chimici. Le facce della cava variano nell’orientazione, offrendo un ricco insieme di microclimi che divengono nicchie ecologiche sfruttate dalla natura. La trasformazione del processo di estrazione dei materiali in un’attività positiva e benefica, capace di creare valore aggiunto, richiede un certo atteggiamento nei confronti del paesaggio, concepito come un processo nel quale il tempo è parametro essenziale. Qualsiasi progetto costruttivo ridisegna il paesaggio.
Il suo inserimento in un contesto rurale o urbano può contribuire alla sostenibilità dei siti adiacenti nonché influenzare quelli, più lontani, da cui ha attinto risorse per soddisfare le sue esigenze materiali ed energetiche. L’approccio alla progettazione sostenibile dovrebbe comportare non una sorta di simpatia sottomessa rispetto alle condizioni esistenti, ma un’empatia creativa con i sistemi naturali. Ma come può chi progetta prepararsi a questo compito? La formazione universitaria in generale ha favorito un sapere astratto rispetto a una conoscenza fondata sull’esperienza. L’attuale formazione dell’architetto è dominata dalla preoccupazione per la forma. La forma è dominante nel linguaggio del dibattito e della critica e nel modo in cui la stampa presenta l’architettura. Un altro termine salta all’occhio in questo contesto: «estetica».
L’Oxford English Dictionary dà due definizioni di «estetica»: 1. La scienza delle condizioni della percezione sensoriale; 2. La filosofia del gusto o della percezione del bello. Nel corso del XIX secolo il significato di questa parola è passato gradualmente dalla prima alla seconda definizione. L’esperienza condotta attraverso i sensi è stata svalutata a favore di criteri cerebrali ed elitisti di discussione e valutazione dell’arte, dell’architettura e del design. Buona parte della storia dell’architettura e della storia del design è scritta dal punto di vista della seconda definizione.
Nell’introduzione al suo libro Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization (W.W. Norton & Company, New York-London 1994) Richard Sennett traccia le ragioni della sua ricerca: «Sono stato spinto a scrivere questo saggio dal mio turbamento di fronte a ...