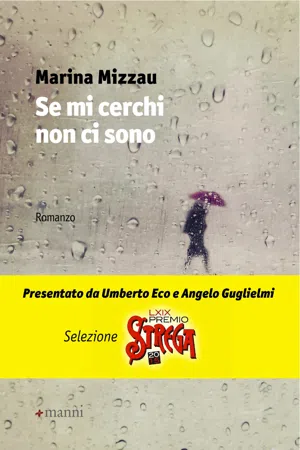![]()
CAPITOLO VENTISETTESIMO
Sguardi e racconti
Si è fatta l’ora del ristorante e siamo un po’ imbarazzati nel muoverci, non sapendo che fare con Simone. Ma lui non lo è. Si avvicina con la nuova venuta: vi presento una mia amica.
«Sono Claudia», dice lei pronta, e lui finalmente sa il suo nome.
«Può venire a cena con noi» dice Daria con un sorriso a Simone.
«No, Daria per piacere» le sussurra Antonia. Poi rivolta a Simone «Mi fai pena.»
Simone fa una leggera risata, mentre Claudia con discrezione si allontana di qualche passo. «Ma guarda» dice lui a Antonia con lo stesso tono di voce basso, «adesso ti metti a sindacare sulle mie scelte? Non avevi detto che non volevi più avere a che fare con me?»
«Le tue scelte, ti prego, come se non ti buttassi addosso alla prima… che incontri» ribatte Antonia censurandosi.
«Come te vero? Anche tu non sapevi con chi occupare il tuo tempo, magari anche il tuo…, quando hai cercato me» rimpalla Simone che ha finito per alzare la voce.
«Vi sembra questo il momento di spiattellare i fatti vostri?» dice Marta.
«Perché, non sono stati anche fatti tuoi?» ribalta Antonia con sarcasmo.
«Non lo sapevo mamma» commenta stupito e ironico Lorenzo.
«Basta», dice Maria Teresa, «andiamo se no non troviamo più posto al ristorante.»
PER MICHELANGELO
Direttamente abbiamo raramente parlato di noi, di te, di me. Lo abbiamo fatto quasi solo attraverso i libri, la letteratura, le teorie del linguaggio, tutto quello che riempiva le nostre letture e i nostri studi. Non ho mai avvertito e temuto quelle tensioni, possibili, anzi quasi certe, in un rapporto docenteallievo, che tra l’altro per età equivaleva a quello padre-figlio.
Al tuo primo anno di università ti ho conosciuto attraverso un tuo paper su Roland Barthes. Ricordo che citavi un brano, Les lunettes noires, che io amavo molto. Bisogna che si veda il nascondere; sappiate che sto nascondendovi qualcosa. È il paradosso che Barthes affronta nel decidere tra il fare vedere la passione – la sofferenza della passione – e il nasconderla, paradosso che viene risolto con l’esibizione di occhiali neri che nascondono i segni del pianto.
In questi giorni rileggendo un brano di Tolstoj ho raccolto un’altra strategia, che fa parte delle mosse insidiose e sottili con cui chi parla costruisce trappole comunicative per confondere e trarre in inganno. Lo riporto, ma forse lo conosci, anche se – ne abbiamo discusso molto – tu preferivi Dostoevskij a Tolstoj, e io il contrario (Dostoevskij scava più nel profondo, dicevi tu, Tolstoj è ineguagliabile nel fare emergere i conflitti dalla superficie, nei gesti e nella conversazione sostenevo io). È tratto da La morte di Ivan Il’ič e riguarda uno scambio tra moglie e marito, i cui rapporti sono di conflittualità e insofferenza reciproca:
“Non ti opporre, fa’ il piacere. È per me” soggiunse ironicamente, facendogli intendere che tutto quanto faceva lo faceva per lui, e questo solo fatto gli toglieva il diritto di rifiutarsi. Egli tacque e si rabbuiò. Sentiva che la menzogna intorno a lui s’era talmente imbrogliata che era ormai difficile capirci qualcosa. Ella faceva tutto per sé medesima, infatti, ma gli diceva di fare per sé medesima ciò che davvero per sé medesima faceva con un tono come se si trattasse di cosa inverosimile, sicché lui dovesse capire tutto il contrario.
Su queste trappole del linguaggio, sul rapporto tra coprire e fare apparire, tra mentire e dire il vero, su altre mosse ambigue della comunicazione, si è costruito parte del nostro lavoro comune e anche la nostra intesa. Tu sei diventato esperto dell’arte dei sottintesi, nell’aggirare la verità, nel dire non dicendo. Come lo collochiamo il tacere di qualcosa che, dovrebbe – ci si aspetta che – sia detto?
Tu mi hai nascosto, diciamo taciuto, una cosa importante, non credo di averti mai detto di conoscerla, forse lo hai immaginato. O forse pensavi che non toccasse a te dirmela. Comunque adesso lo sai. Sai che lo so. Se non lo sai quando leggerai queste righe lo saprai.
Perché non te l’ho detto prima? Perché anche ora non sono più esplicito? Forse avevo, ho paura delle parole. Di parole troppo forti, parole da teleromanzi, di cui abbiamo riso spesso assieme, parole che non hanno limiti e pudori nel dire: ebbene sì, sei tu… Le tue, le nostre parole a volte volano basso, così che non si fanno quasi sentire, per discrezione, per schivare le emozioni, per non sfiorare il conflitto, per non mettersi a rischio.
Non me ne ero mai interessato molto di chi fosse il padre di Alessandra, però il venire a saperlo – Elisabetta me l’ha detto, molto tempo dopo, solo quando ci siamo sposati – mi ha dato un più di felicità.
A tavola Antonia si è collocata alla maggiore distanza da Simone e la sua amica, in modo da non potere incontrare i loro sguardi. I due si scambiano qualche parola all’orecchio e ridono; Claudia spande sorrisi in direzione delle donne presenti e si adopera a compiere piccoli gesti di cortesia, come versare il vino e offrire la saliera quando qualcuna sembra averne bisogno. Il più imbarazzato sembra il giovane Lorenzo, che non solleva quasi mai lo sguardo dal piatto.
Elisabetta fa un gioco. Lo faccio anch’io seguendo il suo pensiero, in sincronia con il suo sguardo. Che lei fa scorrere sui compagni di tavola con gli occhi leggermente socchiusi, come se cercasse nei volti e nei gesti dei suoi commensali qualcosa che le ricorda qualcuno, come se volesse catturare le tracce di Leonardo su chi gli era stato vicino. Fissa Marta e le appaiono di suo fratello le sopracciglia aggrondate come nel concentrarsi su un’idea, nell’altra sorella il mordersi il labbro superiore per una perplessità e in Antonia il sorriso con cui lei e Leonardo a volte creavano un’intesa di cui allora Elisabetta si sentiva gelosa. Vede in Michelangelo l’espressione tra distaccata e divertita con cui guarda il mondo, che il ragazzo ha adottato da lui e che lo ha formato nel pensare, vede in Alessandra il viso intento con cui lei guardava Leonardo e lo amava, e la serenità con cui si sentiva amata, vede nel ritrarsi di Lorenzo il ritegno inculcato dallo zio quando lo aveva reso consapevole del suo diventare adulto. Guarda di nuovo Michelangelo e Alessandra e accosta i loro volti. I suoi occhi si posano per un attimo su Simone e si allontanano.
Elisabetta guarda questi volti e le sembra che Leonardo sia con loro e vorrebbe domandargli: hai avuto paura della morte, e anche avevi paura della vita e chiedergli se l’ha amata davvero, e dirgli che lei lo ha amato dal primo giorno che l’ha visto, invece gli racconta che Alessandra ha voluto la cioccolata prima del pranzo, e della confusione del prete al funerale e che alcuni hanno pianto, tua sorella e, riesci a pensarci?, Simone, e anche gli racconta che avevano seguito la bara che non era la sua e ridono insieme, e di quei due che volevano gli spaghetti a un bar, e gli chiede cosa dovrà dire a Alessandra che vuole sapere perché è morto e dove è adesso, e se pensa a lei. Gli dice ti porterò dei fiori, ma non so di che colore ti piacciono, perché non te l’ho mai chiesto? E che Daria ha lasciato un orecchino a lei e uno a Antonia, e forse meglio che li tenga tutti e due una di loro, magari regalerà il suo a Antonia, e Daria si è fatta una grappa, gli dice, e Alex era scomparsa dal bar e l’abbiamo ritrovata in compagnia di un ragazzino cameriere mentre cercava di consolarlo con le patatine fritte, e con noi adesso c’è una signora sconosciuta che Simone ha rimorchiato, credo proprio al cimitero, e questo fa imbufalire Antonia, come sempre quando Simone…
Siamo alle ordinazioni. Il cameriere che ha l’aria di sapere quello che i clienti desiderano propone: «Come inizio, prosciutto e melone?»
Supponente e sarcastico Simone contropropone: «Perché non melone e gorgonzola, melone e salsiccia, prosciutto e uva passa?» Diventa direttamente polemico. «Prosciutto e melone? Cosa pensa, che siamo tutti turisti tedeschi o giapponesi?»
«Allora prosciutto con fichi?» propone impassibile il cameriere, aggiungendo poi con un calcolato sorriso di scuse: «Mi dispiace, i fichi non li abbiamo».
«Mi prende in giro?»
«Andiamo Simone» dice Daria.
«Ma perché fai così?» si affligge Elisabetta.
«Per favore», dice Marta irritata.
Alessandra dice «Prosciutto e melone tra virgolette.» Ecco, ha imparato, penso io.
Il cameriere sorvola. «Parliamo del primo. Maccheroncini all’amatriciana, crespelle della casa, strudel di verdure» scandisce con didascalica lentezza, sempre sorridendo. «Cos’altro c’è» chiede Beppe che non aveva sentito elencare qualcosa che assomigliasse di più a lasagne o tagliatelle al ragù.
«Due tagliatelline, senz’altro. O tortellini in brodo, o…»
«Non mi piace il brodo» taglia corto Alessandra.
Avrei potuto dire, alla sua età, non mi piace il brodo? Scontata l’accettazione di ciò che la tavola proponeva, non sapevo se mi piacesse o no. Credo che non mi ponessi il problema. Lo dico a Alessandra. Dico mi piaceva il brodo, da bambina. Mi piaceva tutto. «A me no» taglia corto Alessandra, indifferente ai confronti virtuosi.
Risotto al radicchio. Spaghetti al pesto, continua a declamare il cameriere. A ogni voce Alessandra segna come delle croci col dito sulla tovaglia: cancella.
«Non mi piace il risotto» dice. «Neanche il pesso.»
«Il pesto, si chiama. Ho capito, per lei niente primo, cotoletta alla milanese.»
«Con patate fritte» aggiunge Alessandra, «tra virgolette.»
«Oh, basta con queste virgolette» scatta Elettra. «Qui non c’entrano.»
«Con patate fritte», conferma rassegnata la madre.
«Anch’io milanese. Con pomodori gratté» dice Franca.
«Gratté? Ma non si dice pomodori gratté», la redarguisce Lorenzo, «È francese, pomodori al gratin.» In Italia si dice gratté perché si pensa al pane grattato, commenta con tono di sufficienza Elettra.
«Perché non dirlo in italiano, gratinati» polemizza Valentina.
«No, si dice foie gras, non diresti fegato grasso.»
«Perché no? Non si può dire pollo al vino invece che coq au vin?»
«Io credo che uno possa dire come vuole» concilia Beppe, ottenendo un gesto di consenso di sua moglie Leona, e anche di Daria.
Mi piacevano le patate fritte? Di quelle sì, un vago ricordo, mia madre non le faceva a cubetti, erano a fettine, spesse, non sottili come le chips.
Marta dice che a casa loro la domenica si mangiava il pollo, solo la domenica, ed era una gran festa.
A Daria piacerebbero i vincisgrassi. Il cameriere non sa neanche cosa sono.
Marta spiega: I vincisgrassi sono un piatto tipico delle Marche o Umbria. Condito con ragù e con l’aggiunta di besciamella, rigaglie di pollo ed eventualmente anche animelle, midollo, cervella bovine o tartufo. Marsala o vino cotto. «Piatto dietetico» ironizza Maria Teresa. «Infatti quelli che li facevano non ci sono più, sono tutti morti» conclude Simone.
Passiamo allora al secondo. Simone legge il menu per gli altri. Filetto al pepe nero pressato in salsa agli aromi e patate in potacchio, «Che sarà mai il potacchio», chiede Antonia. Piccione disossato avvolto nella verza e grigliato. Ti fanno sapere tutto nei dettagli. Onesto, ma un po’ burocratico. Sempre meglio di quando coccolavano i cibi, li vezzeggiavano con aggettivi e diminutivi, una tagliatellina, un risottino; uno spaghettino con due vongoline, un filettino al pepe, le piccole verdure; quando li ornavano con termini presi da altri contesti: un formaggio molto valido, un salame dal sapore arguto, un modo nuovo di mangiare la carne, un risotto versatile. Una volta era più semplice, dice Maria Teresa pensando al vecchio Artusi: Fegato d’oca. Arrosto di maiale nel latte. Pappardelle con la lepre. Arrosto morto di pollo alla bolognese.
I contenitori stupiscono più dei contenuti. Cosa sono questi piatti? Leona è allibita. Il piatto è grande, grandissimo, a forma semiquadrata, o ovale, o rettangolare. Schizzi di salsa colorata, foglioline, petali riempiono il vuoto; al centro del piatto appare uno sparuto mucchietto di tagliatelle, un risicato pugno di riso. È tanto invece, ma ci delude la vista. O la illude a quei tanti tante che ormai marciano all’insegna del “poco, poco”. Piatto grande, finzione di cibo ridotto. È più e sembra meno. Light. Per assecondare l’imperativo alla virtuosa rinuncia. Per incoraggiare l’invito alla dieta. Per incrementare surrettiziamente la voglia di consumo.
È entrato nel ristorante, sfuggendo al controllo o confidando nella tolleranza dei gestori, il ragazzo marocchino con le rose. Si dirige al tavolo di fianco al nostro dove una donna, elegante e imbronciata, sfoglia un giornale con gesti secchi e troppo veloci. «Rose» dice «prendi una rosa.» La donna scuote la testa facendo scivolare in avanti ciocche bionde striate senza alzare lo sguardo e affonda nel giornale. Poi lo solleva e compra la rosa.
E i bicchieri? Sempre più grandi. In essi, il vino sembra un assaggio; Beppe protesta: tutto qui? È tanto invece, ma lo beviamo in fretta, senza il senso di colpa di vedere prosciugare velocemente un bicchiere di contenimento normale. Bicchiere grande per il vino, anche bianco, no, dice Marta, non è d’accordo, bicchiere piccolo per l’acqua. Chi si confonde denuncia la...