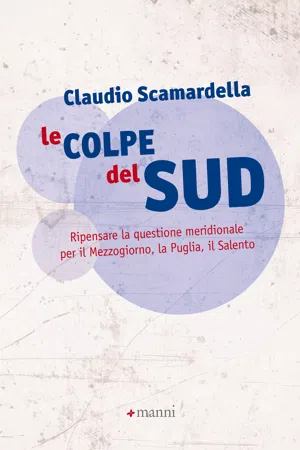![]()
PARTE SECONDA
IL CASO PUGLIESE
E IL LABORATORIO SALENTO
![]()
CAPITOLO QUARTO
Xylella, Tap e Ilva: la rete dei disastri
4.1 Il “sudismo” al governo
Il grande vuoto ideale e politico lasciato dall’eclissi del meridionalismo di pensiero ha fatto emergere al Sud e sul Sud negli ultimi anni analisi e letture, ma anche sentimenti, fascinazioni e personaggi che lo hanno ulteriormente danneggiato. Il Mezzogiorno è regredito, prima ancora che negli indicatori economici e sociali, sul piano politico, culturale, intellettuale e dell’informazione. È regredito non solo nell’incapacità di produrre una nuova visione condivisa e convincente, è fortemente regredito anche nella selezione e nell’espressione di chi è stato chiamato a rappresentarlo. Un abisso rispetto al passato, nonostante i difetti, le distorsioni e le degenerazioni delle vecchie classi dirigenti meridionali e nonostante il processo di decadenza del ceto politico non abbia riguardato solo il Meridione. Di sicuro, al Sud lo scarto tra il prima e il dopo si è presentato ancora più netto e marcato: sono riemersi i suoi lati e i suoi rappresentanti peggiori dopo la sistematica opera di demolizione dei corpi intermedi, dopo il crollo dei grandi soggetti collettivi. Nello stesso tempo, l’irrompere sulla scena della liquida e superficiale comunicazione digitale ha dato stura e libero sfogo al protagonismo degli “spiriti animali”, ha stappato la sentina del rancore e del malcontento, esaltata dalla rete, trasformando l’incompetenza in valore, i saperi in simulacri da abbattere, l’improvvisazione al potere in una conquista.
In questo “significante vuoto” ha avuto gioco facile ad affermarsi un’ondata anarco-populista che ha alimentato un ribellismo trasversale e un rivendicazionismo massimalista, impolitico, in reazione sia al vecchio leghismo settentrionale sia alle nuove paure create dalla globalizzazione. Hanno così trovato diritto di cittadinanza pulsioni, sentimenti e leader che hanno colmato la crisi del vecchio meridionalismo liberale e riformista con un “sudismo” della recriminazione, del rancore e del rigetto. Estremista nel linguaggio, rabbioso nei comportamenti, con una forte spinta all’autoisolamento come reazione alla lunga marginalità e alle decisioni calate dall’alto e subìte per molti secoli. Un “sudismo” pronto a “scassare” nel nome di un accentuato, quanto manipolato e strumentalizzato, orgoglio territoriale, con l’emergere e l’affermarsi di una corrente di pensiero più sovranista dei sovranisti: padroni a casa propria, ora decidiamo noi, qui ed ora, su tutto ciò che riguarda la nostra terra; e se non possiamo decidere noi, non possono e non devono decidere nemmeno gli altri. Una deriva che ha portato, anno dopo anno, pezzi e aree importanti del Sud a collocarsi spesso, con le istituzioni locali, all’opposizione dei governi nazionali e a rifiutare, a prescindere, tutto ciò che veniva da fuori.
È stata questa la variante meridionale della più generale rivolta contro il sistema e contro le élite maturata nelle società occidentali. Non solo il basso contro l’alto, gli emarginati contro gli integrati, i poveri contro i ricchi, ma un diffuso e trasversale sentimento di “rottura” e di “rancore” verso l’esterno. Questo sentimento ha accomunato, anno dopo anno, ceti disperati e ceti protetti, segmenti ampi della borghesia delle professioni e della stessa borghesia intellettuale della società meridionale. Una sorta di populismo identitario o, se si preferisce, di territorialismo populista che, a differenza di altri Paesi e altre aree geografiche in Occidente dopo la grande depressione del 2008, ha visto insieme e sullo stesso fronte “sofferenti” e “insofferenti”: il ribellismo antisistema proveniente dalle aree della “sofferenza” sociale ed economica si è incrociato, infatti, con l’area dell’“insofferenza” politica e culturale delle stesse élite meridionali anche in reazione alla dozzinale propaganda leghista contro il Sud, alle delusioni accumulate con i governi di centrodestra e di centrosinistra della Seconda Repubblica, ai nuovi fallimenti delle ridimensionate politiche pubbliche per il Mezzogiorno.
Rivendicazioni, recriminazioni e sentimenti che hanno trovato ben presto forma e sostanza dentro la politica e le istituzioni locali con l’arrivo al governo di molte città e regioni meridionali di personaggi di forte rottura rispetto anche al passato più recente, confusionari mestatori di un melting pot tra ribellismo e territorialismo identitario, oltre che con un senso delle istituzioni e dello Stato molto approssimativo. Capipopolo più che governanti, demagoghi e agit prop più che studiosi dei dossier e dei problemi da risolvere, bravi a cavalcare la protesta e la rabbia urlante e debordante dei social più che a incanalarle in soluzioni di governo, capaci di sostenere tutto e il contrario di tutto, a seconda degli interlocutori e delle platee del momento, più che a indicare una direzione di marcia e a costruire senso, a perseguire una visione e un progetto. Eppure, proprio per questo, capaci di avere un forte seguito, di conquistare e, perfino, di affascinare (con le parole) per qualche tempo la platea nazionale. Grazie alla perversa spirale di autoalimentazione del consenso con la gestione del potere, ma soprattutto grazie al sincronizzato incrocio tra domanda e offerta nello squassato mercato politico meridionale, con l’una che sostanzia l’altra e viceceversa: sta qui l’iniziale fascinazione, se non addirittura il successo e il consenso (anche extraregionale) che hanno ottenuto queste esperienze politico-amministrative.
I danni sui territori periferici sono stati devastanti. Il già pesante deficit di classe dirigente nel Mezzogiorno si è allargato, la già scarsa qualità nella gestione delle istituzioni locali è peggiorata. Una distanza abissale rispetto alla capacità di governo e alla concretezza dimostrate negli stessi anni dalla classe dirigente e dal ceto politico-amministrativo alla guida delle città e delle regioni settentrionali, non solo di provenienza leghista ma di tutti gli schieramenti. Distanza non certo giustificabile soltanto con la diversa disponibilità di risorse e la differente possibilità di spesa.
Potremmo dire che al Sud, da Napoli alla Puglia, dalla Sicilia alla Calabria, le forze (e i personaggi) antisistema sono arrivate al governo molto prima che a Roma, molto prima dell’exploit del M5S alle elezioni del 4 marzo 2018. E ci sono arrivate con la spinta determinante della maggioranza del cosiddetto “ceto medio riflessivo”, della borghesia delle professioni e di quella intellettuale, non solo del Sud sofferente, lazzaro o fannullone, orfano delle protezioni e in cerca di nuove forme di assistenza. La pulsione palingenetica a “scassare” ha attecchito anche in segmenti insospettabili della società meridionale, in ampi spezzoni delle stesse classi dirigenti, che pure avevano fatto collezione di privilegi, protezioni e mance nel “vecchio regime”. Così il Mezzogiorno è stato risucchiato nel vortice anarco-populista e di un rivendicazionismo massimalista senza sbocchi, se non nell’autoisolamento. Con gli stessi governanti locali a soffiare, sovente, sul ribellismo e a interpretare un linguaggio radicale ed estremista per nascondere le proprie incapacità realizzative. E con gli stessi governanti a identificare, di volta in volta, nemici nazionali o internazionali e capri espiatori lontani dal Mezzogiorno per darli in pasto agli elettori, attraverso la piazza reale o mediatica. Fino a convincersi e a convincere che il “non fare” fosse più efficace del “fare”: la negazione della politica e della funzione di una classe dirigente. Che, con l’esaltazione dell’incompetenza e la demolizione dei corpi intermedi, ha dato un colpo esiziale alla qualità di gran parte delle istituzioni meridionali.
4.2 Il retroterra culturale del “sudismo”
Esiste un rapporto inversamente proporzionale tra la crisi del meridionalismo e l’emergere del “sudismo”: quanto più il primo rivela la propria incapacità di rielaborarsi, ripensarsi e aggiornarsi, di trovare nuove parole e un nuovo linguaggio di fronte alle epocali trasformazioni in corso nel mondo globale, tanto più avanza il “sudismo”, a cominciare proprio dalle parole e dal lessico, anche nelle sue forme più becere, incolte, reazionarie e perfino lazzare. Le ultime dighe al dilagare del “sudismo” sono stati il tentativo colto e raffinato, benché troppo velleitario, del pensiero meridiano rifluito nella retorica delle eccellenze, e le positive ma isolate esperienze riformiste della prima stagione dei sindaci, di sinistra e di destra, e dei primi governatori.
È, infatti, verso la fine del primo decennio del Duemila che cominciano a emergere nel Sud parole e lessico all’insegna di un forte spirito di revanche verso il Nord, anche in reazione alle aggressive campagne di odio dei leghisti verso i meridionali. Parole e lessico utilizzati per ritrovare e ricostruire un’identità comunitaria e territoriale in contrapposizione a quella settentrionale. E che puntano direttamente a demolire il Risorgimento, il processo di unificazione dell’Italia e poi lo Stato unitario, considerati la vera e unica causa dei mali, delle arretratezze e dei ritardi del Mezzogiorno. Come dimenticare il linguaggio seminato dall’approssimativo, confuso e poco contrastato filone revisionistico della storia italiana, contrassegnato da un forte risentimento antinordista e da una rancorosa retorica contro i “nazipiemontesi” e i “galeotti garibaldini”? Si cominciò con i libri di successo scritti in serie da cronisti, sotto le mentite spoglie di storici, la cui unica tesi era l’annullamento delle differenze tra i “diversi” Risorgimenti e la riduzione dell’intero processo di unificazione dell’Italia a colonizzazione sanguinaria di un indistinto Sud da parte di un indistinto Nord. Si continuò con la nascita di movimenti e la proliferazione di convegni, non solo dei neoborbonici, per esaltare e valorizzare il Sud preunitario, e per dimostrare sulla base di dati e cifre presi alla rinfusa che l’unità d’Italia aveva soltanto danneggiato il Sud – un Sud ai tempi dei Borbone più organizzato, più ricco, più industrializzato, più infrastrutturato – e avvantaggiato l’allora arretratissimo Nord, che in seguito avrebbe fondato il suo sviluppo e la sua trasformazione proprio sfruttando e spogliando il Mezzogiorno di tutte le ricchezze. Il termine “terrone” fu sdoganato dagli stessi meridionali per diventare un tratto distintivo della propria identità, prese piede e consistenza la rivendicazione del “terronismo”. Erano gli anni in cui a destra e a sinistra, grazie anche alle sollecitazioni di settori del giornalismo meridionale, si giunse a vagheggiare la fondazione di un partito del Sud, una sorta di Lega meridionale trasversale e onnicomprensiva, in chiave tutta difensiva e in contrapposizione al blocco sociale e politico a trazione nordista. Erano gli anni in cui un ex sindaco di successo di Lecce, Adriana Poli Bortone, fondava “Io Sud” esaltando il brand del terronismo, e l’allora sindaco di Bari, Michele Emiliano, lanciava la proposta di riunire i cosiddetti “Terroni democratici” all’interno del Pd e del centrosinistra per far emergere un comune sentire “sudista” e un progetto “sudista”.
Un filone lungo e con molti interpreti che ha sedimentato e solleticato nel sottofondo della società meridionale pulsioni, rancori, ribellismi, senza mai trovare un adeguato contrasto da parte di una distratta e fin troppo elitaria intellettualità meridionale. E che ha portato qualche anno fa alla stolta, insolita e propagandistica iniziativa di alcuni Consigli regionali del Sud di votare ordini del giorno per istituire una giornata in memoria delle vittime meridionali del processo di unificazione italiana. Solo allora l’intellettualità meridionalista si è accorta dei guasti e dei danni prodotti dal suo prolungato silenzio e dalle sue colpevoli distrazioni negli anni passati, mostrando sorpresa e indignazione per la emergente incultura e per la pericolosa deriva. Troppo tardi. E anche troppo comodo prendere le distanze ed emettere sentenze di condanna con qualche intervista o qualche editoriale sui giornali. Quel magma si era venuto formando e ribolliva da tempo proprio per l’assordante silenzio della cultura e dell’intellettualità meridionaliste.
Il filone revisionistico, tuttavia, non ha riguardato soltanto la storia. E non si è esaurito nei tentativi di una riproposizione di un leghismo meridionale in chiave tutta e solo difensiva. Ha prodotto anche un comune sentire su un’idea regressiva del Sud, nel quale si sono incrociati e autoalimentati il “sudismo” e un “sovranismo” liquidatorio e vendicativo del passato. Nella radicalizzazione dell’identità territoriale, le popolazioni meridionali – a cominciare dagli stessi ceti dirigenti – hanno finito per interiorizzare un forte e diffuso atteggiamento di rigetto verso il processo di industrializzazione, una sorta di reazionaria demolizione degli interventi pubblici dall’alto nell’Italia postunitaria, considerati funzionali solo agli interessi del Settentrione e sommariamente liquidati come dannosi per il Mezzogiorno, violentato nella sua natura e nelle sue vocazioni. Nel giusto e legittimo ripensamento del modello di sviluppo che, con meriti e contraddizioni, si era affermato nella seconda metà del Novecento, prende il sopravvento un regressismo cupo e rabbioso contro la modernità, con un rigetto culturale del ruolo delle opere, delle reti, delle connessioni, perfino delle infrastrutture immateriali e digitali, necessarie per annullare le distanze con il mondo. Si è venuta così diffondendosi nella società la suggestione di una “purificazione” bucolica, con la riscoperta e l’idealizzazione dell’arcadia meridionale, con il sogno di un ritorno al piccolo mondo antico e felice del Sud preindustriale e agricolo, con la crescita dei preconcetti ostili all’industria e con l’illusione di una decrescita salutare. Ne è derivata una visione sempre più conservatrice dell’ambiente, anche laddove era stato scempiato e devastato, anche laddove mancavano infrastrutture materiali, necessarie per ridurre ritardi e arretratezze. Da qui un crescente e trasversale fronte del “no”, un’opposizione pregiudiziale a qualsiasi tentativo di intervento di trasformazione, la continua e stantia agitazione di complotti e aggressioni ai danni del territorio. Il “non fare” preferito al “fare” con un atteggiamento di diffidenza e di opposizione verso la scienza, la tecnica, perfino verso il progresso sociale.
Quante opere e infrastrutture materiali, finanziate da anni (alcune, come la statale 275 nella Puglia del Sud, da decenni) e cantierabili, sono rimaste e restano bloccate nel Mezzogiorno per le contestazioni delle comunità locali, per le liti tra sindaci, per la sindrome del nimby? Anche questa una regressione del meridionalismo, teorizzata invece come nuovo protagonismo dopo secoli di espulsione dalla storia e di imposizioni dall’alto.
4.3 Il “sudismo” pugliese
La Puglia è la regione che, negli ultimi anni, più di tutte ha incubato ed elaborato le varianti e le contraddizioni del “sudismo”, sia di governo che di opposizione, sia politico che sociale e anche culturale, ed è diventata una sorta di laboratorio della “mutazione genetica” dei ruoli e delle funzioni propri di una classe dirigente. Un “sudismo”, impastato di sovranismo e antimodernismo, che ha trovato terreno fertile nella valenza e nel concentrato delle questioni al centro dell’agenda pubblica pugliese – dalla xylella al gasdotto Tap e all’Ilva –, tutte di rilievo nazionale e diventate materie di scontro diretto tra centro e periferia. Proprio su questi temi, così sensibili e di grande interesse popolare, ma soprattutto di facile manipolazione nella formazione del sentimento pubblico, sono state sperimentate, prima che altrove, le disastrose conseguenze a cui una comunità e un territorio vanno incontro quando la politica e le istituzioni rincorrono tutte le piazze, reali e digitali, del ribellismo, parlando il “linguaggio del consenso” anziché il “linguaggio della verità”, inseguendo la followership invece della leadership, ricercando la popolarità anche se in contrasto con l’etica della responsabilità. Quando, cioè, chi ricopre ruoli di governo (e anche di opposizione) nelle istituzioni si traveste da capopopolo e sale sulle barricate invece di indicare la direzione di marcia e costruire il senso; rinuncia alla profondità per trasformarsi in un abile “surfista” sulle onde delle emozioni, della rabbia e della protesta della rete; insegue l’isteria del pensiero digitale nella demolizione delle competenze; asseconda rivolte e spontaneismi alimentati spesso da false verità o da verità manipolate. E aggiungendo, non di rado, carichi da novanta nelle piazze della rabbia invece di svuotarle, come è compito di chi ricopre responsabilità politiche e di governo.
Ma la Puglia e il Salento hanno anche sperimentato, prima che altrove, proprio su temi sensibili come la xylella, il gasdotto Tap e l’Ilva, i guasti e i danni prodotti dalla folle teorizzazione della cosiddetta “società orizzontale” da parte del M5S, con l’esproprio della politica e del governo da parte delle chiassose, isteriche e manipolate piazze digitali: non solo la delegittimazione dei decisori pubblici, ma il disprezzo verso le competenze e la demolizione dei depositari delle conoscenze, la derisione della scienza e il dileggio degli scienziati, la messa in discussione della separazione e della gerarchia dei saperi. Attraverso una quotidiana e sistematica campagna di odio, insulti, intimidazioni e minacce dispiegata dalla potente e organizzata macchina digitale pentastellata contro tutti i portatori di pensieri e idee non allineati.
Così, negli ultimi cinque anni la “mediatizzazione” del governo e dell’opposizione pugliesi ha raggiunto livelli parossistici con la continua rincorsa verso tutte le piazze della protesta e della rivolta e con la formazione di un trasversale e incontrastato “fronte del no”. Si è venuto delineando un modello politico e di governo nel quale si sono miscelati tutti gli stilemi di un populismo territoriale, agitato in modo magistrale soprattutto sul versante dell’ambientalismo: demagogia e propaganda, manicheismo ideologico, settarismo ed estremismo, complottismo e catastrofismi, appelli al popolo ed emotività di massa. Senza dimenticare la rigida quanto artificiosa divisione tra “buoni” e “cattivi”, tra il “bene assoluto” e il “male assoluto”, tra i portatori di una visione di benessere e di difesa del territorio e gli speculatori, i traditori e gli affossatori della Puglia e del Salento. È stato questo lo schema predominante, di governo e di opposizione, seguito su tutte e tre le questioni che hanno monopolizzato l’agenda pubblica pugliese negli ultimi anni.
Il risultato è stato un “movimentismo immobilista” o, se si preferisce, un “immobilismo movimentista”, corroborato dalla demagogica radicalizzazione dell’identità territoriale, in contrapposizione al “nemico esterno” di turno. Ora il governo dei petrolieri, ora le lobby del carbone, ora i ministri al servizio dei poteri forti, ora la vendetta dei banchieri e dell’alta finanza, ora i complotti delle multinazionali contro le tradizionali coltivazioni agricole, ora i gigli magici. Un’escalation vista e rivista in questi anni su tutte le principali questioni: scaricare le responsabilità sugli altri, denunciare l’inaffidabilità delle altre istituzioni, trovare alibi e individuare comodi capri espiatori da offrire alle piazze dello squadrismo digitale.
Del “movimentismo immobilista” l’arma più efficace ed utilizzata è stata il “ricorsismo”, l’esatto opposto del riformismo. Ricorsi sull’Ilva, ricorsi sulla xylella, ricorsi sul gasdotto Tap, ricorsi sulle trivelle, ricorsi sul patto Puglia, ricorsi perfino su materie di non immediata competenza regionale, come la buona scuola. Ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale. Esposti alle Procure della Repubblica. Tutti previsti dalle leggi, ci mancherebbe. Dunque legittimi. E, tuttavia, se il “ricorsismo” diventa una regola per un’istituzione importante come la Regione, e non l’eccezione, si viene a creare una situazione patologica, soprattutto se la “coazione a ripetere” dell’opporsi avviene anche in presenza di sentenze sfavorevoli e definitive. Trasferire continuamente nelle aule giudiziarie ciò che, invece, la politica è chiamata ad affrontare e risolvere, vuol dire abdicare alla funzione fondamentale propria di chi governa e rappresenta le istituzioni, che è quella dell’etica della responsabilità, della soluzione dei problemi, della ricerca delle mediazioni e dei compromessi. Indipendentemente dallo schieramento politico di provenienza. Nessuno dei problemi sul tappeto viene affrontato nelle sedi deputate, con i legittimi interlocutori e con le competenze appropriate. Nessun conflitto mediato e risolto. Anzi, la “non soluzione” finisce per essere ritenuta più conveniente ed efficace della stessa “soluzione” perché consente di non scegliere, di non scontentare, di non perdere consensi. Così il “ricorsismo” si rivela per quello che è: un decisionismo senza decisioni. Con gravi e pesanti danni sul territorio. Perché più gli anni passano, più i problemi non risolti si accumulano, si incancreniscono e si autoalimentano, scompaiono e ricompaiono, e la loro gestione viene demandata ad altre sedi e ad altre funzioni, come la magistratura, le prefetture e le forze dell’ordine.
Non esiste questione strategicamente rilevante per il futuro della Puglia che non sia stata o non sia condizionata, in questi ultimi anni, da inchieste e sentenze giudiziarie per il deficit di classe dirigente e, in particolare, per la subalternità alle piazze delle contestazioni, per l’incapacità della politica di assumersi le responsabilità che le competono. Mai a dire dei “no” netti o dei “sì” altrettanto netti e senza condizioni.
L’epilogo del caso della xylella, la realizzazione del gasdotto Tap e il destino del siderurgico di Taranto rappresentano la prova più evidente di ciò che accade quando chi ha compiti di governo e di rappresentanza politica smarrisce l’etica della responsabilità, è ossessionato dalla sola ricerca del consenso e viene risucchiato nell’orbita del conformismo digitale, alimentando e sfruttando, anziché arginare, l’estasi populista. Le popolazioni vengono prima illuse, poi raggirate, infine tradite; le istituzioni finiscono per sottovalutare, non fare o addirittura remare contro gli interessi veri del territorio; chi fomenta la protesta, omettendo o manipolando la verità, costruisce nel frattempo carriere politiche di successo, per poi rinnegare – una volta diventato inquilino delle istituzioni – le posizioni assunte da capopopolo nelle piazze reali o virtuali.
Il tempo, però, non fa sconti. A nessuno. Riconsegna alla storia i problemi veri e le soluzioni farlocche, mostra l’effimero successo dei profeti del falso, svela il fiato corto delle promesse dagli effetti stupefacenti. Mette a nudo gli inganni di chi aizza le piazze e soffia sul fuoco, di chi strumentalizza le proteste popolari per accrescere la propria visibilità e per costruire su di esse fortune elettorali e carriere. Dimostra, il tempo, che essere dei bravi agit prop dietro la tastiera è un conto, ma che governare è un affare maledettamente più serio in società sempre più complesse. E conferma che con l’incompetenza e l’improvvisazion...