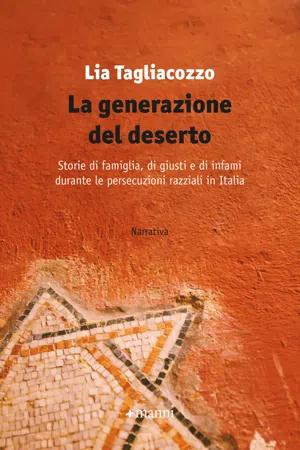![]()
CAPITOLO TERZO
Storia del cane Tito
Il cane Tito è un magnifico golden retriver di due anni. È di un delicato color avorio ed è straordinariamente buono. Non abbaia, non reclama. Viene a poggiare la testa sulle gambe dei visitatori della casa grande e luminosa in via G. B. a Firenze con delicatezza e senza insistere. Il suo merito fondamentale, appunto, è di essere buono. Ha un pedigree di pregio ma, in questa storia, non è questo l’importante. Mia zia, Sara Cividalli, gli è molto dedita, lo fa correre, lo istruisce, lo coccola. È proprio il cane Tito – oltre ad una buona dose di casualità – che ha socchiuso le porte alla storia. Un uscio – così si dice in Toscana – tanto nascosto e sprangato da ignorarne quasi l’esistenza e che invece, una volta aperto, ha suscitato ricordi e rimpianti.
Ancora più che per la storia della mia famiglia paterna le domande suscitate dalla vicenda della mia nonna materna sono – e sono destinate a restare – inestinguibili. Come la sete, la fame, il sonno… tutti i bisogni primari quando sono insoddisfatti. D’altro canto la nonna diceva: “Per un morto si piange, per due morti si piange, per tre morti si piange. Poi c’è solo il silenzio”. “E lei è stata zitta”, chiosa mia zia Sara, “tanti lutti impossibili da elaborare e il loro silenzio assordante sono stati deposti sulle mie spalle”.
Le occasioni in cui mia zia lascia Tito si possono contare sulle dita di una mano e, comunque, per il minor numero di giorni possibili. In una di queste, rare, circostanze Tito è andato in campagna da amici di mia zia a loro volta proprietari di una cagna. Un amico degli amici, vedendo Tito, si è complimentato per il nuovo arrivo. Il padrone di casa però ha replicato ironico chiarendo che il cane, in realtà, non abitava affatto da loro, stava piuttosto in via G. B., Firenze centro, vicino ai viali. “Conosco bene quell’indirizzo”, ha risposto sorridendo Raffaele Favilli, l’amico dell’amico, “ci andavo da bambino a trovare una carissima amica di mia zia”. Come spesso accade un nome tira l’altro e il caso e Tito hanno deciso che l’amico in questione fosse davvero il nipote della più cara amica di mia nonna: la signorina Nella Bichi. Si evince da quel signorina, non maliziosamente riposto prima del nome, che la Nella fosse nubile e di quei nipoti noi tutti sapevamo l’esistenza come parte unica e fondamentale della sua famiglia ma, con la morte della nonna prima e quella della signorina Bichi poi, nessuno ne aveva più saputo nulla e i contatti si erano persi.
Per sgombrare il campo da inutili equivoci è bene chiarire che la nonna in questione era in realtà la seconda moglie di mio nonno, divenuta poi madre della più giovane delle mie zie e mia – amatissima – nonna materna. Il nonno, Giorgio Cividalli, e la nonna, Miranda Servi, si sono sposati dopo la guerra, alcuni anni dopo che mio nonno era rimasto vedovo con tre figlie tra cui mia madre, Anna. Tutta questa spiegazione genealogica ha pochissima importanza se non fosse per chiarire che ho l’onere di avere ben tre famiglie con tre diverse storie delle persecuzioni. Tre memorie diverse. Tre lutti. Per quel che riguarda il legame con mia nonna – e poi chiudere questa parentesi – basti un piccolo aneddoto famigliare. In quei primi tempi in cui, prima del matrimonio, Miranda frequentava la casa del nonno Giorgio per dare lezioni alle mie zie più grandi Miriam e Carla, mia madre – bambina di sette anni dai trascorsi scolastici fortunosi tra la Svizzera dove erano scappati e la campagna toscana che li aveva accolti al rientro in Italia – scrisse che la nonna era la sua “amicia”. Con il correre del tempo la “a” è caduta ed è rimasta “la Micia” e poi “la nonna Micia”. L’articolo – come si è detto all’inizio – allora e oggi segnala la parte toscana della famiglia.
Era un piovoso pomeriggio invernale e a Firenze, poco più di dieci anni fa, nei locali dell’Adei – l’Associazione donne ebree di Italia – Marta Baiardi, storica, raccontava di uno studio recente: un’analisi delle testimonianze immediatamente successive alla guerra. La Comunità ebraica fiorentina, con straordinaria e forse addirittura inconsapevole lucidità – su richiesta del Comitato di liberazione nazionale toscano – pose immediata la necessità di fare una sorta di “inventario” di quanto accaduto nei mesi bui dell’occupazione nazista. Propose così ai suoi iscritti – che uscivano in quei giorni dai nascondigli in città o che tornavano dai luoghi di fuga – di scriverne una memoria. La prontezza del Cln toscano e dei dirigenti della Comunità ebraica fiorentina di allora è impressionante: la data di questi fogli ingialliti segna il settembre del 1944. Firenze era libera da poche settimane e al Nord la guerra continuava. Marta Baiardi racconta in quell’occasione all’associazione delle donne la storia di altre donne. Ma una di queste donne ed una di queste storie era quella della nonna Micia. La professoressa Baiardi non poteva sapere che la nonna – Miranda Servi Cividalli – era stata per molti anni la presidente della sezione fiorentina dell’associazione e che fosse una persona conosciuta e stimata. Solo la sera successiva qualcuno ha telefonato alla Sara, che allora non abitava a Firenze, per raccontarle quanto accaduto. E solo qualche giorno dopo Marta Baiardi – storica ma anche donna di cuore – ha inviato alla Sara, e lei a noi, le pagine di quella testimonianza sepolta in archivio e per questo assolutamente sconosciuta.
Di ciò che vi era scritto nessuno aveva mai saputo nulla. E nessuno quindi aveva potuto fare domande. Adesso che la nonna Micia è morta, e prima di lei è morto suo fratello Giorgio, adesso che di quella generazione non c’è più nessuno, restano delle facciate ingiallite e il tentativo di mettere insieme alcune, spesso vaghe, impressioni. Che la Nella Bichi fosse l’amica della nonna lo sapevamo tutti. Ciò che avevamo sempre ignorato era che l’avesse nascosta durante la guerra e, in questo modo, salvata. Ma la Sara dice che mia nonna “è morta prima che per lei arrivasse il tempo di parlare”.
Non so se sia una storia come tante di quegli anni di fughe e di paura ma è la storia di mia nonna e di come l’ho ricostruita io, come me la sono raccontata per mettere insieme i pezzi del puzzle, con l’aiuto della Sara, la zia giovane, nata anche lei come me dopo la guerra. Anche lei nel mezzo, anche lei della generazione del deserto.
Il 26 novembre del 2018 alla sinagoga di Firenze – luogo di vita della locale comunità ebraica e luogo di infanzia per me, mia sorella e mio fratello, in rigoroso ordine di età – si è svolta la cerimonia di conferimento del titolo di Giusto tra le nazioni alla signorina Nella Bichi e a suor Benedetta Pompignoli ma, come accade a volte a noi “venuti dopo” – quelli, appunto, della generazione del deserto – la loro storia si intreccia alla nostra perché le vicende delle loro vite sono annodate al modo in cui noi le abbiamo sapute o scoperte. E così la loro memoria è diventata anche la nostra perché ricordiamo cosa facevamo quando l’abbiamo ascoltata per la prima volta, cosa abbiamo provato, dove eravamo, se faceva caldo o freddo, se abbiamo pianto fuori o dentro, se abbiamo provato paura per i rischi terribili e i dolori indicibili o sollievo per la loro salvezza che ci ha, tra l’altro, permesso di venire al mondo. Ma la memoria ha in comune con la ragione la necessità di creare un discorso logico, di produrre sequenze comprensibili. Per dare senso e significato ad un racconto la nostra memoria ha bisogno di riempire i vuoti. La Storia in questo aiuta a identificare ipotesi verosimili, concatenazioni compatibili con la realtà. Ma la Storia non narra della mia famiglia, anche la nonna Micia, come gli altri del ramo paterno, nei libri di storia non c’è. Resta a me cercare di riempire quei vuoti in assenza del suo racconto e con il solo aiuto di quelle pagine ritrovate cercando di intrecciare ciò che so e conosco della nonna con quanto scoperto quando lei già non c’era più.
È stato in occasione della cerimonia per il conferimento del titolo di Giusto tra le nazioni che la Sara parlando dalla Tevà1, di fronte a studenti e autorità, ha detto che “dobbiamo pensare al lavoro della memoria come ad un atto di comprensione e di libertà […]. Una memoria che colga cosa c’è in comune tra l’allora e l’ora, tra luoghi e mondi apparentemente distanti. Una memoria che sempre più ha necessità di rivolgersi ai piccoli ricordi, alle storie apparentemente ordinarie e ha sempre meno bisogno di grandi numeri e di grandi proclami”. La memoria, secondo me, ha bisogno del gerundio – rammemorando; è solo se è continuamente compientesi e mai atto compiuto. Richiede sforzo di cuore, ricordare, e di testa, rammentare.
Così – ricordando con il cuore – affiora un regalo ricevuto per i miei dieci anni. La nonna me lo consegnò in ingresso, di fronte allo specchio, appena ero arrivata da Roma. Era il suo regalo, un gesto privato tra me e lei, che non includeva il nonno. Era un libro dalla copertina rigida di tela rossa e dalle scritte dorate, il titolo Storie della storia del mondo di Laura Orvieto2. Il libro era molto “vecchio” già allora, visto che venne pubblicato per la prima volta nel 1911. La mia copia era – ed è ancora, custodita tra i libri più cari – un’edizione più recente, del 1963, comunque prima della mia nascita. Un regalo che in questi ultimi anni, alla luce di ciò che ho saputo della sua vita e di ciò che è accaduto nella mia, ha assunto un significato speciale.
Mia nonna era una donna speciale, ha insegnato lettere classiche per tutta la vita e la lettura era per lei, come per me, fuga e rifugio, conforto e sollievo. Un lustro dopo i miei dieci anni ho passato ben due estati – quando ancora gli esami di riparazione si facevano a settembre – a studiare latino con lei e greco con la signorina Bichi. Credo si fossero conosciute alle superiori e la passione per lo studio delle lettere le aveva – immagino – unite fin da allora. Erano insegnanti antiche non solo per l’età: severe – non credo di aver mai studiato tanto come in quei mesi estivi né di aver mai sofferto tanto caldo come ad agosto a Firenze. Ma erano soprattutto intimamente competenti. Quelle storie e quegli autori non erano cose imparate, erano pezzi di vita: erano cose loro. In quel libro oramai pluricentenario – che continua ad essere in catalogo e ad avere nuove edizioni – la mamma di Leo e Lia racconta le storie degli dei e degli eroi greci e attinge ai poemi omerici e all’Eneide di Virgilio. La città di Troia, l’amore tra Elena e Paride, l’astuzia di Ulisse e il tallone di Achille e tanti altri episodi famosi diventano così per i due bimbi – e divennero per me che forse non a caso ne sono omonima – vere avventure. La struttura del libro è un affettuoso intercalare tra i bimbetti e la loro mamma. Mi rendo conto ora che nel mio lavoro ho fatto lo stesso: ho inventato il contesto narrativo mentre il centro della vicenda, il suo contenuto, è stata la storia delle mie famiglie durante la guerra. La nonna quindi non mi ha solo regalato un libro, mi ha fatto un dono che ha segnato il mio modo di pensare: la storia si fa dentro le vicende piccole, famigliari, e ha sempre bisogno di due voci: quella che narra e quella che ascolta, in cui c’è chi interroga e chi risponde. E chi interrompe mandando tutti a dormire e segnando il tempo del racconto. Per questo senso del dialogo così profondamente introiettato la mancanza di risposte fa risuonare la sua assenza. Scrive Primo Levi rivolto agli amici: “O tu / che mi leggi ricorda il tempo, / prima che s’indurisse la cera, / quando ognuno era come un sigillo. / Di noi ciascuno reca l’impronta / dell’amico incontrato per via; / in ognuno la traccia di ognuno”3. Di lei, in me per sempre, la traccia.
Forse anche un altro indizio era celato in quel regalo che ho letto per anni e che ora mi svela nuovi segreti: Laura Cantoni fu un’autrice famosa di libri per bambini con il cognome del marito Angiolo Orvieto, poeta, giornalista e fondatore insieme al fratello Adolfo del periodico culturale “Il Marzocco”, a Firenze. Sono abbienti e inseriti nella buona società cittadina ma questo non gli ha impedito di trascorrere i mesi dell’occupazione tedesca nascosti fra i vecchietti della casa di riposo del convento dei Padri Cappuccini di San Carlo, a Borgo San Lorenzo. Del convento dove è stata la nonna Micia invece sappiamo solo che fosse in via dei Serragli ma ora non ve ne è più traccia. Le stesse suore non riescono a ricostruirlo. Rimane un racconto vago nella corrispondenza tra suor Benedetta e la madre superiora alla fine della guerra: quando la suora accenna di aver accolto “tanta gente sconosciuta”. Ma la lettera risale al “dopo” e siccome la storia aiuta la memoria, e la cronologia è uno strumento utile, vale quindi la pena ricominciare dall’inizio, cercando nessi, percorsi e ipotesi. Adesso quelle pagine sono un punto da cui partire, un luogo materiale e mentale da cui originare il nuovo racconto e stracciare quello rasserenante che, in assenza di memorie, mi ero costruita da bambina: una storia magica che aveva tenuto la nonna al riparo dalle brutture e dalle angosce, in cui qualcuno l’avesse protetta nella casa che sapevo sua e che mi consentiva di immaginarla muoversi, leggere e mangiare tra quelle mura bianche, in una normalità appena sfiorata dalla guerra. Non è andata così ma, anche in questo caso, io lo so solo da poco.
Per aiutarmi a pensare questa nuova storia posso, adesso, fare ricorso ai volumi di storia inaccessibili da bambina: impervi per la mia età di allora ma soprattutto perché ancora non erano stati scritti. Negli anni Settanta gli studiosi stavano appena cominciando il loro lavoro tra le carte e vigeva ancora, tra i vivi, la consegna di vita e di silenzio.
Solo adesso l’urgenza della scrittura autorizza a fare domande. Ma non è come nelle storie che racconto ai bambini o quelle che Laura Orvieto scrive nei suoi libri, non ci sono generazioni pacificate e sorridenti che in poltrona si scambiano racconti e confidenze. Non c’è un camino acceso che testimoni con i suoi guizzi parole penose eppure oggi la scelta di scrivere mi pone al riparo dai rimproveri di invadenza. Gli anni passati, le nostre età, la temperie pubblica che santifica la Shoah da una parte e dall’altra le toglie paradossalmente ogni asperità e contraddizione fino a ridurla al male assoluto avulso da ogni responsabilità umana, hanno sdoganato finalmente nella mia famiglia la possibilità di parlare. Solo ora la fretta mi autorizza all’impazienza, per questo la mia telefonata coglie mia madre alla guida. “Cosa? Aspetta che accosto”. Nemmeno lei, biologa in pensione diretta al mercato rionale, sembra cogliere quanto sia surreale il contesto e la telefonata: “Mamma”, ripeto, “la nonna Micia parlava di quanto le fosse accaduto durante la guerra?” La risposta arriva immediata: “Lei non ne parlava proprio”, non vi è incertezza né esitazione. “Come non ne parlava mio padre”. Per mia madre i ricordi della nonna iniziano nel dopoguerra. La Sara, fuori dalla scuola materna di Firenze dove ha appena lasciato il nipotino, mi spiega: “A me non ha mai detto nulla”. A scavare un poco emerge un solo aneddoto: “Una sera alla porta del convento bussarono dei militi. Erano italiani e lei e le sorelle Curiat, nascoste con lei, gli scesero incontro nonostante fossero in camicia da notte. Nel vederle i fascisti gli si rivolsero però bruscamente chiedendogli dove stessero andando: ‘A messa’, rispose una delle ragazze tornata in sé e pronta a giustificare la presenza di tante giovani donne senza la veste. La soldataglia, soddisfatta dalla spiegazione assurda, le lasciò andare verso la cappella. La mamma raccontava l’episodio con ironia ed io allora non potevo certo superare la soglia che lei aveva posto alle sue confidenze”. “Tito, ferma!” Il cane Tito la accompagna ovunque e, nonostante tutto – l’urgenza, la drammaticità, la delusione per tanto poco racconto raccolto –, a immaginare mia zia, pediatra da poco in pensione, che tiene al guinzaglio il cane, sorrido. Solo oggi che finalmente se ne può parlare, che si possono fare domande, che la vita e il presente irrompono nella tragedia, noi della generazione del deserto possiamo sottrarci alla paralisi e, a volte, trovare il coraggio di sorridere. D’altro canto nella tradizione ebraica sorridere non è affatto disdicevole, lo fa per prima la matriarca Sara quando gli angeli le annunciano la nascita di Isacco. E lo fa anche il Padre Eterno. Oggi però, suonate molte decine di anni, si può riflettere, si può collocare nella storia. Oggi ci possiamo permettere di immaginare, di sentirci legittimati ad aggiungere particolari con la fantasia, possiamo riempire il vuoto dei racconti mettendoci del nostro senza tradire la consegna. Addirittura possiamo interrogarci se i comportamenti dei nonni o dei genitori, assunti per anni come indiscutibili, originassero da quel nodo informe di anni bui. Dal trauma di un’esistenza negata. Ma quando è la vita a chiedere la sua libbra i ricordi irrompono ignorando la cronologia: la nonna Micia non era una gran cuoca. Tra cucinare e leggere preferiva sicuramente leggere e non ne faceva mistero. Dei miei ricordi nella casa di via G. B., Firenze vicino ai viali, ricordo i fagiolini con l’aceto e i biscotti fatti con il grasso di pollo che pazientemente raccoglieva e congelava per poi – raggiunta la quantità necessaria – impastare e sfornare dei biscotti con una vaga forma di rombo, pieni di uvette. O il gelato allo zabaglione la cui ricetta le donne della mia famiglia – a parte me – eseguono immutata per tutte le feste ebraiche. L’altro punto di forza della cucina di via G. B. erano le scodelline di Pesach4, uno straordinario e spumoso impasto di uova, zucchero e farina di mandorle preparato in quantità da caserma in tutte le tazzine di casa solo e unicamente per la Pasqua ebraica. È un’eredità alla quale mi sono sottratta, nella mia famiglia la depositaria è mia sorella: fa gelato e scodelline meravigliose ma a me sembrano – non me ne voglia – meno magiche di quelle della nonna. Nel suo ruolo di casalinga la nonna Micia scalpitava parecchio ma si era piegata suo malgrado al volere del nonno Giorgio, bisbetico già allora, che la voleva a casa. È quindi andata in pensione dall’insegnamento molto presto per iniziare però molte altre attività: dava ripetizioni (anche se agli alunni venivano a volte imposti i brontolii del nonno che, al di là della porta del soggiorno, manifestava la propria disapprovazione) e divenne, e restò per molti anni, presidente dell’Adei. Credo, ma posso essere smentita, che fu tra le prime a partecipare come adeina alle consulte cittadine delle donne. “Era una persona molto buona”, ricorda mia madre sopra le voci del mercato rionale che mi raggiungono tramite l’apparecchio che collega la sua sordità al telefono, “era una donna mite ma soprattutto sapeva stare con gli altri. La gente faceva amicizia con lei volentieri, era una persona molto aperta”. Eppure qualcosa stride: nei miei ricordi la nonna era mite, è vero, ma come lo è un fuscello nella tempesta, che si piega ma non si spezza. Dietro la sua gentilezza scorgevo lampi di acciaio puro. Nel dopoguerra, quando ha sposato un uomo con tre figlie – almeno due delle quali già adolescenti – non credo sia stato facile, eppure sono intimamente convinta che lei non abbia mai fatto nulla contro il proprio volere, che una consapevolezza lucida e chiara le abbia sempre fatto scegliere – nella parte di vita in cui nazisti e fascisti erano scomparsi dal suo orizzonte – quello che ha voluto.
La nonna Micia era nata il 18 gennaio – a pochi giorni di distanza da me – del 1911. Nei racconti della zia Sara i primi ricordi di mia nonna risalgono alla fine della Grande guerra: “Era sfollata con la madre, il padre ed il fratello in un paesino vicino Firenze. La spagnola imperversava, la gente moriva e le campane suonavano incessantemente a morto. Lei era molto spaventata ma la sua mamma la tranquillizzò: non potevano mica morire lì, non c’era il cimitero ebraico! Una risposta surreale che ...