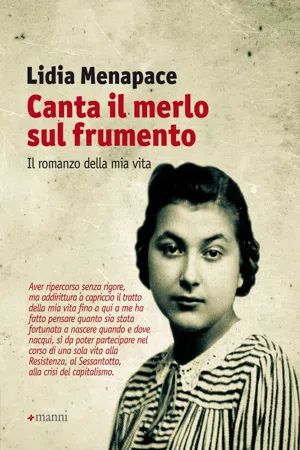![]()
Tornano i partiti
Nel 1946 si riorganizzarono i partiti, ciascuno con le sue idee, i suoi valori e i suoi progetti, ciascuno a rappresentare fasce sociali specifiche; ma a livello di base, di persone che erano abituate a collaborare e combattere insieme a prescindere dalle ideologie, le differenze erano labili, non sembravano sostanziali; il prete e il suo vice dalla Fuci di Novara si iscrissero al Pci ma furono quasi subito richiamati dal vescovo perché in qualche modo facevano propaganda; per me era così ovvio collaborare con i comunisti come era avvenuto per tutta la Resistenza, che non c’era alcuna differenza. L’unione fra preti e comunisti ci sembrava una ovvia conseguenza di quegli anni di lotta. Quando poi i partiti iniziarono a formalizzarsi, il Partito comunista e la Democrazia cristiana in particolare, a me cattolica sembrava più naturale aderire alla Democrazia cristiana, che pure accoglieva anche i nostalgici del regime, solo più democratizzati. Presi la tessera, anche se in principio la Dc non era particolarmente attraente soprattutto rispetto alla tradizione socialista, almeno a Novara, e i circoli che andavano formandosi avevano inizialmente l’apparenza di una specie di dopo lavoro. In definitiva, l’appartenenza ai partiti era una cosa non così straordinariamente definita.
I partiti più presenti, quello comunista, quello socialista, la Dc e quello repubblicano, due più grandi due meno, avevano degli organismi elettivi; generalmente c’era anche una parte delle donne, i vari movimenti femminili; le attività che svolgevano erano prevalentemente formative e sociali. La questione elettorale era molto presente ma non rappresentava l’ossatura delle attività. Si facevano delle riunioni di partito in cui si discuteva di vari temi sociali, il più importante era ovviamente quello della ricostruzione, delle ferrovie, delle case e delle fabbriche che erano state bombardate sia dagli alleati che dai nazisti dopo. Poi il 18 aprile 1948 ci fu il grande successo della Dc che prese la maggioranza relativa, e quella è una data che considero funesta perché già si intravedeva come quel partito si andava configurando. E nel ’49 venne la questione della Nato; io mi battei perché l’Italia non aderisse, in quanto l’adesione rappresentava l’accettazione della divisione mondiale, rappresentava la fine dell’unità.
Mi allontanai dalla Dc quando iniziò quello che poi venne chiamato anticomunismo viscerale.
Fin dalla sua origine e rifondazione nel 1943, la Dc ebbe una caratteristica, quella di essere un organismo composito e corporativo, tenuto insieme da elementi “esterni” alla sua struttura di forza politica.
Questi due dati – la composizione corporativa e la natura esterna del collante – sono permanenti e costituiranno insieme la forza della Dc nei momenti alti del suo dominio e la sua debolezza come asse della vita politica italiana, la debolezza specifica dello schieramento borghese, del blocco storico della borghesia, che emergerà nei momenti difficili e diverrà apertamente pericolosa nelle fasi di crisi prolungata e profonda. La coesistenza di questi due elementi, che vedono coinvolti in maniera ambigua quasi tutti i principali personaggi e gli statisti della Dc nel trentennio del suo regime, si ripete molte volte: troviamo in successione De Gasperi rappresentare la conciliazione del movimento cattolico con lo Stato liberale e Gronchi riprendere i temi del più tipico populismo cattolico; Dossetti esprimere una adesione laica alle forme organizzativo-politiche e, nello stesso tempo, fornire la base a tutti i più rigorosi integralismi; Fanfani, Moro, Andreotti venire dalle stesse esperienze formative nelle associazioni cattoliche e manifestare, persino in relazione ai rapporti con la Chiesa, forme molto differenziate di ossequio e di dipendenza.
Questa natura variegata, cui dopo gli anni Cinquanta viene dato il nome di “pluralismo”, è il riflesso della natura interclassista della Dc; dove il termine “interclassista” maschera e mistifica la natura realmente classista di quella formazione politica, della sua linea, degli obiettivi che persegue nella società e nella direzione dello Stato, e delle contraddizioni che la investono.
La Dc era il partito di maggioranza elettorale, e andava progressivamente occupando tutti gli spazi istituzionali, fin quasi a identificarsi con lo Stato: oggi diremmo un partito nazione. Comunque moderato, accettato da tutti, che difendeva tutti i valori, giusnaturalista: la libertà come diritto naturale, la famiglia come istituzione. Aveva anche una sua compattezza, oggi diremo biologica. La rivoluzione sociale della Chiesa non veniva accettata unanimemente, per i cattolici era già un grosso passo stare nella politica come cattolici. Basti pensare alla questione dei sindacati: nessun vescovo aveva detto che era giusto ammettere i sindacati, a favore di questi c’erano pochi preti, fra cui von Ketteler, un prete belga che lavorava in mezzo ai lavoratori nelle fabbriche e sosteneva che se la Chiesa perde questo aggancio lo perde non solo con il mondo contadino ma anche con l’intero mondo contemporaneo. I vescovi in seguito sostennero che sarebbero state preferibili le corporazioni, anche se era un termine dal sapore fascista, ma anche che il sindacato non era vietato né c’era la scomunica per gli iscritti, quindi per i cattolici fu possibile entrarvi. Permaneva tuttavia un atteggiamento di sospetto, una forma viscerale di paura verso il “rosso”, nei confronti dei sindacati considerati come iniziativa non cattolica, il che rese poi relativamente facile e poco traumatica la rottura dell’unità sindacale e la fondazione delle Acli in funzione antiunitaria e di destra.
Io ero e sono credente, anche se la mia educazione è avvenuta in una famiglia molto laica, laica nel senso che non c’era nessuna propensione religiosa. Avevo ricevuto il battesimo, la comunione e la cresima regolarmente – ma in un contesto appunto laico.
Un episodio emblematico di quel modello di educazione è legato alla Traviata. Mio padre era appassionatissimo di opera e mia madre aveva una bella voce ben impostata e cantava sempre mentre lavorava in casa, canzoni e arie, cioè quelle terribili canzoni anni Trenta tipo “Straziami, ma di baci saziami” oppure “Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto ha gli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma tu compri soltanto i profumi per te!”; ci facevo su i miei piantini pensando come sarebbe stato triste avere una mamma che preferiva i profumi suoi ai balocchi miei. Che del resto non erano regalati se non con misura e con intenti pedagogici.
Papà era il presidente di una corale che forniva i cantanti alla stagione d’opera del teatro Coccia, il nostro famoso teatro il quale – come altri che circondavano Milano – faceva da pedana di lancio per la Scala, sicché noi avevamo sempre una stagione d’opera nella quale si esibivano cantanti che diventati famosi sarebbero passati a Milano: il severo giudizio del loggione di Novara era noto. Avevamo affittato un palchetto di terza fila e la prima opera che i miei mi portarono a sentire fu appunto La traviata. La mamma mi preparò un bel vestitino di voilé bianco con una falda arricciata e mi fece due codini tenuti legati da alti nastri di taffetà molto elaborati: ci andai, mi deliziai, mi piacque moltissimo, ero assolutamente presa e ascoltavo con grande gioia.
Il lunedì andai a catechismo dalle suore, mi stavo preparando per la prima comunione, e alla suora che mi chiedeva che cosa avessi fatto la domenica raccontai del teatro e di quanto mi fosse piaciuto. Non riusciva a credere che fossi stata condotta a vedere La traviata: volle parlare con la mamma, le disse che non si dovevano portare i bambini a teatro, e poi proprio per La traviata, dove si canta “Questa donna pagata io l’ho!”. Ascoltai in silenzio e a questo punto, mentre la mamma cercava le parole per rispondere alla suora, dissi: «Adesso capisco, anche a me sembrava molto villano quel signore: se aveva dei crediti con quella donna, perché mai doveva rinfacciarglieli davanti a tutti? Davvero maleducato!» “Omnia munda mundis”, direbbe padre Cristoforo – ma all’epoca non conoscevo ancora il latino.
Ci fu poi una coda domestica, perché a tavola, come si usava da noi, quando la mamma finì di raccontare a papà la faccenda e la parola passò ai piccoli, chiesi se la suora avesse ragione e a teatro non ci sarei più andata. Mio padre, che era molto riflessivo e amava discorsi precisi e magari anche eleganti, disse: «Quando la suora parla di catechismo è autorevole e competente e la devi ascoltare; ma se parla di musica d’opera, non è cosa che faccia parte della sua preparazione e non occorre darle molto credito». Benissimo! Fui felice e all’opera ci andrò sempre.
Frequentando il liceo ad un certo momento ebbi una vera conversione cui seguì anche una certa pratica religiosa, e andavo a messa tutte le domeniche. Ancora oggi il termine ateismo lo considero un po’ contradditorio perché se dici ateismo vuol dire che hai una certa idea di Dio, non puoi pensare che a questo Dio manchi solo l’esistenza, è contradditorio in sé. Forse è meglio dire agnostico, anche se queste sono cose che non sappiamo e che forse non sapremo mai. Ma il punto interrogativo in questo senso a me resta. Verso l’aspetto del laicismo continuo ad avere un particolare interesse. Proprio per questo chiedo che venga abrogato l’articolo 7, perché non si può essere se non laici assoluti. Io sono contraria a tutti gli assolutismi tranne che su questo tema, perché non si può essere laici se non in forma assoluta. Dire che l’Italia è uno Stato laico quando la religione più diffusa e praticata è quella cattolica ed è garantita da un accordo addirittura con un altro Stato è dire una stupidaggine. L’Italia non è uno Stato laico.
Nonostante la mia religiosità, la scomunica dei comunisti da parte di Pio XII, nel ’49, la considerai una cosa sbagliata, convinta che era una scelta che avrebbe diviso, e più allontanato che avvicinato; mi dichiarai subito contraria, del resto appartenevo a quella parte delle Dc che batteva molto sulla sinistra, perché sembrava una misura così palesemente elettoralistica e così ingiusta da provocare effetti contrari a quelli che si proponeva. So che per alcuni militanti la vita diventò molto difficile, e passarono degli anni davvero drammatici, perché gli fu tolta la comunione all’altare dal prete.
A me non è mai capitato di avere difficoltà di questo genere: mi ero appena laureata alla Cattolica, eravamo nel 1945, avevo già cominciato la carriera universitaria e mi sembrava una cosa stupidissima mettere a repentaglio un percorso professionale potenzialmente brillante per il solo fatto di iscriversi al Pci, e quindi evitai di farlo, ancora convinta che l’Università Cattolica fosse una università libera, tutto sommato. Quando mi iscrissi alla Cattolica mio padre mi disse che una università non di Stato era più antifascista, e questo era vero perché molti professori erano antifascisti, anche se devo dire che era tutto molto mescolato, non era una scelta proprio limpida. Io rimasi convinta che l’università fosse un mondo completamente libero tanto è vero che passando da assistente volontaria ad assistente di ruolo feci delle ricerche sull’arte abbracciando l’idea marxista della società, sulla quale anche Marx stesso aveva dei dubbi, come conferma in alcune lettere con Engels.
C’erano in Cattolica alcuni docenti bravi ed aperti, per i quali la ricerca era l’aspetto prioritario del loro impegno, e non ti discriminavano per le tue posizioni politiche. Ricordo Sofia Vanni Rovighi che insegnava teoretica, conosciuta in tutta Europa, Gustavo Bontadini che era un professore di filosofia molto aperto e poi Mario Apollonio, di letteratura italiana, famoso critico ermetico, con il quale ebbi qualche difficoltà di relazione all’inizio della nostra conoscenza e poi anche durante la discussione della mia tesi di laurea, che definì fortemente “virile”, forse perché ...