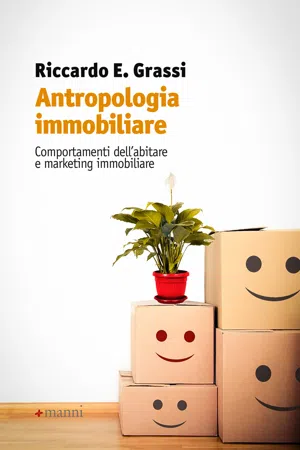![]()
PARTE PRIMA
Psicologia motivazionale e marketing immobiliare
1. Cuore e ragione
Investigando sulle dinamiche che attivano e strutturano le trattative di vendita ci siamo resi conto che il processo razionale non è tutto, anzi esso si limita a far da sintesi e da fattore risolutivo quando le “ragioni del cuore” hanno tenui possibilità d’essere esaudite.
Di più: è solo in apparenza che il processo indirizza le scelte, ma di certo ne rappresenta la conclusione.
All’inizio della sua ricerca della casa l’acquirente segue qualcosa che somiglia al “vivido colore del sentimento che dona alle anime la gioia di vivere”1.
Perciò se è vero che le nuove necessità dell’individuo o della famiglia, gli adattamenti imposti dalla vita quotidiana e un certo progresso verso il meglio stanno alla base del ragionamento di cambiar la propria abitazione (processo razionale, valutazione dei bisogni), è oltremodo vero che l’individuo è anche anelito, slancio verso l’ideale, superamento della materialità.
Perciò, verificato che nella persona s’è generata l’esigenza d’un nuovo alloggio, il passo immediatamente successivo è di soddisfarla con i “mi piacerebbe che…”.
Lo si coglie concretamente negli appuntamenti di vendita, quando s’indagano i motivi che conducono all’acquisto d’una residenza, chiedendo (banalmente) alle persone a quante camere da letto pensino, alla preferenza d’avere una cucina abitabile o aperta verso il soggiorno, o finalmente un grande balcone, ecc.
Le indicazioni che scaturiscono da questi colloqui preliminari focalizzano l’attenzione sui bisogni (più o meno essenziali) degli individui in cerca di casa, facendo emergere i centri d’interesse.
Si arriva dunque a stabilire questa relazione: quanto più la potenziale abitazione s’avvicina o soddisfa i centri d’interesse, gli aneliti, gli slanci verso l’ideale (in senso umanistico), tanto maggiore sarà la propensione all’acquisto.
Al contrario, se l’unità immobiliare soddisfa solo alcuni di quei centri d’interesse allora subentra il processo razionale.
L’individuo a quel punto cercherà di farsene una ragione: non è riuscito a trovare concretamente la casa dei sogni e, siccome mantiene comunque l’intenzione all’acquisto, ne valuta i benefici dal punto di vista logico, funzionale, razionale. Più scientifico che umanistico, verrebbe da dire.
Ecco perché nella trattativa di vendita l’aspetto razionale è la conclusione, non l’avvio.
2. Marketing ma non solo
Dalle trattative di vendita e dal concatenarsi di quegli episodi, numerosi e molto simili tra loro, è nata la constatazione di cui discorrevamo all’inizio: gli acquirenti tendono a cercar casa innanzitutto nei “luoghi del cuore”.
Un dubbio però non ha tardato ad arrivare. Ci siamo chiesti: il marketing, che prende le mosse dal mercato e dai bisogni del cliente, può da solo offrirci una chiave di lettura per questo fenomeno?
Oppure occorre affidarsi anche a qualcos’altro? Per esempio alla letteratura, alla psicologia, alle scienze umane in genere?
Il tentativo l’abbiamo fatto, cercando le risposte anche in queste discipline.
La prima a cui abbiamo pensato è l’antropologia; ci sembrava che s’avvicinasse di più alle nostre intenzioni di ricerca.
Senza pretese di definire compiutamente la materia né di voler dibattere sui confini che essa ha tracciato nel tempo2 desideriamo però dar conto delle ragioni del suo utilizzo in questa sede e della possibilità che sembra offrire di chiarirci talune dinamiche del marketing e delle vendite nel settore immobiliare.
La sociologia3 non è da meno: fornisce sicuramente degli spunti originali per arricchire il nostro discorso.
Per ciò che invece riguarda l’indagine motivazionale che guida l’acquisto, abbiamo verificato che la psicologia4 è uno strumento irrinunciabile.
A questo punto ci siamo chiesti: qual è lo spazio riservato al marketing? Quanto queste discipline sono in grado di valorizzarlo ed integrarlo? E, soprattutto, si può ipotizzare di risolvere la questione di partenza, cioè di comprendere non tanto perché un individuo debba acquistare casa ma piuttosto di cogliere i motivi del dove, del perché proprio lì?
3. Che fine ha fatto la casa: la gerarchia dei bisogni
Diciamo subito che vorremmo riferirci al marketing utilizzandone l’approccio ai temi e sorbendone gli spunti ma sospendendo temporaneamente una certa sistematicità dei testi sull’argomento.
Dunque, il punto di partenza per organizzare le attività di marketing non può che essere il mercato: luogo d’incontro tra persone che chiedono un prodotto (domanda) ed aziende in grado di metterlo a disposizione (offerta).
Nel caso specifico il prodotto è la casa nella sua espressione più generica di “muri da abitare” e le aziende sono indifferentemente tutti gli operatori immobiliari (agenzie d’intermediazione, costruttori, cooperative, ecc.).
Capire il mercato è perciò l’origine di ogni successivo pensiero.
Se esiste una richiesta da parte degli individui è perché in cuor loro manifestano un desiderio, un bisogno, quindi un’azione che prende le mosse da motivazioni fisiologiche, personali o sociali che si generano dalla differenza fra la situazione desiderata e quella effettiva.
Le necessità si presentano in tante forme proprio perché provengono da differenti sollecitazioni: quindi sono bisogni fisici, sociali, individuali. Tuttavia, pur essendo sintetizzabili in concetti, in realtà si manifestano in forma complessa perché emergono in momenti diversi secondo una priorità ben riassunta da A. Maslow5. Seguendo la sua teoria le necessità individuali vengono rappresentate con una forma gerarchica a piramide (fig. 1).
Lo schema è sufficientemente intuitivo: si capisce infatti che soddisfiamo innanzitutto le esigenze primarie di mangiare, dormire, ecc. e, pian piano, tendiamo a voler perfezionare anche quelle più “strutturate”, sino ad aspirare alla sommità, verso l’autorealizzazione, per cui gli individui perseguono una crescita personale (di cultura, di lavoro, di istruzione) attribuendo un senso alle loro azioni e attività.
Sembra inutile sottolineare che i bisogni posizionati verso l’apice generalmente sbocciano quando buona parte dei sottostanti sono, bene o male, soddisfatti.
Tuttavia questa scalarità è, nella realtà quotidiana, più complessa di quanto schematicamente viene rappresentato poiché ogni fascia non ha confini rigidi e ben delimitati, le cose non si svolgono in modo così lineare; anzi ogni persona agisce secondo stimoli esterni, ambientali e, in senso lato, pure culturali, reagendo con bisogni sfumati che coesistono e si sovrappongono.
Comprendere il comportamento di tali soggetti (quindi degli acquirenti d’una abitazione) diventa perciò indagine delicata. E dinamica.
Per riportare alla concretezza la piramide dei bisogni con le intenzioni della nostra ricerca, si può sostenere che gli individui cercano casa favorendo un’inconscia ibridazione tra fase fisiologica e di sicurezza.
È innegabile che l’abitazione veda una compresenza di entrambe. Di più: nella società moderna non si può prescindere che essa sfumi anche nel livello superiore, quello dei bisogni sociali.
In poche parole: un tetto sulla testa è ritenuto elemento fondamentale. La quasi totalità delle persone ha però soddisfatto tale bisogno: tutti quanti abbiamo infatti una casa dalla quale proveniamo, che sia in affitto o di proprietà non è significativo.
Quindi le fasi dei bisogni cosiddetti fisiologici e di sicurezza sono ormai acquisite dentro di noi, le diamo per scontate.
Oggi si prefigura un altro scenario: tendiamo a cercare (quindi a cambiare) abitazione ponendoci inconsapevolmente già nella fascia superiore, tra bisogni sociali e di stima.
Questo contesto, riferito alla casa e proiettato all’insù, è tipico delle società industriali avanzate, tanto che persino in presenza di squilibri sociali (livelli di reddito, qualità dell’occupazione, cultura, status) notiamo che la spinta a scegliere una nuova casa non è solamente dettata dalle mutate necessità dell’individuo (input razionali), bensì anche per tacitare un livello di bisogni più evoluti e strutturati.
L’aveva già sottolineato A. Maslow: ferma restando l’impalcatura piramidale, siamo in presenza di due ulteriori forme di esigenze espresse dalle persone e riferibili a cluster di popolazione più circoscritti, ma non meno importanti.
Soprattutto quando, aggiungiamo noi, queste fasce di popolazione esprimono l’idea d’una nuova abitazione: viene enfatizzato il loro bisogno di conoscere, di comprendere nonché quello di soddisfazione estetica. Di conseguenza, il bisogno di confrontare.
Queste tre componenti sono la manifestazione concreta della fase di maturità in cui si trovano oggi i clienti. E non meraviglia, infatti: si tratta della situazione tipica dei mercati avanzati (ed il comparto residenziale lo è a pieno titolo).
Le sollecitazioni che provengono da film e serie televisive, dalla pubblicità o dalle riviste di arredamento impattano direttamente sulle persone ed i loro gusti, a prescindere dallo status cui appartengono.
Quindi i bisogni di conoscere, di comprendere e di soddisfazione estetica non sono da sottovalutare solo perché crediamo si manifestino in fasce di pubblico più limitate, e generalmente “alte”. Al contrario: essi tendono a propagarsi e venir assorbiti anche dagli altri strati di popolazione, quanto meno per emulazione, e curiosamente pur in presenza di squilibri sociali significativi.
È quanto vistosamente emerge dall’osservazione che ne abbiamo tratto da chi mostrava l’intenzione di acquistare un alloggio. Non stupisce perciò ritrovare queste fasce “più allargate” di potenziali clienti che si spostano, nello specifico, sui livelli più alti della piramide.
Dunque vediamo transitare l’attenzione degli individui dall’abitazione in senso stretto e da quanto essa può rispondere oggettivamente alle mutate necessità (una camera in più, una cucina più grande, un posto auto privato, ecc.) ad un’altra porzione immobiliare che, fatto salvo quanto funzionalmente può garantire in più, appaghi anche l’idea estetica che essi hanno in mente e la rappresentazione di un raggiunto o millantato status.
In altre parole: spesso accade, per i beni di consumo, che i potenziali acquirenti tendano a soddisfare “necessità ideali” meno pressanti pur avendo da risolvere esigenze “più basiche”.
È il caso, per esempio, di chi compra un televisore o uno smartphone pur vivendo in situazioni di ristrettezze, al limite della soglia di criticità d’igiene, di alimentazione...