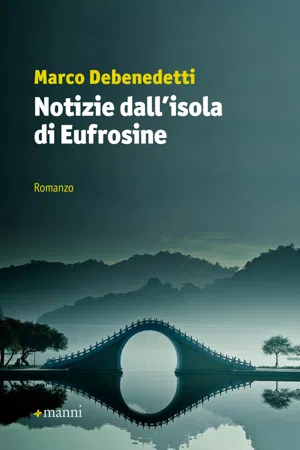![]()
Capitolo diciassettesimo
Innumerevoli – lo abbiamo detto – erano stati i maligni refoli di diffidenza che si erano sollevati, nelle settimane precedenti, a proposito degli ambigui rapporti fra Timoteo Crisostomo e Nicandro Flogo. Si era sussurrato che i due avessero ordito una subdola congiura per rovesciare Lisimaco e prendere il potere, e che tutte le attività filosofiche e religiose dello Straniero fossero finanziate dal denaro dell’uomo politico, e dei suoi complici. Che Flogo fosse una creatura dello stesso Timoteo, un suo fantoccio, e che il partito dei Despotai, da lui diretto, si fosse ormai ridotto ad un semplice braccio istituzionale della nuova organizzazione religiosa fondata dal Predicatore. Si era addirittura mormorato che l’uno e l’altro fossero dei modesti figuranti, dietro cui si intravedeva minacciosa la potenza economica di Eutidemo Filocaino, o di chissà chi altro: magari di uno sconosciuto gruppo di potere interno, o addirittura di una potenza straniera, interessata ad assumere il controllo della Repubblica. Ma, per quanto fitte si fossero addensate le tenebre del dubbio, e per quanto l’insediamento di Flogo nel nuovo ruolo di Arconte fosse circonfuso già da tante e così gravose ombre di sospetto, fatto sta che nei giorni immediatamente successivi al 18 la condotta del nuovo Governo nei confronti della minaccia eversiva rappresentata dalle affermazioni televisive di Crisostomo, e dal loro inveramento nel miracolo delle Sette Peregrine, fu fermissima. La mattina del 19, giorno in cui scadeva l’ultimatum lanciato da Timoteo, quasi all’alba, venne diramato un comunicato ufficiale, in cui si dichiarava che “di fronte alle gravissime asserzioni dell’agente straniero Timoteo Crisostomo”, la Repubblica di Eufrosine intendeva ribadire la fedeltà alle proprie leggi, e allo spirito democratico che le informava; e che il Governo diffidava Timoteo, i suoi seguaci o chiunque altro “da qualsivoglia atto indirizzato a sovvertire la legalità repubblicana, o a minare la saldezza delle istituzioni”. Di più non poteva essere fatto, a meno di non violare per primi la legge: la libertà di espressione in Eufrosine era sacra, e finché Timoteo non avesse commesso un atto concreto per dare corso alle parole intimidatorie che aveva proferito non poteva essergli torto un capello. L’Arconte Flogo dispose però un rafforzamento delle misure di sorveglianza intorno al Predicatore, che si era nel frattempo nuovamente trasferito, questa volta nella villetta di uno dei suoi sostenitori, alla periferia di Eudemonia; e mise in allerta le Forze armate.
La notte del 21 Nicandro Flogo fece un sogno. Si trovava nella stanza d’ospedale in cui era morto Pericle, ormai tanti anni addietro. Era una stanza semplice, in una delle più grandi strutture sanitarie della capitale, giacché l’Arconte aveva voluto essere curato come un qualsiasi cittadino, adorna solo di pochi fiori e di semplicissimi mobili: in esso la rapida agonia dell’ultimo grande statista della Repubblica si era consumata in silenzio, con dignità e riservatezza, circondata dalla costernazione dell’intero popolo eufrosinote. Nicandro non vi era mai stato, ma la conosceva alla perfezione per averne visto alcune fotografie riprodotte nei libri di storia; la stanza, nel sogno, appariva tuttavia sfocata: né era riconoscibile alcuna delle persone che erano radunate al capezzale dell’infermo. Tutto sembrava avvolto come in una nebbia, in un’ombra lattiginosa. Le uniche cose di cui Flogo riusciva a rendersi conto con chiarezza erano la propria stessa presenza, ed il volto di Pericle: quel viso dai tratti irregolari e ormai senile, deturpato dagli spessi occhiali e dalla malattia che – Nicandro lo sapeva – lo avrebbe portato alla morte di lì a poche ore, minuti forse; in cui brillava tuttavia indomabile il fuoco degli occhi azzurri, penetranti, vivissimi, consapevoli. Pericle lo guardava fissamente: era uno sguardo pieno di tristezza, illuminato da una sconfinata e come desolata, dolcissima pazienza, in cui riposava immensa una domanda. Flogo intuiva quale fosse, e di conoscerne la risposta; capiva altresì che se solo fosse stato in grado di rispondere a quella silenziosa, pressante interrogazione, a quella ardente richiesta, ogni cosa sarebbe d’un tratto mutata, e l’oppressione che gli gravava sul petto sarebbe magicamente scomparsa. Ma, per quanto affannosamente egli cercasse di parlare, per quanto spingesse con tutto il proprio fiato nei polmoni, la voce non era in grado di uscirgli. Ed egli avvertiva su di sé lo sguardo di Pericle, dell’uomo più saggio che mai Eufrosine avesse annoverato; e la sua delusione, la sua malinconica rassegnazione, come un dolore suo proprio, vertiginosamente crescente e senza possibilità di riscatto, che gli stringeva il cuore tanto forte da fargli mancare il respiro.
Ed ecco che ogni cosa si faceva di colpo più confusa ed incomprensibile. L’Arconte Pericle in agonia, la stanza d’ospedale erano scomparsi: Flogo si trovava ora su di un sentiero di montagna, circondato da una fitta vegetazione di alti pini, larici ed abeti; il sogno era repentinamente cambiato, e l’unico dato rimasto identico, e tormentoso, era il senso di soffocamento che avvertiva. Si trattava di un luogo per lui notissimo, e profondamente amato: i dintorni di una grande casa di famiglia in cui aveva trascorso i momenti più felici della propria infanzia e giovinezza, situata nell’aspra regione centrale dell’isola, quella che si raccoglieva intorno al Monte Chimerio. Egli percorreva il sentiero di buona lena, per quanto ripido, accompagnato proprio da Timoteo Crisostomo; si era in pieno inverno, ed i loro passi risuonavano ovattati sul manto nevoso. Fra i due vi era un clima disteso, come di grande amicizia, di affettuosa confidenza: tanto che Nicandro rivelava all’altro la propria oppressione. «Non ti preoccupare,» rispondeva tranquillo Timoteo «non ti devi preoccupare di nulla, perché, vedi…», e pronunciava con tono scandito una frase, una frase sola, breve, in una lingua misteriosa. Flogo ignorava di quale idioma si trattasse; e tuttavia, per quanto non fosse in grado di comprenderlo, ed anzi pressoché certo di non averlo mai neppure udito prima, sapeva che le parole in esso proferite erano per lui preziosissime, ed intimamente legate a tutto il complesso della propria vita: che se fosse riuscito ad intuirne l’irraggiungibile significato, non solamente lui, Nicandro, ma ogni cosa gli stesse a cuore avrebbe trovato salvezza. Il sentiero, man mano che egli camminava, si faceva più impervio, e la sensazione di asfissia, di pericolo che provava più dolorosa. D’un tratto, accanto a lui non vi era più Timoteo, l’indecifrabile Predicatore: bensì un bimbetto di pochissimi anni, dalla capigliatura corvina e ricciuta, che gli dava la mano e trotterellava cercando di tenere il suo passo, con visibile sforzo ma sempre con sollecitudine e con gioia. Nella sua fisionomia seria e aggraziata Flogo non tardò a riconoscere il figlio dei Nefalio, Cleomene, che gli sviluppi recenti della cronaca eufrosinote avevano reso celebre in tutta l’isola. La presenza del bambino, per quanto familiare, gli comunicava però una sensazione di irrequietudine e spavento, senza apparente spiegazione e tuttavia insopprimibile: con orrore, egli si rese improvvisamente conto che il volto del piccolo era come rovesciato su se stesso, e che all’esterno, in luogo delle fattezze che chiunque si sarebbe aspettato, gli occhi, il naso, la bocca, aveva invece una sorta di maschera concava, bianchissima, della consistenza della porcellana, e quasi stilizzata. Di fronte a questo mostruoso particolare l’angoscia, il senso di impotenza che l’avevano accompagnato sin dall’inizio del sogno raggiunsero nel suo animo l’apice: Nicandro era ormai travolto da un terrore puro, tanto assoluto e selvaggio da paralizzargli i pensieri e mozzargli definitivamente il fiato. A quel punto, di botto, egli si svegliò.
E vennero i giorni successivi al 19, che furono racchiusi in un senso di pietrificata sospensione. I seguaci di Timoteo, ed il Predicatore stesso, mantenevano uno sconcertante silenzio; l’opinione pubblica, attonita, seguiva il decorso degli eventi quasi in uno stato di trance. Due, fondamentalmente, erano le supposizioni che in maniera vorticosa si rincorrevano: una, la più ottimistica, che le minacce di Timoteo avessero rappresentato unicamente un bluff, e che fosse stato sufficiente che la Repubblica facesse una buona volta la voce grossa perché qualsiasi ipotesi di cospirazione venisse a cadere; l’altra, più allarmistica, che i seguaci della nuova religione stessero organizzando qualcosa di orrendamente insidioso, e che l’impenetrabile silenzio che mantenevano nascondesse una nuova e più terribile macchinazione.
La villetta in cui Timoteo si era trasferito era prossima ai limiti estremi di Eudemonia, quasi in aperta campagna: una costruzione bianca e linda, su due piani, circondata da una staccionata verde che racchiudeva un giardinetto curato, pieno di ciclamini, eriche, primule ed ellebori. Si trattava apparentemente di un luogo dall’aria ridente, quasi infantile; ad onta della sua parvenza innocente, era in realtà il luogo più pericoloso, ed insieme il più attentamente scrutato, temuto, desiderato e pensato di tutta l’isola, assai più che non gli stessi palazzi del Governo, sul Leucolofo. L’edificio era circondato da un fitto sbarramento di agenti dell’Astinomia, e di fronte ad esso stazionavano perennemente due camionette dell’esercito, con dei soldati armati di tutto punto. Intorno a tale cordone, come in una doppia cinta d’assedio, era radunata una piccola folla di seguaci di Timoteo, che bivaccavano ed osservavano ogni cosa, mantenendo un poco promettente silenzio.
Sembra dunque che i primi segnali della Megàle Stasis, la Grande Rivolta, si siano prodotti nel quartiere di Decelea: una zona popolare vasta ed ariosa ai margini della capitale, rapidamente cresciuta negli anni precedenti a ridosso della riva sinistra del Glaucomone, là dove la città cominciava ad ospitare amplissimi parchi che quasi si confondevano con le campagne circostanti. Il 27, intorno alle 18, minuto più minuto meno (le fonti sono in proposito altamente discordanti), alcuni membri delle forze dell’ordine, che erano stati inviati a pattugliare le strade, segnalarono al loro quartier generale presso la Polis Eudemonias di aver notato il formarsi, non si capiva bene se spontaneo o diretto dall’esterno, di alcuni rumorosi assembramenti di uomini e donne negli ampi viali di quella parte della città. I convenuti, riferirono, avevano un’aria assai determinata, rabbiosa, addirittura invasata, e parevano organizzati di tutto punto; recavano con loro dei cartelli, e scandivano slogan violenti, cadenzati e ossessivi come una litania, inneggianti a Timoteo, alla nuova religione, ed al sovvertimento della Repubblica.
Il contagio fu, da quel momento in poi, inarrestabile. Di lì a pochissimo – intorno alle 18:15, venne in seguito ricostruito – anche in differenti zone, variamente sparse per la città, si cominciò a segnalare la presenza di numerosi altri cortei e gruppi di facinorosi. In particolare, ad essere investiti dei disordini erano i quartieri di Alea, Ramnunte e Cefisia: anche in questo caso, i dimostranti brandivano cartelli ed urlavano slogan, del tutto identici a quelli mostrati nei primi assembramenti di Decelea.
Con il passare dei minuti, dei secondi quasi, il numero di partecipanti andava aumentando sempre di più, come il montare di una rovinosa marea. (È anzi questo il dato che colpisce di più, in tutte le testimonianze che abbiamo avuto modo di collazionare: la profonda sorpresa di tutti gli osservatori, di fronte alla rapidità con cui il fenomeno si era prodotto.) Già intorno alle 19 i dimostranti risultavano pari a molte migliaia di persone, forse decine di migliaia. La sera era ormai definitivamente calata, ed il cielo si era fatto buio, pesante ed appiccicoso come la pece. I rivoltosi cominciarono a dirigersi, a passo deciso, verso il centro della città, invocando il nome di Timoteo Crisostomo – del loro Maestro, del loro Phàidimos Heghemòn, Guida Luminosa, come lo chiamavano. Urlavano sempre, senza mai fermarsi, come se fosse solo il fragore delle loro voci all’unisono a tenerli insieme: una fiumana interminabile di figure tetre, vocianti, perfettamente coese da una comune, mistica volontà di annientamento. Qualsiasi ipotesi che potesse trattarsi di dimostrazioni spontanee (se mai alcuno aveva ancora in animo di accarezzare una così rosea illusione) era in quel momento definitivamente caduta: tutti avevano già avuto chiaramente modo di notare come i rivoltosi fossero organizzati con cura, e che il livello di coordinamento e precisione nei loro stessi movimenti era tale da far escludere, si può dire a fil di logica, che potesse trattarsi di un innocente fenomeno estemporaneo.
Alle 19:40 la folla dei manifestanti, oramai immensa, raggiunse i confini della Città Nuova. La distanza che avevano dovuto percorrere risultava in verità modesta, ma era il loro numero stesso, arrivati a quel punto, a rallentarne la fluidità nei movimenti. L’Astinomia era infine riuscita ad organizzarsi. Li aspettava nella Megàle Agorà, un’immensa piazza posta nel cuore del quartiere centrale, secondo gli ordini direttamente ricevuti dall’Arcontato, in tenuta antisommossa: una lunga linea di agenti in divisa blu scuro, con delle protezioni a difesa del volto e del corpo ed in mano dei manganelli, rigidamente disciplinati e, secondo le tradizioni di Eufrosine, ben decisi a non arretrare di un passo.
Tutto era pronto. I reagenti (ci venga perdonato, per descrivere un frangente tanto decisivo, l’uso di una metafora così rozzamente meccanicistica) erano stati disposti secondo gli opportuni rapporti stechiometrici, i catalizzatori che dovevano favorirne la combinazione erano al loro posto, le condizioni ambientali erano quelle dovute, il necessario livello di energia di attivazione sarebbe stato raggiunto. Lettore: come aspettarsi, spintisi ormai così innanzi, che il corso degli eventi deviasse dal proprio violento corso naturale, rigidamente predeterminato da equazioni antecedenti alla stessa esistenza di Eufrosine? Come pretendere che l’inevitabile, rovinosa reazione esplosiva, cui tutto quel che era accaduto fino a quel momento vertiginosamente conduceva, non si innescasse?
Alle 19:50 alcuni sparuti dimostranti, i più animosi e determinati, cominciarono a farsi avanti, seguiti a ruota dalla gran parte degli altri, vale a dire parecchie migliaia di persone: i rivoltosi cercavano di forzare il blocco che era stato eretto contro la loro avanzata, per raggiungere il Leucolofo e, di lì, la sede della Boulé. L’Astinomia, obbedendo agli ordini ricevuti, caricò la folla. Fu un soffio, un rapidissimo battito del cuore: le prime armi fecero capolino: i primi coltelli, i primi colpi di pistola sparati in aria. Le forze di polizia lanciarono, dal canto loro, i fumogeni; cercarono di isolare i più esagitati fra i manifestanti, buttandoli a terra ed ammanettandoli. Gli anelli della catena si succedevano gli uni agli altri, in una meccanica, inesorabile successione: fu a quel punto la volta dei seguaci di Timoteo di lanciare le prime bombe molotov.
La situazione si faceva di attimo in attimo più critica. La Megàle Agorà si era trasformata in un confuso, sanguinoso campo di battaglia, in cui già si contavano numerosi i primi morti e feriti, coperta qua e là da spesse volute di fumo ed invasa dal rumore assordante dei cruenti scontri in atto.
Alle 20:30, tutte le testimonianze e le registrazioni sopravvissute al disastro concordano, un numero elevatissimo di quartieri di Eudemonia, da Lachiade ad Acidatene, ad Alimunte, sino a Collito, giusto all’ombra dei piloni ancora semidistrutti del Metarsio, erano ridotti a poco più di un campo di guerriglia urbana. Neppure il Glaucomone, che da sempre tagliava in due la città, era stato sufficiente a contenere il montare della violenza; e se non vi era riuscito un corso d’acqua tanto grande, così antico e maestoso, come avrebbero potuto farlo le deboli forze umane dell’Astinomia? I disordini erano ormai ovunque, equamente sparsi in vastissime porzioni della città. Toccò all’Arcontato – e fu come l’ulteriore, possente scatto della meccanica di un congegno di devastazione – la responsabilità di imprimere ai reagenti la spinta verso il successivo stadio della loro transizione chimica: ordinò alle Forze armate di intervenire. E mentre il cielo era solcato dagli elicotteri dell’Esercito eufrosinote, si videro così, per la prima volta nella millenaria storia della Repubblica, i cingolati percorrere lenti e minacciosi, cadenzati come danzatori di un funereo balletto listato a lutto, i candidi viali della Città Nuova.
Solo ancora i quartieri di Torico, Gargetto e Anagirunte erano illesi dal contagio: si stagliavano luminosi come tre isole di grazia, sperdute in un violaceo mare in tempesta. Il Leucolofo, meta ultima dei rivoltosi, alle 21 era ancora in salvo, ma paurosamente minacciato.
Apparve allora evidente un fatto. Esso era minuto, lieve, etereo: impalpabile come la polvere che danza in un raggio di sole; un fatto a proposito del quale tutta Eufrosine, a cominciare dagli uomini che erano deputati a governarla, avevano volutamente, testardamente serrato gli occhi. Talmente difficile risultava accettare che il numero effettivo dei seguaci di Timoteo fra i cittadini dell’isola fosse così paurosamente ampio, e più grande di ciò che fosse auspicabile valutare; e che il livello di diffusione della nuova religione si fosse fatto, in appena poche settimane, tanto esteso e pervasivo. Dato ancor più spaventevole, ed altrettanto volutamente ignorato, la nuova religione si era capillarmente insinuata nelle fila stesse dell’Astinomia e delle Forze armate, tra le quali contava una quantità elevatissima di proseliti. E dunque, impressionante fu il numero di poliziotti e soldati che nel corso di quella notte sanguinosa si unirono improvvisamente ai rivoltosi, del tutto scompaginando i piani di contenimento minuziosamente approntati dall’Arcontato. Tutto ciò, se fosse stato almeno parzialmente valutato in precedenza, avrebbe forse fatto la differenza tra la salvezza e la rovina della Repubblica, quella sera; ed al prezzo modesto di un briciolo di lucidità in più, la storia dell’isola benedetta avrebbe potuto avere, perlomeno in piccolissima parte, un esito diverso, e meno tragico.
Già intorno alle 22 le fiamme si erano impadronite di vaste zone della città. I rivoltosi, nel tentativo di aver ragione dell’indomabile resistenza delle forze dell’ordine rimaste fedeli alla Repubblica, avevano preso a dar fuoco a qualsiasi oggetto combustibile capitasse loro a tiro, per distogliere da sé l’attenzione ed aver modo di organizzare delle tattiche di difesa rispetto alle misure di contenimento cui erano sottoposti. Ahimè! Pressoché ogni cosa, in Eudemonia, si prestava allo scopo: una delle caratteristiche fondamentali dell’edilizia privata della capitale era di essere volutamente costruita a base di materiali poveri, con una fortissima presenza di mobilia in legno, essendo invece quelli più resistenti e pregiati riservati agli edifici pubblici; tutto ciò naturalmente favoriva il diffondersi degli incendi. Né l’Astinomia poteva intervenire dappertutto: anzi, nel più violento infuriare degli scontri, non è escluso che anche ad essa sia da attribuirsi qualche corresponsabilità per il rapido estendersi delle fiamme. E neppure a tutto ciò erano in grado di ovviare i vigili del fuoco, giacché erano giocoforza nell’impossibilità, nel pieno della cruenta battaglia che si stava svolgendo, di raggiungere i più pericolosi focolai. Il buio della notte era interrotto da ondeggianti bagliori rossastri, che avevano preso il posto delle ordinate, rassicuranti luci di sempre.
Timoteo Crisostomo, spaventevole visione di rovina, fece a quel punto la propria apparizione in mezzo ai rivoltosi, circondato dalla piccola coorte dei capi più in vista della sua setta. Indossava la tunica bianca di sempre, quella con cui era solito impressionare la fantasia dei propri proseliti; aveva però unito ad essa degli speciali ornamenti, appositamente studiati per quella solenne occasione, una sopratunica ed un alto copricapo color rosso sangue, che ne rendevano ancor più ieratica, sinistra la figura. Agariste Nefalio era al suo fianco: in braccio a lei, si riconosceva la testolina ricciuta del piccolo Cleomene; li scortava il marito Èustrato, che cingeva le spalle della moglie: i tre formavano un piccolo gruppo fervoroso e compatto. Più di ogni altro, però, fu vista alla sua destra Teodosia: vestita con accurata eleganza, esattamente al modo in cui usava presenziare dalla tribuna alle sedute inaugurali delle sessioni della Boulé, con un abito nero dai riflessi cangianti, una collana di perle bianche, il bastone dal manico d’argento, ed intorno al collo e al risvolto della giacca le massime onorificenze della Repubblica, quelle che erano appartenute al marito, Pericle. Incedeva quella notte in mezzo ai rivoltosi con aria rapita e fanatica, una luce di autentica follia negli occhi; la sua espressione era assente, ed i movimenti a scatti ed a balzi, come quelli di una marionetta meccanica. Il piccolo gruppo, raccolto intorno al Predicatore, avanzava nella devastazione, come un manipolo di Erinni annunzianti la prossima rovina di Eufrosine.
Ecco che si innalza infine, lugubre ed indicibilmente triste, la stanca melodia della fine della Repubblica. Ecco salire lenta e funerea la musica che mai avremmo voluto intonare, e di cui tuttavia la nostra cronaca era intessuta fin dalle primissime parole. Ecco le foglie ingiallire e cadere dagli alberi, i ruscelli inaridirsi ed i fiumi andare in secca. Ecco i fiori imputridire, e l’erba dei prati trasformarsi in sterpaglie. Ecco stramazzare l’esemplare più fiero del branco, ed i piccoli essere rapiti bramenti alle proprie madri. Ecco che la voce più chiara si tace, la mano più dotata cessa di creare, ed il ...