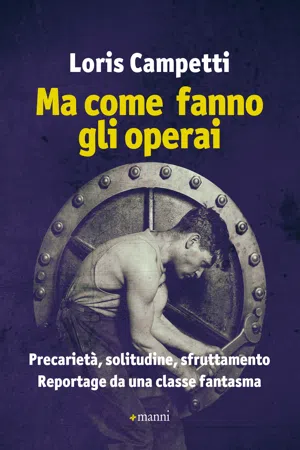![]()
L’operaio declassato
“Silenzio”, grida una voce dalla testa del corteo. Il brusio cessa come d’incanto, la stessa voce solitaria e squillante lancia, dal megafono, un motivo che scimmiotta i Ricchi e poveri e Nicola Di Bari nella canzone La prima cosa bella e scandisce: “La senti questa voce?” In risposta, dal lungo serpentone in marcia verso un futuro sognato si alza un coro possente che risponde: “Il potere dev’essere operaio” prima cantato e poi ritmato finché reggono le voci. Siamo nel Sessantotto, nel Sessantanove, negli anni Settanta, quando gli operai pretendevano di guidare il cambiamento con l’ambizione di governare il paese, la stagione in cui a indossare la tuta blu ci sono i comunisti con infinite tonalità di colore rosso ma anche i “comunisti bianchi”, operai cattolici veneti che camminano nella stessa direzione. Un sogno egemonico, quello della classe operaia che liberando se stessa avrebbe liberato l’umanità intera, si riversava dalla fabbrica alla società, alla politica. Nel corteo la componente maggioritaria del movimento interpretava così il messaggio: “È ora di cambiare / il Pci deve governare”. Tra la fine degli anni Sessanta e il decennio successivo la cosiddetta “centralità operaia” contaminava società, politica, cultura e nasceva una sorta di contropotere persino nei media, fino ad allora dominati dalla subalternità al potere democristiano o, se vogliamo, al comune senso del pudore. Cambiava la scienza che svelava finalmente l’imbroglio della sua presunta neutralità, mentre l’esperienza gramsciana e luxemburghiana dei consigli di fabbrica tentava di estendere sul territorio un inedito modello di democrazia. E c’erano gli intellettuali più o meno “organici”. Il sommarione del primo numero del quotidiano comunista il manifesto annunciava a tutta pagina: “Dai duecentomila della Fiat riparte oggi la lotta operaia. È una lotta che può far saltare la controffensiva padronale e i piani del riformismo”. Era il 28 aprile del 1971. Era la stagione dell’internazionalismo proletario, il serpentone colorato scandiva “Mirafiori / Barcellona / la catena / non funziona”, a Mirafiori c’erano 60.000 tute blu di cui oggi restano pochissime migliaia di superstiti; a Barcellona c’era la Seat, allora di proprietà Fiat prima di passare alla Volkswagen. Un decennio più tardi gli operai Fiat, che ai cancelli difendevano storia e dignità del lavoro, solidarizzando ironicamente con la lotta ai cantieri navali polacchi, gridavano: “Stettino-Carmagnola / la lotta è una sola”; cantavano “Tutto il mondo sta esplodendo / dall’Angola alla Palestina / l’America Latina sta combattendo / la lotta armata vince in Indocina”, una cover casereccia di estrema sinistra (firmata Pino Masi, titolo L’ora del fucile) del celebre successo americano contro la guerra Eve of destruction, compositore P.F. Sloan, cantato tra gli altri da Barry McGuire.
Tanto nella versione riformista quanto in quella più radicale la centralità operaia ha indotto talvolta a semplificazioni e narrazioni prive di fondamenta solide nella realtà di un paese in via di trasformazione, ma profondamente segnato da una storia e una cultura specifiche. Racconta un metalmeccanico lombardo, cresciuto in quegli anni di cambiamento: “Il guaio è che gli operai sono sempre stati utilizzati a fini politici, ieri mitizzati dalla sinistra fino a pensare che fossero diversi dagli altri cittadini, come se tutti votassero Pci o addirittura volessero fare la rivoluzione; cosa falsa, erano e sono solo persone normali. Una volta abbandonati dalla sinistra, che è andata a pescare consensi in diversi aggregati sociali introiettandone i valori, colpiti e impoveriti dalla crisi e dalle ricette liberiste dei governi falsi amici, mi spieghi perché dovrebbero votare per la sinistra, oppure pensare che gli immigrati che lavorano da schiavi negli appalti siano un’opportunità invece che un pericolo? Il fatto è che, una volta finita l’appartenenza a una classe – anche chi votava Dc si sentiva parte di una classe – viene meno l’idea che quella classe possa essere il motore del cambiamento del lavoro, della società, della politica”.
Dunque, dall’internazionalismo proletario si precipita nell’individualismo proprietario, anche se è di nulla che si è proprietari? Più semplicemente, l’insicurezza produce paura e la paura può diventare il catalizzatore di una guerra tra poveri. A questo proposito, un racconto amaro ci arriva da un capo della Fincantieri di Monfalcone: quando un giorno di primavera, sul pulmino aziendale che raccoglie i dipendenti acquartierati nei paesi vicini, è salito un operaio del Bangladesh dipendente da una ditta d’appalto, gli operai della Fincantieri hanno costretto l’autista a fermare il mezzo per far scendere l’intruso, quello che si sfinisce a spalmare e saldare la stiva della nave al posto loro.
Cancellato il lavoro come appartenenza e progetto collettivo di cambiamento, lo spirito con cui l’operaio va in fabbrica è quello di chi vuole solo tirar su i quattro soldi sufficienti “a campare la famiglia” o a continuare gli studi. Lo racconta un “operaio del weekend” alla Brembo che da grande non vorrebbe più costruire freni per le automobili il sabato e la domenica, ma produrre musica, tutti i giorni, per i cartoni animati. Passati dalla mitizzazione alla cancellazione, “gli operai sono tornati a essere persone normali. Ieri c’era il sol dell’avvenire”, prosegue amaro il metalmeccanico lombardo, “oggi l’avvenire, il futuro, non si riesce più neanche a immaginarlo”.
L’ingresso a Monfalcone è segnalato da un cartello stradale che sotto il nome della località precisa “La città delle navi da crociera”: “È sparito chi costruisce quelle navi con la sua fatica, si esalta l’oggetto, il prodotto del lavoro umano e viene cancellato il soggetto, il produttore”, commenta tra la rabbia e la tristezza un cantierino.
Fa scandalo il crollo delle sinistre nei luoghi simbolo di quella che fu la classe operaia, da Monfalcone a Torino a Sesto San Giovanni, e si è diffuso il luogo comune secondo cui gli operai avrebbero tradito la sinistra. Per cercare di capire cosa sia successo e cosa sia cambiato nel lavoro e nella soggettività operaia ci siamo messi in viaggio attraverso il Nord Italia, facendo tappa nelle cattedrali di un pensiero, una speranza, quasi una religione che oggi sembrano appartenere a un passato remoto che non potrà mai più tornare a vivere, almeno in quella forma. Un pensiero cancellato che non trova riscontro nei libri di storia, e neppure nei progetti di una presunta sinistra che forse, più modestamente, si dovrebbe definire centrosinistra. A un incontro che nella piazza ulivista romana dei SS. Apostoli lanciava il progetto di Pisapia “Campo progressista”, l’unico riferimento esplicito alla “classe” è arrivato, pensate un po’, da Sabrina Ferilli: “Sono vicina a questa iniziativa che spero possa riunire tutte quelle anime della sinistra che in questo momento si sentono confuse e non rappresentate. Ho sempre pensato che il paese abbia bisogno di più sinistra per ristabilire la cultura della giustizia sociale e della rappresentanza di classe”.
Nel viaggio abbiamo incontrato lavoratori tradizionali vincolati alle linee di montaggio e giovani sottoposti a forme moderne di sfruttamento, nell’industria, nei servizi, nella logistica, in quel che resta della cooperazione. Abbiamo attraversato città grandi e piccole valli, da Torino a Belluno alla Val Trompia, incontrando i cantieri complessi e articolati della mobilità: dal disegno alla costruzione, alla componentistica dell’automobile, dalle motociclette agli aerei da combattimento, dalle navi agli elicotteri. E poi la bicicletta, strumento essenziale per il lavoro dei rider, i ciclo-fattorini governati da un algoritmo, comandati da un sms e pagati a cottimo per consegnare pranzi e cene a domicilio. Aziende modello come la Luxottica, dove un padrone oculato, oggetto di culto, organizza l’intera vita del dipendente, dalla culla alla tomba come si diceva ai tempi di Vittorio Valletta, ma con più rispetto che negli anni Cinquanta alla Fiat; la salute, le vacanze studio, i libri e la colonia per i figli, il buono spesa e il buono benzina. Al punto che ben pochi operai rivendicano la necessità e l’utilità del sindacato nelle fabbriche di Del Vecchio.
L’Italia è il paese del capitalismo familiare ricco di quarti di nobiltà, lauree ad honorem e cavalieri del lavoro, i nomi di alcune di queste aziende rimandano a storie secolari: Agnelli, Del Vecchio, Cosulich prima che il cantiere di Monfalcone entrasse nella sfera dell’economia pubblica fino a prendere il nome di Fincantieri, (Aer)Macchi, Agusta, Brembo che equivale alla famiglia Bombassei. O Beretta che costruisce armi con lo stesso nome fin dai tempi della Serenissima, mezzo millennio fa. Alcune famiglie sono ancora in sella, altre, come Pininfarina, hanno gettato la spugna e i loro operai con essa; solo in qualche caso sono state inglobate da brand prestigiosi, come è capitato alla Bertone diventata Maserati, cioè Fca. Le testimonianze sono state raccolte in multinazionali, tipo Foodora, così come in piccole aziende. Abbiamo parlato con i dipendenti di fabbriche in crisi o addirittura chiuse; dove stanno finendo anche gli ammortizzatori sociali per operai troppo giovani per potere accedere alla pensione che la riforma Fornero ha trasformato in chimera, ma al tempo stesso troppo anziani per trovare un altro lavoro. Ma non mancano nel nostro viaggio aziende che scivolano sul mare magnum di bolina, talune con il vento in poppa. Aziende che se ne stanno mangiando altre all’estero, o meglio che credevano di averlo fatto come i manager della società pubblica Fincantieri inglobando la francese Stx: avevano sottovalutato il potere contrattuale del presidente Macron nei confronti di uno Stato italiano inconsistente che si limita a evocare, inutilmente, il rispetto delle regole liberiste del dio mercato mentre rinuncia a quote di proprietà. E abbiamo incrociato aziende come la Fca (Fiat Chrysler Automobiles) che fanno gola ai nuovi competitor (cinesi) in un mercato globale caratterizzato da regole feroci e scontri senza esclusione di colpi. Una Fiat non più italiana la cui testa è tra Usa e Canada, cuore e polmoni tra Londra e Amsterdam, che sta per essere ridotta a spezzatino, cotta e venduta ai migliori offerenti. C’è chi vede delle luci in fondo al tunnel della crisi più lunga, chi non riesce ancora a vederle, chi teme che quelle luci siano i fari di un treno lanciato a bomba nella propria direzione.
La crisi ha contribuito a modificare gli atteggiamenti dei lavoratori e proprio là dove ha picchiato più duro rischia di scatenarsi la guerra tra poveri, tra operai fissi e precari, tra diretti e interinali, tra tempi pieni e part-time, tra indigeni e migranti, tra anziani professionali e giovani studenti trasformati in operai nel weekend. Una guerra spinta dal sentimento della paura che a sua volta conduce al peggiore degli abbagli: invece di incolpare chi sta sopra e le sue ricette, si concorre alla creazione di ulteriori ingiustizie individuando il nemico in chi sta ancora più in basso. Là dove questo abbaglio si radica, il rapporto con i migranti diventa più difficile e i populismi di destra aprono brecce pericolose. E le forze che si dicono progressiste inseguono i populismi sugli stessi terreni al limite del razzismo, pensando così di raccogliere consensi. Come direbbe Maurizio Crozza nei panni del ministro degli Interni Marco Minniti, “Non si può lasciare il fascismo ai fascisti”.
“Io ho votato per il Movimento 5 Stelle perché condivido la critica al sistema dei partiti e credo nell’importanza della trasparenza. Non so se voterei ancora per Grillo, adesso che ha preso di mira i sindacati senza i quali noi operai ci sentiremmo ancora più soli. Una cosa so con certezza: mai ho votato e mai voterò per il Pd.” Così dice un operaio dell’Aermacchi che assembla i caccia da addestramento. E quando chiedo a un gruppo di lavoratori della Val Trompia se l’avvento degli ultimi governi a centralità Pd non abbia migliorato un po’ la vita degli operai, un coro di protesta mi zittisce: “No, l’hanno peggiorata”. E un operaio della Beretta, un costruttore di pistole che rivendica il suo pacifismo, mi fulmina: “Vuoi sapere cosa si pensa in fabbrica di Renzi? Se lo chiedi a quelli di sinistra come me ti rispondono che Renzi non è di sinistra e quindi lo detestano. Se lo chiedi a quelli vicini a Salvini o a Grillo ti rispondono che è di sinistra e di conseguenza lo odiano”. In quella che fu la classe operaia del Nord, la maggior parte, per non dire (ma sarebbe forse esagerato) la totalità dei sentimenti operai raccolti nel nostro viaggio, va in questa stessa direzione. Prova ne sia il crollo del Pd nei luoghi emblematici della sinistra italiana. A raccoglierne l’eredità non sono certo le forze politiche che arrancano alla sinistra del renzismo, giudicate negativamente per la loro incapacità di unirsi e costruire una sponda credibile per la parte più sofferente della società. Il primo partito sorto dalle ceneri della dynasty del Pci è quello del non voto, con le sue varianti che rispondono alle voci astensione e voto nullo. Anche le forze politiche di destra e il M5S vedono ridursi i consensi, ma sono paradossalmente premiate dal crollo degli eredi della sinistra, più che dai voti operai andati comunque a parziale beneficio delle destre e dei populismi. Siamo entrati nell’era della postdemocrazia in cui il Partito democratico brinda alla vittoria delle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, dove ha votato appena il 37% degli aventi diritto, o festeggia per i risultati ottenuti alle comunali di Taranto dove i tre quarti dei cittadini avvelenati dall’Ilva in fabbrica e in città hanno disertato le urne.
Sulla parete di uno stabilimento del Varesotto è appeso da decenni un poster di Enrico Berlinguer. Ma i giovani operai quella sinistra non l’hanno mai conosciuta, la sinistra incontrata nella loro vita è quella del jobs act e dell’eliminazione dell’articolo 18 del martoriato Statuto dei lavoratori. Se invece hanno più di trent’anni si ricordano che neanche a Berlusconi erano riuscite le picconate ai diritti nel lavoro che invece Renzi è stato capace di assestare quasi senza opposizione dal campo politico, incassando solo qualche timido brontolio da quello sindacale. Perché mai i più giovani dovrebbero, se non identificarsi con il Pd, almeno votarlo? Gli operai con i capelli bianchi hanno la memoria lunga, si ricordano molte cose, anche di quando il segretario del Pci Enrico Berlinguer andava davanti ai cancelli di Mirafiori per schierarsi apertamente dalla parte delle tute blu in lotta per salvare la propria storia e la propria dignità dall’aggressione della Fiat di Romiti. Ma ricordano altrettanto lucidamente di quando trent’anni più tardi il dirigente del Pd Piero Fassino, per cinque anni sindaco di Torino, ma prima ancora responsabile della commissione operaia del Pci, diceva che se fosse stato un operaio avrebbe votato sì al referendum-ricatto di Marchionne in cui un ipotetico lavoro futuro veniva scambiato con la certa cancellazione di diritti conquistati in decenni di lotte operaie. Perché stupirsi se quegli operai hanno rimandato a casa Fassino, consentendo l’elezione della grillina Appendino a sindaco della ex città dell’auto e della sinistra?
Nei cantieri navali di Monfalcone, una realtà operaia che è anche metafora della giungla nata dalla frammentazione e precarizzazione del lavoro – dove per assumere i padroni hanno a disposizione un menù da cui scegliere à la carte il contratto (o il nero) che più conviene – per la prima volta da decenni le forze del centrosinistra hanno subito una sconfitta schiacciante e sullo scranno del sindaco ora siede la leghista Anna Cisint. C’entrerà qualcosa il fatto che prima del voto la sindaca uscente del Pd, con l’astensione di Rifondazione comunista, ha accettato 140.000 euro da Fincantieri per ritirare la costituzione di parte civile nel processo per i morti d’amianto? E proprio là dove il capitale e la politica a esso prona stanno scatenando la guerra tra poveri, tra operai locali e operai “bangla”?
Quell’amianto maledetto che i cantierini erano costretti a spalmare sulle navi e sui propri polmoni e che oggi li sta uccidendo più di quanto fece la peste ai tempi di Renzo e Lucia?
Poi ci sono i nuovi schiavi, soprattutto giovani, spremuti nella logistica e nei servizi, senza tutele sindacali e dunque privati dei diritti conquistati dai loro padri. Ragazzi dati in prestito, in affitto da un padrone all’altro. Ragazzi che ricevono la chiamata sullo smartphone, pagati a cottimo e costretti a fare pubblicità gratis al padrone, lavoratori formalmente non dipendenti eppure subordinati a tutti gli effetti, escluso l’aspetto contrattuale. È il caso di Foodora, multinazionale delle consegne a domicilio dei pasti in bici. Per i dirigenti questi ragazzi non lavorano, “si divertono a pedalare e in più portano qualche soldino a casa”. Una paghetta, nessun diritto. Hanno protestato da soli, i sindacati confederali non li conoscono né riconoscono come subordinato il loro lavoro; sono stati licenziati tutti quelli che hanno osato raccontarsi pubblicamente a una cittadinanza distratta o indifferente. La passione per la bici? È la gig economy (economia dei lavoretti), un sottoprodotto della sharing economy (economia della condivisione). Il campo di applicazione di questi nuovi sistemi si sta allargando dai lavoretti a settori imprevedibili: piattaforme per avvocati o agenti commerciali, ristrutturazione di alloggi con gare tra architetti in crowdsourcing: è finita l’epoca del posto fisso, dello stipendio a fine mese, della pensione, della sanità. Se si va a chiedere ai ciclo-fattorini cosa pensano del sindacato o del centrosinistra si ottengono risposte feroci, e magari qualcuno non risponde proprio, limitandosi a mostrare il dito medio.
Abbiamo incontrato operai che avevano scelto di lavorare dentro un progetto alternativo a quello capitalistico, le cooperative di produzione-lavoro: metalmeccanici, chimici, soprattutto edili che si indentificavano nel loro lavoro e nell’azienda collettiva cui versavano le quote sociali e, quand’era necessario, prestavano persino i propri soldi. Piano piano quelle cooperative hanno cambiato natura, si sono aperte al mercato e alle alleanze con il capitale privato, la mutualità del progetto iniziale si è ridotta a “mutualità prevalente”, il lavoro è stato esternalizzato a finte cooperative nate come funghi, al punto che storiche cooperative di muratori non hanno più un solo muratore tra i soci lavoratori. Con gli appalti sono entrate nella filiera corruzione, malavita, persino le mafie; le cooperative storiche gestite da bocconiani sono fallite una dopo l’altra bruciando i capitali investiti dai soci lavoratori e migliaia di posti di lavoro. Insieme ai fallimenti arrivano i processi, come sta capitando a Reggio Emilia. In una fase di grave calo della domanda nell’edilizia, si è approfondito lo stravolgimento del nobile progetto delle società di mutuo soccorso e, contemporaneamente, si è arrivati alla fine dell’antico rapporto del sistema cooperativo con la politica (cioè il Pd) e con le amministrazioni (sempre il Pd) basato sul principio delle porte girevoli, con i dirigenti che transitano da una stanza all’altra senza soluzione di continuità. Con rabbia e con dolore quei lavoratori, traditi da chi ha trasformato un’esperienza collettiva democratica in pure società immobiliari che progettano e commercializzano merci prodotte da altri, stanno abbandonando in massa il centrosinistra, o più precisamente le urne. Dal fallimento delle cooperative si sono portati a casa solo lo scatolone che conteneva il loro lavoro e la loro utopia.
Dire che tutti questi operai – senza più sponde politiche e spesso privi persino di una rappresentanza sindacale, a cui è financo negata ogni rappresentazione e narrazione nei media e nelle fiction, a volte ridotti a nuovi poveri, precari oggi al pari del proprio futuro, con la pensione che si allontana come per tanti si allontana l’ingresso nel mondo del lavoro – hanno tradito la sinistra, è una bestemmia, un’oscenità; è l’evoluzione del processo di svalorizzazione del lavoro che fa vergognare i figli di dire ai compagni di scuola che il loro papà fa l’operaio.
Dai quartieri operai e postoperai e dalle periferie abbandonate è arrivata un’ondata che a Torino ha scavalcato i Murazzi del Po trascinando, insieme ai detriti, un ex sindaco convinto di vincere la sfida per riconquistare il trono già al primo turno. Un analogo tsunami ha spazzato via la memoria di intere città, dall’Emilia che fu rossa alla Roma popolare di Tor Bella Monaca, da Monfalcone a Sesto San Giovanni e a Genova. Gli operai hanno tradito la sinistra? I rottamatori della lotta di classe, quelli del jobs act, quelli del centro luccicante e delle periferie degradate, pensavano che si potesse conquistare il centro spostandosi al centro e stravincere perché le salmerie comunque si sarebbero accodate come sempre in passato, magari con il cappello in mano come facevano i braccianti pugliesi prima di Giuseppe Di Vittorio; hanno scoperto invece che abbandonando tra le fiamme dell’inferno gli operai si alzavano fiamme che, fuori controllo, avrebbero bruciato innanzitutto loro stessi.
Il cambiamento di campo della ex sinistra, sostenuta ormai soltanto dalle élite e dai ceti benestanti dei centri storici – sotto la Mole a Torino come in piazza Duomo a Milano o ai Parioli a Roma, ma anche nella City di Londra come a Wall Street negli Usa –, è andato di pari passo con la rottura delle regole novecentesche operata dalla politica per conto del capitale. La parola d’ordine renziana non era forse l’affossamento dei corpi intermedi? La Fiat, non da sola ovviamente, ha lavorato alla costruzione di un rapporto diretto con i lavoratori, tentando di liberarsi dei sindacati conflittuali e incorporando quelli già pronti a muoversi come gli ascari nelle guerre d’Africa. Contemporaneamente se n’è andata da Confindustria che senza il grande gruppo automobilistico si ritrova in una condizione di fragilità analoga a quella dei sindacati cui scivola via il contatto con i lavoratori. L’organizzazione del lavoro viene scombussolata e, in una sorta di rivoluzione passiva di gramsciana memoria, il ruolo che oggi i team leader sono andati assumendo in fabbrica assomiglia – e per alcuni aspetti è anche sostitutivo, sicuramente nell’intenzione di Marchionne – a quello ricoperto in passato dai delegati nel rapporto con i lavoratori. Attraverso i suoi esecutori il padrone vuole controllare e orientare i sottoposti in tutti gli aspetti della loro vita, dentro e fuori la fabbrica. Intanto quella che era la sinistra ha provveduto a togliere di mezzo pezzi di Statuto dei lavoratori, come l’articolo 4 che impediva il controllo a distanza dei dipendenti. E così nessuno si scandalizza e neppure si meraviglia, se oggi Marchionne regala agli operai della linea che a Mirafiori produce la Maserati Levante uno smartwatch a testa (tu ci fai quel che vuoi, io ti trovo quando voglio), facendo pure la figura del padrone buono e generoso.
Di questo raccontano gli operai e i sindacalisti torinesi, e ci aiutano a capire di chi è stato il tradimento, ammesso...