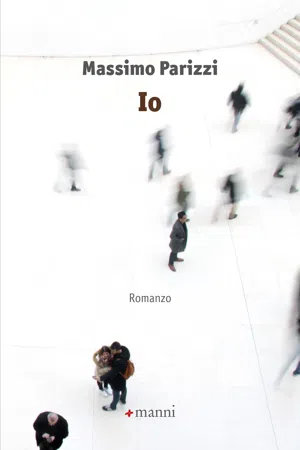![]()
Capitolo decimo
Apre gli occhi per la prima volta ed è inverno. Forse c’è la neve, chissà. Ecco la neve. Ecco il freddo ecco il caldo. Ecco le nuvole, ecco la pioggia. Ecco il vento. Ecco il sole. Ecco il cielo, azzurro.
È una bella giornata di sole e cielo azzurro. Ma con il sole e il cielo azzurro le polveri sottili restano nell’aria. È una brutta giornata di sole e cielo azzurro.
Che cos’è la leggerezza?
E che bello, nella casa del grande garage, da dietro i vetri in cucina, guardare i fiocchi che cadono. Si posano così morbidi. In piedi davanti alla portafinestra, non arriva neanche alla maniglia. Tutto si sta ricoprendo, come se scomparisse. Tende il piccolo braccio, raggiunge la maniglia e apre. C’è uno strano silenzio, fuori. E non fa neanche tanto freddo. Ma non appena sua madre rientra in cucina e vede la portafinestra aperta: «Torna subito dentro» gli grida «prendi freddo là fuori». Le mamme si preoccupano sempre. Rientra e, attraversata la cucina, si sporge sulla soglia verso il corridoio. È buio. Più lo sguardo si spinge lontano, più è buio. Sente battergli il cuore, s’irrigidisce e, in questo, prova uno strano piacere.
Perché è bello, sentire il cuore battere all’impazzata, a volte fino a togliere il respiro, o sentirsi impallidire o arrossire.
Che cos’è la spontaneità?
Perché è bello, che quello che si sente dentro di sé esca allo scoperto nel corpo. Non essere allegri, o tristi, o spaventati, soltanto dentro di sé. Altrimenti, chi se ne accorgerebbe?
“Senza corpo l’anima si vergogna”.
Qual è la verità? Quella che si sente dentro di sé o quella che gli altri vedono?
Fa un passo e intravede, in fondo, la porta d’ingresso. O l’immagina? Gli piacerebbe tanto arrivarci. Ma ha paura. Mamma! Mamma! Torna in cucina, sotto la luce, una luce calda. «Quanti anni hai, mamma?» «Ventidue» risponde lei ridendo, mentre stira. Dice sempre di avere ventidue anni. Sul fornello c’è il sugo, ancora un po’ liquido, rosso arancio, e scoppietta nella padella. Guarda che bolle! Non appena si formano, si gonfiano un po’ e, plof, esplodono lanciando in alto uno schizzo. Si sente al sicuro, qui, ma anche un po’ triste.
Perché?
«Non so».
E torna a fissare il buio in fondo al corridoio. Riuscirà mai ad arrivare alla porta d’ingresso?
Il corpo è piccolo, e gli piace strisciare sotto il tavolo, fra le gambe dei grandi. Che invece non possono, o forse non vogliono. Non entrano neanche nello sgabuzzino di zia Rosaria, loro. Lui sì. Gli piace quell’odore di detersivi. Si mette sulle ginocchia e sulle mani, apre la porticina di legno in corridoio, bassa bassa. E striscia nel buio. Ma questa volta non è il buio ad attrarlo. Non soltanto il buio. È uscire da un mondo ed entrare in un altro. Com’è facile. È lì: sotto il tavolo dei grandi, nel corridoio dei grandi. Perché non ci vengono anche loro?
Perché sono grandi e non ci passerebbero.
Perché farebbero fatica a chinarsi e strisciare.
Sì, sì, ma perché non ci vengono lo stesso? Perché se ne stanno lì seduti, al tavolo, una gamba di qua e l’altra di là, nei pantaloni o nelle gonne? Mangiando, bevendo vino, parlando? Perché non si buttano per terra? Perché?
La società è indietro rispetto all’uomo.
Quanti mondi ci sono al mondo! Quello sotto i tavoli e negli sgabuzzini bassi, dove i grandi non vanno. Quello dei corridoi bui.
E poi?
Ci sono mondi vicini e mondi lontani. Ma quelli che per alcuni sono lontani per altri sono vicini, vicini come le viette sotto casa sua.
Ma guarda un po’. Un capriolo che se ne viene dalla stradina. Stradina… Un sentiero largo d’erba e sassi. E lui: «Bianca!» S’incollano alla portafinestra dell’ingresso, e poi alla finestra della cucina, e poi del bagno. Quello passa accanto alla casa, la casa del castagno, brucando, sale il sentiero lungo la recinzione e sparisce.
Ecco, c’è anche il mondo dei caprioli.
E poi? Che altri mondi ci sono al mondo?
Da qualche parte, in Messico, c’è un vecchio che fa il calzolaio e non sa che esistono altre monete, oltre al peso e al dollaro. E la sera va a dormire, chissà dove, chissà se da solo o con sua moglie, a meno che sua moglie non sia morta o l’abbia lasciato, o lui abbia lasciato lei. Però potrebbe avere un figlio, una figlia, o più figli e figlie, e forse uno di loro, o una, vive con lui e la mattina gli prepara il caffè e gli dice: «Buongiorno, papà». Oppure è solo e la mattina il caffè lo prende al bar del paese, e sono il barista e gli amici a salutarlo: «Ciao, …» Chissà come si chiama. Forse si chiama in un modo e viene chiamato in un altro. Ha un soprannome. Può darsi. Quello che è sicuro è che sorride ed è mite. Per questo senza dubbio ha degli amici. Perché è un brav’uomo e non diffida degli altri, e non fa male a nessuno, non ne sarebbe capace, e questo c’è sempre qualcuno che lo apprezza. Magari con un po’ di condiscendenza, e allora la mattina, dicendogli «ciao…», gli dà una pacca sulla spalla. E lui è contento. Ma non è detto che non si accorga che quello lì lo tratta con un po’ di sufficienza. Soltanto, lascia perdere. C’è anche qualcuno, lo sa, che lo considera un uomo da poco, perché la sua bottega è un buco, ed è lercia. Questo è sicuro: la sua bottega è un buco ed è lercia. È che è sempre stato povero. “Cosa posso farci?” pensa, forse, mentre risuola le scarpe. Forse, perché a che cosa pensi non si sa, a parte, naturalmente, la colla e i chiodi che deve usare, le scarpe che gli restano da aggiustare. Ma non devono essere molte. Forse, per qualche minuto, ha pensato a quei due stranieri che sono passati dalla sua bottega con un paio di scarpe rotte e gli hanno chiesto di ripararle subito, per favore. Lui aveva solo quel paio. Ma non perché fosse povero, no, non erano dei poveri. Le scarpe erano americane, l’ha capito subito, e una aveva quasi perso la suola. E mentre la riparava, com’è che sono caduti su quel discorso? Mah. Comunque, quando lui ha chiesto se da loro, in Europa, c’era il peso o il dollaro, gli hanno detto che no, c’è un’altra moneta, l’euro. Questo bisogna che lo racconti, agli amici, o a suo figlio o a sua figlia o a sua moglie, se ne ha. Forse a questo ha pensato, per qualche minuto. È molto probabile.
Poi ci sono le ragazze. Così le chiama: hanno la metà dei suoi anni. L’aspettano al portone. «Ciao». «Ciao». «Ciao». Tutte e due minute, basse. «Brr, che freddo». Hanno sempre freddo. Quella con i capelli corti, ma così corti – una spazzola di pochi millimetri – che quasi non si vedono. A vedersi invece, e bene, è, roseo, marezzato, il cuoio capelluto.
Sono io, Cinzia.
E quella sempre elegante, che arriva ogni giovedì con un cappellino nuovo. E tutti bellissimi.
Sono io, Aurora. Ne ho una collezione, di cappellini.
A lui piace l’abitudine che hanno preso – ma chi ha cominciato? – di aspettarsi giù al portone, andando a lezione di arabo.
«Saliamo?» Preme il pulsante del citofono e il portone si apre. A chiamare l’ascensore è Cinzia, ma ad aprirne la porta, e i battenti della porta interna, è lui. Attento a farle entrare per prime o per ultime. E il rito si ripeterà, goffo, al sesto piano. Uscendo dall’ascensore per entrare da Cesare, il professore di arabo.
Ma c’è anche la ragazza che serve ai tavoli al ristorante dell’Arci Bellezza. È alta e avrà trenta-trentacinque anni. E poi il capo cameriere, che s’è tagliato la barba. E Khalid, ma non il vecchio, oggi non è venuto: un ragazzino che vende anche lui rose. Viene dal Bangladesh, dice, e ha diciassette anni, ma Bianca non ci crede; secondo lei ne ha almeno venti. Ma perché dovrebbe avere mentito? E poi c’è la signora del negozio di biciclette che, dice, non vuole più salire e scendere in continuazione quella scala. Per questo fanno solo le riparazioni che possono fare di sopra. Larga, sta seduta dietro il bancone. E c’è suo marito, che ha i baffetti. Gliela ripara lui la bicicletta. Ma quel capo cameriere stava meglio con la barba. C’è anche quella della panetteria, bassa e magra, che parla sempre ad alta voce per farsi notare. Gli è antipatica, ma anche l’altra non è che sia simpatica. Khalid, quello più vecchio, alto alto, magro magro, gli dice «tu mio amico». Con le rose in mano. E quando lui cerca nel portafoglio e non trova monete: «Io resto, io resto». Intende che può dargli il resto. Viene dall’India, lui.
I lati lunghi della casa del grande garage si affacciano sulle viette. Gli appartamenti al piano terra – che fortunati – hanno lì dei piccoli giardini. Minuscoli, qualche metro quadrato, e cinti da muretti sui quali si vedono spuntare, aguzzi, cocci di bottiglia, pezzi di vetro bianchi, verdi, marroni. Da dissuadere, ahimè, dalla scalata, ma attrarre ancora di più lo sguardo. E che cosa non si vede! Piante, erba, terra, fiori. Un giorno ci passa davanti e: guarda che fiori. Grandi, di tanti colori, e una ragazza. «Che belli» le dice lui. E lei, senza rispondere, ne stacca uno e glielo dà. «Tieni». Che bella mattina.
Ma chi è lei?
Io, no? Io.
In vietta va a giocare al mondo. Un gruppetto di bambini, e qualche bambina, via a saltellare su una gamba sola fra i quadrati disegnati col gesso sul marciapiede. Oppure a pallone sulla strada, e quando arriva una macchina si fermano e salgono sul marciapiede per lasciarla passare. E soprattutto, all’angolo fra una delle viette e la via che porta a scuola, dirimpetto alla casa, l’edificio di una fabbrica di impermeabili disegna una rientranza. Uno spicchio di erbacce fra due muri grigi ad angolo retto.
È nostro, quel posto.
E poi? Che altri mondi ci sono al mondo?
Oh, sono così tanti. Ci sono i mondi che ci sono stati, e ci sono i mondi che ci saranno.
Nel porto di Haiphong non c’è un’imbarcazione, piccola o grande, che non sia arrugginita, scrostata, malandata. Per scendere a terra dal traghetto passiamo sulle solite strette assi di legno con inchiodate piccole traverse a fare da gradini. Poi, da Haiphong a Nam Dinh in autobus, fra risaie con contadini e contadine chini, sotto i cappelli a cono, sulle piantine ormai verde intenso, fitte. Non un attrezzo agricolo a motore: mani e qualche volta bufali d’acqua. Grossi, grigi. Bianca mi fa notare il modulo delle case: un parallelepipedo oblungo, il lato corto come facciata sulla strada, diviso in due locali uno dietro l’altro, piccoli. Il primo è spesso negozio, garage per la moto, sala da pranzo e soggiorno insieme. I mobili principali, a volte unici, televisore e credenza; cui possono aggiungersi una poltrona, un tavolino, delle sedie che, nelle case più ricche, sono in stile “cinese”: di legno scolpito a disegnare draghi e simili. La seconda stanza sarà la camera da letto. A volte il modulo si raddoppia in altezza e allora la prima stanza al piano superiore è spesso una veranda chiusa da una balaustrata. In qualche caso si triplica. E spesso si raddoppia o triplica anche in larghezza, ma in genere rispettando il modulo.
Da Huay Xai a Luang Prabang, Laos. Il barcone rolla e scricchiola. Strani sguardi e richiami fra il timoniere a prua e altri dell’equipaggio a poppa non mi fanno essere tranquillo. A un certo punto spostano un mucchio di zaini a prua per bilanciare il peso. Ci sono gorghi a volte violenti, rapide, secche, rocce affioranti, contro una delle quali è schiantata una “speedboat”, una di quelle barche che solcano il Mekong a velocità folle, passeggeri e timoniere tutti con giubbotto salvagente e casco. Sembra che gli incidenti siano quotidiani.
Il fiume è ampio, color fango, pieno di disegni formati da tutte le irregolarità del fondo e delle correnti, pieno di detriti, legni, pezzi di bambù spesso immobili sui gorghi. Sulle rive, per tutto il percorso, un paesaggio che doveva essere lo stesso cento, duecento anni fa: foresta, i verdi alti e inchinati dei bambù, palme, mille alberi sconosciuti; in radure, villaggi anche di numerose case di legno su palafitte, senza elettricità, né acqua corrente, né strada. Il padrone della guest-house mi dice che non è gente povera come sembra: pescano, coltivano il riso a secco, piantano tek.
Che cosa vuole fare questo ragazzo?
Vuole fare il traduttore. Cioè, non è che lo voglia proprio, o che è questo che voglia fare nella vita. È che deve pur lavorare, per mantenersi. E i libri gli piacciono. E sa il francese. E Piera qualcosa ha già tradotto. Così, una volta è lui, un’altra lei ad andare alla cabina telefonica del bar, in piazza, a Final Borgo. È in fondo, oltre il lungo bancone, e non c’è bisogno di gettoni: si paga dopo alla cassa. Basta chiudere la porta e, nel silenzio, perché la cabina è insonorizzata, nella penombra, comporre il numero. E poi un altro, e un altro. Ma per che cosa? Per sentirsi dire: «Adesso non abbiamo nulla. Richiami fra quindici giorni»?
Chi è Piera?
Gli viene una rabbia. Non ha ancora capito niente. Ha passato da poco i vent’anni e, perché ha due braccia, perché ha una testa, crede che dovrebbero cercarlo loro. Altro che farsi cercare. Che spreco, pensa. Cerco lavoro e mi rispondono annoiati, come se li infastidissi; con tutto quello che ci sarebbe da fare, al mondo.
E fallo, allora.
Spreco di che cosa?
Che cosa ci sarebbe da fare, al mondo?
È nel suo pigiama azzurro che il secondo giorno del convegno, il convegno nazionale del movimento studentesco a Ca’ Foscari, Venezia, si alza, la mattina, tirandosi fuori dal sacco a pelo a sarcofago rosso e blu. Ha dormito nell’aula magna dell’università, e adesso raccoglie il suo sacchetto di plastica con lo spazzolino, il dentifricio, l’asciugamano, e s’incammina verso i bagni. Quando uno passandogli accanto si ferma, lo guarda e ridacchia. «È per il pigiama azzurro?» si chiede lui.
Be’, certo che ad andare a un convegno di rivoluzionari, in un’università occupata, portandosi dietro il pigiamino azzurro, ci vuole tutta. Perché non s’è portato anche la mamma? Gli avrebbe preparato la zuppa di latte per colazione. L’avessi visto io invece di quello lì, altro che ridacchiare: sarei scoppiato in una sonora risata.
E perché? Adesso a un convegno di rivoluzionari non si può indossare quello che si vuole? Lui è un ragazzino, in famiglia s’è abituato a dormire in pigiama, e se l’è messo anche lì. Sarà conformista, d’accordo, come portare la giacca e la cravatta. Una divisa. Ma anche il movimento ha le sue divise: l’eskimo, le sciarpe, i jeans, le magliette. Conformista è quello che ha ridacchiato.
Come se il conformismo non avesse le sue buone ragioni. Significa anche non volere separarsi dagli altri.
Splende il sole, oggi, e lui ha fatto tutto. S’è lavato, cambiato d’abito, persino pulite le scarpe. Non basta che chiudere la porta, salutare allegramente il vicino che sta salendo, scendere con le mani in tasca i gradini. La freschezza dell’aria, che aspettava, lo accoglie. La luce luccica sui marmi del Duomo, tra le foglie degli alberi, rimbalza sul pavé, per le vetrine, e un vento leggero si unisce ai suoi passi veloci per sventolargli le falde della giacca. La più bella che ha. Così passeggia per la città, tra le volute barocche delle fontane, cittadino tra cittadini, senza dovere vergognarsi di niente, nemmeno di sé, attirare lo sguardo delle ragazze e sguardarle.
Per fortuna, di boz...