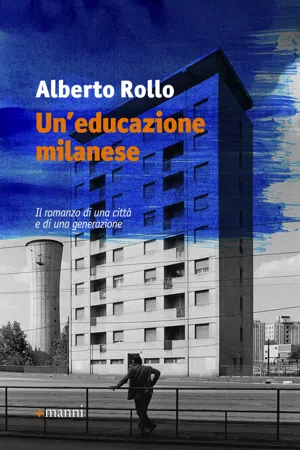
This book is available to read until 31º marzo, 2026
- 320 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Disponibile fino al giorno 31 Mar |Scopri di più
Un'educazione milanese
Informazioni su questo libro
"Cerco ponti in cui lo spaesamento e il sentirmi a casa coincidano. E su quei ponti finiscono con l'apparire, teneri e meridiani, i fantasmi che mi riconducono là dove io sono cominciato e dove è cominciata, per me, questa città."
Questa è una ricognizione autobiografica ed è il racconto della città che l'ha ispirata.
Si entra nella storia dagli anni Cinquanta: l'infanzia nei nuovi quartieri periferici, con le paterne "lezioni di cultura operaia", le materne divagazioni sulla magia del lavoro sartoriale, la famiglia comunista e quella cattolica, le ascendenze lombarde e quelle leccesi, le gite in tram, le gite in moto, la morte di John F. Kennedy e quella di papa Giovanni, Rocco e i suoi fratelli, l'oratorio, il cinema, i giochi, le amicizie adolescenziali e i primi amori fra scali merci e recinti incustoditi.
E si procede con lo scatto della giovinezza, accanto l'amico maestro di vita e di visioni, sullo sfondo le grandi lotte operaie, la vitalità dei gruppi extraparlamentari, il sognante melting pot sociale di una generazione che voleva "occhi diversi".
A questa formazione si mescola la percezione dell'oggi, il prosciugamento della città industriale, i progetti urbanistici per una Grande Milano, le trasformazioni dello skyline, il trionfo della capitale della moda e degli archistar.
Un romanzo autobiografico magistralmente scritto, lo sguardo teso della visione: la storia di una città, di una generazione.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Un'educazione milanese di Alberto Rollo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Literature e Literature General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
IN QUEL TEMPO
Un grande amico che sorga alto su me
E tutto porti me nella sua luce
Che largo rida ove io sorrida appena
E forte ami ove io accenni a invaghirmi…
E tutto porti me nella sua luce
Che largo rida ove io sorrida appena
E forte ami ove io accenni a invaghirmi…
Vittorio Sereni
Aspettavamo quasi d’essere altri per l’accanita attesa di noi stessi.
Paolo Volponi
1. Gli occhi diversi
È cominciata prima di scendere nella stazione della metropolitana. Un’oppressione al petto. Una pressione ostinata che non è ma sembra dolore. Stavo aspettando un taxi. Invano. È la Settimana della moda. Avrei dovuto prenotarlo – i più previdenti lo fanno.
Così sono sceso nel metrò. Solo sulle scale. Solo ai tornelli. Sulle scale mobili. Solo sul marciapiede. Mi siedo sul sedile di granito. Dev’essere l’ultima corsa. Fosse già passato il convoglio qualcuno mi avrebbe fermato. Invece no. Cerco di rammentare se dall’ingresso in poi ho incrociato qualcuno.
Non soltanto è la Settimana della moda, ma mi capita di lavorare ai margini di quello che viene chiamato Quadrilatero della moda. Non so quanto sia rispettata la geometria, di certo sono abituato a percorrere strade in cui le griffe dettano l’identità dei luoghi. E spesso mi è successo di pensare che in fondo mi muovo dentro una galleria che, forse più di un museo d’arte contemporanea, sa sciorinare bellezza. Sarà che ho il sangue di una sarta, ma non posso non subire l’intermittente incantesimo del tessuto diventato forma e della forma diventata promessa di corpi senza corpo. In una notte come questa, ma deserta, ma fredda, ma silenziosa, percorrendo una delle vie del Quadrilatero, ero stato letteralmente assalito dalla poesia altèra e soffice di una creazione (come non pensare che in sartoria il termine “creazione” sta proprio a indicare l’abito concepito e realizzato?) che, quasi affrancata dal manichino minimalista che le offriva appoggio, si apriva dentro le luci, nello spazio altrimenti buio della vetrina, come una sonata di proporzioni e colori. C’era qualcuno che avrebbe potuto indossare quella creazione? Forse sì. Ma in quel momento, non c’era umanità a cui fosse destinata, quantomeno non dell’umanità visibile che mi era nota. E allora pensavo che Milano fomentava bellezza, bellezza cattiva, aristocratica, figlia della ricchezza, ma pur sempre bellezza. Restai a lungo davanti a quel disegno sofisticatissimo diventato gesto. Era solo nella notte. Ero solo io stesso. Milano aveva continuato a cercare grandezza. Aveva creato nuova ricchezza. Sentivo che la Milano di mia madre rubava spazio a quella di mio padre. Ma non era più la Milano di mia madre. Né tantomeno quella di mio padre.
E d’altro canto io avevo rinunciato all’una e all’altra. Adesso sono lì, mentre la bellezza cerca, sopra di me, di diventare ricchezza, e viceversa.
Mi sembra di distinguere un suono in fondo alla galleria, ma in realtà viene da sopra, forse è il treno che va nella direzione opposta che sta entrando in stazione.
Com’è che tutto a un tratto il mondo si fa lieve? Com’è che questo antro si acquieta e mi acquieta? Fino a un’ora prima ero nel caos a cui appartengo, insieme a gente tanto riconoscibile da essere diventata estranea, minacciosamente estranea. Sedevo nella convivialità di una serata mondana cercando di ritagliare segmenti possibili di conversazione, e per farlo continuavo a cambiare posto e interlocutore. Non ho neppure il conforto dell’alcol, non posso contare sulla minima ginnastica del bicchiere perennemente carezzato dalle mani a conchiglia. La fantasmatica esistenza dei funzionari nel primo secolo del nuovo millennio. Senti un magnificar di tecniche. Ma siamo in un antico bestiario. E così sorrido ancora. Sorrido in questa pace sospesa. Si tratta solo di attendere. Semmai torno fuori e mi rimetto a caccia di un taxi.
All’idea della caccia vedo la notte luminosa che sopra di me ha appena cominciato a brulicare di bêtede-mode. Si spostano da un albergo all’altro, da un locale all’altro. Attendono autisti, perlopiù. Ma l’esercito si muove con le vetture di piazza.
Proprio su questa stessa linea della sotterranea ho incrociato nel corso degli anni tante modelle, tanti modelli – sono almeno vent’anni che si muovono dalla periferia verso il centro con i loro book sotto il braccio, con i loro corpi belli e uguali, con la stessa allucinata indifferenza. A volte siedono l’uno accanto all’altra e commentano le rispettive foto – chi te l’ha fatta, la resa del Photoshop, il fondale, i capelli acconciati, cosa bisogna mettersi, nuda è meglio, nudo è meglio. Quasi non sorridono neppure quando fanno una battuta. Sono americani, sono russe. I maschi perlopiù americani, le ragazze perlopiù russe. Mi è capitato di vederli uscire dai residence che occupano in periferia. Chilometri di finestre che danno sull’autostrada. E gli altri chilometri verso la triste campagna senza campagna – monconi di cascine, motel, piccole fabbriche, magazzini.
Oggi è la loro festa. Forse tornano a casa a piedi, forse sono già saliti sull’ultimo treno, quello che comincio ad avere la sensazione di aver perduto. Perduto. In quella pace mi disfo del rancore e comincio ad avere qualche certezza.
Quanto ho detestato, e per quanto tempo, quelli che pretendono di capire – ma dovrei dire quelli che hanno sostituito la complessità del capire con l’efficienza, la funzionalità del capire. Io li ho visti, con l’espressione apparentemente morbida del disporsi a comprendere, esibire il progetto, declamare (ma senza retorica, giacché della retorica si protestano nemici) i punti del programma.
Cosa succedesse oltre la soglia di quel capire, non era dato sapere, giacché la loro saggezza era per definizione non condivisibile. Utilizzavano le mosse della filosofia per arrivare a un luogo (ma si trattava di un luogo?) che aveva forse a che fare semplicemente con l’esercizio del potere.
Li ho appena lasciati nel sovramondo milanese, questi compagni, forse alla ricerca di un taxi ma molto più probabilmente intesi a lasciare qualche traccia di sé su signore sensibilizzate alle ragioni di quel capire.
Ma da qui il sovramondo suona persino buffo, suona buffa l’esistenza che ho fatto, e c’è qualche traccia di comico anche in questo totale silenzio. Ed è proprio silenzio? Ripeto come un mantra che non esiste il silenzio, che non si rompe, che non ha rumore. Ma adesso cosa dovrei dire?
Qui non è rimasto più nessuno, qui nulla si muove, eppure mi sembra di sentire la luce friggere, mi sembra che dal fondo del tunnel arrivi un alito musicale, c’è anche della carta che svolazza fra la banchina e i binari, e schiocca o plana o rotola. Io stesso sono suono. Il cellulare. Perché non uso il cellulare?
Appena sopra la mia testa si sta celebrando una festa, con piglio serissimo si fa festa nel cuore di un disastro. E qui sotto è tutto così in pace, così lontano dalla danza di entrate e uscite davanti agli hotel. Sopra, la bellezza cerca lo splendore. E lo splendore è quello che si immagina un bambino, perché luccicano i vestiti, luccicano gli occhi, luccicano le sale interne, i padiglioni, gli hangar, il treno sulle passerelle.
Ho giocato all’approssimazione fino a qui, e mi è piaciuto farlo. Ho fatto finta di sapere che sapevo e ho fatto in modo che si credesse che fingevo di non sapere. Che esercizio, che perizia. Ma adesso non ha neppure un gran senso questo cedere alla confessione, adesso è troppo tardi e suona ridicolo. E del resto questa forma di santità che sento destarsi in me e distendersi come fosse una garza, che posto avrebbe in una tardiva confessione? Forse sono già stato perdonato, sono già stato assolto.
Probabilmente è qui che dovevo arrivare, in fondo a questa galleria, anzi dentro questo tunnel, e a godere di questo riposo che mi tiene gli occhi aperti. Vedo bene dove sono, vedo come la luce artificiale occupa con discrezione tutto lo spazio di sicurezza, mi dico perfino: non può accadermi nulla, anzi nessuno può farmi del male. Finché resto qui nessuno può farmi del male.
È una sensazione che mi è capitato di sentire sdraiato in un letto pomeridiano, fra veglia e sonno, fuori la luce, ma difeso dagli scuri, fuori il suono della città diurna, ma ottuso dalla distanza. Mi è capitato in certe stanze di alberghi anonimi ma eleganti – un nowhere sfibrato da una stanchezza, da un torpore senza causa. Il fatto è che ora non dormo e ho una nostalgia passiva della meta.
Guardo verso la bocca del tunnel e ne arriva un suono senza suono. Io non sono un temperamento tragico. Forse mi sarebbe piaciuto, ma non è così. Dunque sto in questa assenza di moto con una nonchalance che sfiora il comico – qualsiasi cosa stia accadendo, mi dico, non può capitare a te. Mi riconosco privo degli strumenti per farne un che di nobile e maestoso. Non posso lasciarmi credere di sapere quello che non so, non posso farlo con me, quando invece quello è stato il mio costume, ma più che costume naturale inclinazione. E dunque per non mentirmi obbedisco al durare dell’abbandono.
Ho accompagnato per tutta la vita le dame e i cavalieri che mi hanno ispirato, e a dame e cavalieri ho dato spesso modo di pensare, e con successo, che andavamo per la stessa strada. Mentre lo penso, sento quasi uno strappo, vorrei veramente levarmi in piedi e trovare l’uscita perché quello, quello soprattutto, è stato il mio modo di amare. Creare i dintorni, inventare strade di avvicinamento. Mettere nelle condizioni e mettermi nelle condizioni. Nessuno avrei voluto veramente essere. E di nessuno avrei voluto veramente portare le armi. Lo scudiero era una tentazione, ma non sono mai stato tanto diligente. Anche le regole, i giuramenti, anche quelli erano avvicinamento e non sostanza. Eppure che prossimità. La sfumatura di comico comincia dove era inevitabile stare nell’azione comune. Ma una cosa per volta.
C’è stato un momento in cui è cominciato tutto, se a questo tutto vogliamo attribuire una sobria relatività. Ma è certo che da qui, da dove ora sono, è come se la visione del momento fosse netta come una rivelazione. Sopra c’è la città dove ho cominciato a imparare. Ma imparare è solo apparentemente legato al “cominciare”. L’avrei mai detto? Il momento non ha nulla a che fare con l’infanzia. Torno indietro, senza sprofondare.
Certamente si trattava di una primavera. Io ero là in mezzo a quella primavera e a questa stessa città. A vederla da qui sembra solo un sussulto di gioventù. Magari fosse così. Emergevano visioni nette come mattine, sentimenti eccessivi e luminosi come versi di Hölderlin, promesse cristalline fatte a se stessi, fatte ad altri, fatte al nemico. E il bello era che il mondo pareva, in tutta la sua magnificenza, solo temporaneamente in mano al nemico. Fu l’idea del nemico a muovere l’intelligenza, a premere, a forzare decisioni, a dividere ma non di meno a unire, come sempre fa l’idea del nemico. Ma allora – e nella scena che mi vede tornare come a un cominciamento – il nemico era ancora tutto impastato con il cambiamento che ciascuno chiedeva a se stesso.
Uscivo da un bar senza aver consumato, qualcuno salutava, qualcuno sarebbe rimasto chissà fino a che ora, sarebbero passati dalle considerazioni sul cineclub appena nato alla linea del gruppo a cui appartenevano. Pietro era convinto che saremmo tutti morti in dieci anni, e non per le battaglie contro i padroni: non ci rendevamo conto che le risorse si stavano esaurendo o che comunque non c’era più un luogo veramente selvaggio? Eccolo lì, il nostro Rimbaud. In Africa, in Africa. «Ma l’Africa non c’è più» – Marco era impietoso con l’amico Pietro, e Pietro ascoltava come un profeta stanco finché l’alcol non lavorava. Sono tutti in quel bar – piccoli tavoli mai puliti, sedie sparpagliate –, hanno spalle alte dentro maglioni larghi, le mani escono insieme al polso dalle maniche troppo corte e agitano eco di parole comuni. Ragazze ce n’è poche, quasi tutte sullo sfondo, belle di una bellezza trasandata, acciaccata, se la passano quella bellezza come fosse una sigaretta. Qualcuna ha occhi che scavano nella nebbia del fumo, e vuole un’aura assoluta, ma perché appaia, perché sia vera, un consenso che a volte è il bacio del ragazzo con cui è risaputo che sta, e a volte è il pensiero con cui si astrae, come succedeva in quel momento a Marina, sulle labbra il motivo di una canzone, Winter spring summer or fall, all you’ve got to do is call…
Questo nel caldo di quell’anfratto, da cui uscivo con il conforto che quando fossi ritornato avrei trovato tutto così come lo lasciavo. Lì, imparavo il rispetto e la considerazione che si impara per i coetanei, quando hai vent’anni. Marco, che allora era compagno di una ragazza francese, bianca come il burro, non era propriamente un leader, in quel tempo di leader, ma una figura che gli somigliava. Per esserlo, gli mancava il gusto della costruzione di una linea. «Sono luxemburghiano», gli piaceva ripetere, e con questa dichiarazione si tagliava fuori, senza escludersi, voleva guardare più lontano e di quello sguardo si accorgevano in molti.
Sarebbero rimasti fino a tardi, forse tardissimo, non avevano il tempo contato. Io invece sì. Dunque guadagnavo la strada verso casa stringendomi nel cappotto nuovo, blu, taglio classico, che Marco aveva subito battezzato “cappottino borghese”. Era difficile distinguere fra appartenenza di classe e spirito rivoluzionario. La mia famiglia era proletaria, per reddito, per collocazione, per costituzione, quella di Marco borghese, ma lo spirito rivoluzionario era dalla sua parte. Mi portavo addosso, e il mio cappottino blu ne era la testimonianza irrefutabile, gli orpelli del decoro, segnali di una cauta ambizione piccolo-borghese. Era molto più complicato di così, ma era quanto bastava a farmi sentire a disagio in quel taglio di sartoria.
Me ne andavo con un rammarico doloroso. Era uno strappo ma non dovevo mostrarne i segni. Lasciavo un mondo e me ne andavo in un altro. Non conoscevo altro che la strana febbre del ritorno perché in entrambi continuavo a far ritorno.
Fra il corridoio e la camera da letto dei genitori trovai mia sorella, scivolata a terra, le gambe piegate senza eleganza sotto di sé. Piangeva, anzi martellava di singhiozzi una stessa frase: «Mi fa male».
Che cosa le facesse male lo sapevo bene: apparentemente la proibizione di uscire quella sera, più in generale la sensazione di aver perduto una sua personale battaglia.
Mio padre la consolava: «Non c’è nulla che possa farti male nella tua famiglia», e con un gesto secco e imperioso faceva cenno a mia madre di allontanarsi.
Questo era il luogo a cui facevo ritorno. Solo un’ora dopo, a tavola, mia sorella avrebbe sorriso, avrebbe sorriso con rassegnazione, ma anche rassicurata davvero, che nessun male si poteva sentire, nel cerchio della famiglia.
Io dovevo raccontare qualche episodio di vita universitaria e l’avrei inventato.
«Quel che fate è giusto. Ma dovete studiare.»
Mio padre alludeva agli scontri di cui leggeva sui giornali o sentiva al telegiornale.
Era cresciuto nella consapevolezza storica della lotta di classe, ma era altrettanto convinto che a conferire più saldezza alle battaglie dei lavoratori erano necessari i valori del lavoro e della famiglia. Peccato che fossero, quei due valori, fortemente compromessi, là da dove venivo. Guardavo mia sorella che dal suo piatto spiava me, il fratello più giovane, indecisa se invidiarlo o riconoscergli una qualche risorsa utile anche alla sua sofferta rassegnazione.
«Tu sai chi era Rosa Luxemburg?» chiesi a mio padre.
Lo sapeva, naturalmente. Sapeva che l’avevano uccisa, che con la sua morte in Germania la lotta era finita, che poi sarebbe arrivato il nazismo.
«Era una donna», dissi.
«Una donna che ha sacrificato la sua vita ai suoi ideali», fece lui.
«Una donna libera», continuai, e fissai mia sorella che abbassò subito lo sguardo.
Mio padre appoggiò la mano destra sul tavolo insieme al cucchiaio. Mia madre restò con il suo immerso nella minestra.
«Che cosa ha scritto Rosa Luxemburg?»
«L’accumulazione del capitale», dissi.
«L’hai letto?» chiese brusco.
«Non ancora.»
«Leggilo. Poi ci spieghi come la Luxemburg è diventata una grande rivoluzionaria.»
Sullo schermo della tv rimasta accesa passavano immagini di ballerine con ampio piumaggio sul fondoschiena. Un presentatore in smoking apriva lo show del sabato sera.
Mentre mia madre sparecchiava e mia sorella le dava una mano, lasciammo parlare il presentatore.
Suonò il telefono.
«Chi chiama a quest’ora?» fece mio padre spazientito.
«Un mio amico.»
«Un tuo amico che per noi non ha un nome?»
«Marco», dissi, e intanto risposi: «Marco? No, stasera non posso. Ci sentiamo domani».
Riguadagnai la mia postazione. Mio padre non chiese altro. Mia madre dava colpi d’ago all’orlo di una camicetta. Il mento appoggiato alle braccia conserte sul tavolo, mia sorella guardava la tv e tutto il suo male sembrava cancellato.
Dunque erano primavere. Nell’atrio della stazione dove arrivava quando scendeva in città, Marco mi aspettava, sigaretta in bocca, giacchetta di pelle lisa, blue-jeans e mocassini neri. Scendeva tutta la Brianza, scendeva tutta la Milano Nord ed era una vera folla vestita a festa in cui avremmo potuto sentirci comodamente degli infiltrati. Era una condizione che avevamo imparato presto. Era un dato di fatto, quasi una dotazione generazionale. Gli “altri”, e poi questo “noi” che si apriva e si chiudeva, che assimilava ed escludeva, che si gonfiava e si assottigliava.
Ma era domenica, che apparteneva agli “altri” e ci si poteva entrare, la si poteva visitare, persino condividere.
Io portavo sempre il mio cappottino leggero, il mio cappottino borghese, e mi ci stringevo dentro come se l’inverno non dovesse scivolare dentro quella luce di primavera. Tenevo le mani in tasca quasi volessi deformarlo, e ascoltavo Marco che raccontava del villaggio aziendale oltre i confini suburbani di Milano in cui risiedeva la sua famiglia.
Stavamo provando a vivere, no?
Ma forse lui ci stava provando come fanno i ribelli naturali, con più concentrazione, con più scioltezza drammatica. Diceva che Adriana era innamorata di lui, Adriana borghese come il mio cappotto, anzi ben di più, e gli piaceva lo scompiglio che sentiva in quella ragazza che era già fidanzata e frequentava le buone famiglie dell’imprenditoria lombarda. Io l’avrei conosciuta più tardi ma nei racconti di Marco appariva, come di fatto era, bella ed elegante, una ragazza con gemelli di cachemire e gonna a pieghe. Lui diceva come lei si tormentava, come non voleva scombinare i piani famigliari, come lo aspettava tra la fermata degli autobus e un certo bar lasciandosi calare davanti alla faccia i lunghi capelli castani per poi scostarli e sorridere. Lui insisteva molto sul sorriso di Adriana, perché, diceva, erano le sue labbra a confessare il desiderio, a deciderlo, a disegnarlo, di fronte a lui. Diceva proprio “deciderlo”, “disegnarlo”, e io lo vedevo quel desiderio. Che forse era più netto, più caldo, perché Adriana non avrebbe dovuto provarlo, né tantomeno coltivarlo. Marco si commuoveva al pensiero di Adriana che lo baciava forte, disperata. Era convinto che fuori dal suo ambiente borghese Adriana si sarebbe spenta, che non avrebbe retto l’attraversamento del confine.
Marco mi parlava di qualcosa che distinguevo bene ma non mi apparteneva in quella maniera e con quegli accenti. C’era un che di struggente nel suo raccontare, e non mi rendevo conto di quanto il racconto dilatasse la sua esperienza, e di come dilatandola la facesse entrare in un orizzonte più grande, che era poi quello che scivolava nel nostro “noi”, nel mondo che cambiava forse più di quanto lo volessimo cambiato.
Avevo conosciuto molte ragazze “di” Marco, molte le abbandonate che non lo abbandonavano.
Nessuna d’altro canto era stata o sarebbe stata davvero la sua ragazza. Gli piaceva citare il Foscolo, non dei versi o dei passi particolari, lo citava per come immaginava che sapesse amare le donne. E il poeta si liberava dal curriculum scolastico.
Marco sapeva far saltare la logica delle cose.
Anche studiando Architettura, era questo che faceva.
Mi raccontava di Ulitsa Rossi a San Pietroburgo, dove era stato con la famiglia.
«Tutto artificiale, tutto vivo.»
Tracciava segni nell’aria. «Una stradicciola. E invece. Tutto lo spazio occupato dalla grandezza. E dal silenzio. Architettura per una città che prima non c’era, per una società che non c’era, e ora era forzata a esistere. Dentro quelle misure perfette. 22 x 22. 220 metri di lunghezza. 22 colonne su o...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Prima di cominciare
- Uno sguardo dal ponte
- UN’EDUCAZIONE MILANESE
- IN QUEL TEMPO
- CODA
- Indice