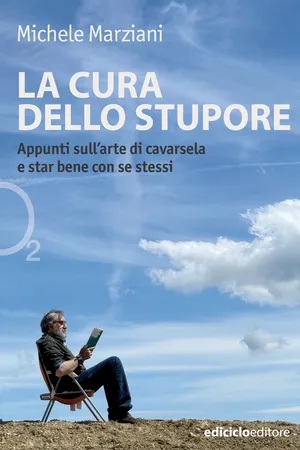
- 160 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Lo scrittore Michele Marziani ha fatto una scelta importante: quella di andare a vivere in un piccolo paese di appena duecento anime tra i monti della Valsesia, in una casa di legno e pietra. Un ambiente selvatico e, all'apparenza, difficile. Ma a volte è proprio in uno stato di privazione, di essenzialità, che si fanno nuove e sorprendenti esperienze.
La rivelazione della solitudine come valore e occasione per riscoprirsi, la paura come strumento utile per conoscere i propri confini, lo stupore come nuovo punto di vista per leggere il mondo, gli hanno insegnato l'arte di cavarsela. I libri e la ricchezza offerta dalle parole gli hanno curato l'anima.
Ritornare a se stessi, ai desideri semplici, alle erbe offerte dalla natura, a una sana condivisione con gli altri, significa vivere meglio, più felici, più forti, più veri.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La cura dello stupore di Michele Marziani in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Crescita personale e Viaggi. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
SEGNALI
La via del silenzio
Le erbe mi hanno indicato una strada in un brutto momento per tutti, all’inizio di un periodo di malattia collettiva. Di epidemia. Di pandemia. Più altre parole inventate o riscoperte per l’occasione.
È stato quando la prima volta, per un tempo lunghissimo, ci hanno detto di non uscire più di casa. O meglio di non allontanarci dalle nostre abitazioni. La cosa non mi ha infastidito: vado malvolentieri altrove, anche se per lavoro, per presentare libri, per amore, per seguire affetti e amici, mi capita spesso di spostarmi, di viaggiare.
Nel piccolo paese sulle Alpi dove vivo, l’edicola era chiusa e a me non piace tenermi informato attraverso la rete o la televisione, nemmeno la radio mi soddisfa. Preferisco i giornali di carta, non tanto per l’odore dell’inchiostro, ma perché le notizie, le informazioni, i commenti hanno tempo di depositarsi sul foglio, creano distanza dal momento della scrittura a quello della fruizione.
Non gridano, non spaventano, parlano. E quando le parole, le informazioni si fanno difficili, o viene sonno, basta piegare la pagina e appoggiarla a lato del divano. Si può sempre tornare a riaprirlo, il giornale.
Certo, le notizie sui quotidiani non sono immediate, né tempestive, ma sono fragranti, direi più buone. Comunque l’edicola era chiusa e quindi ci ho messo un po’ a scoprire che a me, come a tutti, avevano detto di restare in casa.
Mi sono organizzato così la vita al telefono, coi messaggi video, scrivendo e ricevendo lettere sotto forma di mail. Per un po’ mi è rimasta anche la possibilità di andare a pescare. Quel correre al fiume all’alba a stanare solitario le trote in caccia alle prime ore del giorno. Poi la pesca è stata vietata ed è rimasta chiusa per qualche mese. Avrei voluto domandarmi il perché, pormi tante questioni, capire. Ma tutto era troppo veloce, selvaggio, complesso.
Successivamente l’incrociarsi in rete, su Internet, sui social, di pensieri, parole, idee, affetti a distanza mi ha stufato. Ero stanco.
È difficile che qualcosa o qualcuno venga a salvarti mentre sei indaffarato. Questo lo so da sempre, se ti senti soffocare occorre fermarsi. È l’unico modo che conosco per trovare una via d’uscita, una strada che ti ridoni il respiro. È anche inutile cercare risposte, per trovarle dovresti conoscere le domande. Anche questo l’ho imparato dai mondi dai quali provengo, in particolare dal giornalismo: il quesito vale più della replica; perché a domanda sbagliata corrisponde sempre risposta sbagliata. Non mi stancherò mai di dirmelo prima di pormi o di porre un qualsiasi interrogativo. La buona domanda, ho imparato, presuppone empatia, conoscenza e cultura. Senza una di queste tre gambe la richiesta zoppica, la risposta inciampa. Si crea un caos, magari divertente, ma dal quale è difficile uscire. Meglio fermarsi allora. Fare il vuoto. Niente pensieri. Come nelle meditazioni orientali. Lasciare spazio alla noia. All’attesa. Ma per arrestare frenesie, dubbi, inquietudini, preoccupazioni, affanni, idee più o meno sensate, occorre qualcosa. Una tecnica. Un’occasione. Un pensiero che si faccia strada sugli altri. Un’abitudine.
Davanti a casa
Così per fermarmi, per trovare respiro, ho cercato casa nell’unico luogo dove mi sembra di sentirmi cittadino. Tra i libri. Ne avevo in mano uno importante, almeno per me, Il paese delle vocali, di Laura Pariani. Mi ricorda, ogni volta che lo riapro, di un tempo nemmeno troppo lontano – siamo nella seconda metà dell’Ottocento – in cui ancora non sapevamo leggere e scrivere. Almeno non tutti. Non era ovunque la lingua dentro la quale viviamo. Esistevano i dialetti, le parlate vernacolari. L’italiano era altro.
Lo rileggo spesso questo libro perché le vocali della Pariani sono per me un balsamo di comprensione, mi aiutano a capire il mondo. Certo, non come l’Iliade o la Bibbia dove ci sono le risposte a tutto, ci mancherebbe, ma al pari di Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut che però è tutta un’altra cosa.
Comunque, fermandomi con quel libro in mano, la voce della maestra Sirena Barberis – A come arto, E come erto, I come irto, O come orto, U come urto – mi suonava meno dolce, meno fiabesca di altre volte. La mente era stanca. Il divieto di allontanarmi da casa mi stava minando il cuore.
È stato lì, seduto sul gradino davanti alla porta, nonostante l’aria gelida che mi costringeva a leggere incassato dentro al maglione dal collo alto, che ho alzato gli occhi: davanti a me erano spuntate alcune primule. A differenza di altri fiori questi li conosco perché piacciono a mia madre. Appartengono, al pari dei ciclamini e dei nontiscordardimé, alla formazione familiare, alle cose imparate durante l’infanzia.
Subito ho fotografato le primule e ho inviato l’immagine a mia sorella, che la stampasse e la girasse alla mamma. Così si fa oggi di fronte alle cose. Invece di ammirarle a bocca aperta, si immortalano e si condividono con qualcuno. Spesso, nel frattempo, si rischia persino di perderle. Almeno è quello che capita a me che non amo le fotografie, anzi, un po’ mi annoiano, sono come le figure nei giornali. Sovente servono solo a riempire i buchi. Per uno che ama le parole sembrano quasi tempo perso. Guardando i fiori ho pensato cosa sapevo delle primule e mi è venuto in mente che una volta avevo letto che sono commestibili. E pure buone.
Un mondo scritto
Ecco, qui occorre una precisazione: vivo in un mondo scritto, per me esiste solo quello che leggo. Perché le parole le puoi cercare e ricercare ancora. Ci sono sempre. Non mutano come il tempo, l’ora, il paesaggio, le stagioni, l’umore. Una volta scritte sono lì, le rintracci ogni volta nel medesimo posto, in fila nello stesso modo. Dentro alle parole ho sempre trovato quello che mi serve, o, almeno, tutto quello che so. Imparo dai libri. Viaggio e cerco i luoghi perché li ho visti sulle mappe. Guardo i fiori solo perché qualcuno me li ha raccontati in qualche pagina. La prima camelia con la quale mi sono incontrato è stata dopo Alexandre Dumas, prima le camelie erano soltanto dei fiori, se lo erano, neppure ci facevo caso.
Ho questo rapporto strano con la vita. L’ho sempre avuto, da quando so leggere. Senza immergermi nel libretto delle istruzioni, una lavatrice per me è un cubo di ferro smaltato. Dopo, divento bravissimo a utilizzarla.
Agli aeroporti, nelle stazioni, negli uffici pubblici, negli ospedali, so sempre cosa occorre, cosa si deve fare. Lo so perché mentre arrivo leggo tutto: cartelli, foglietti appesi, circolari, bigliettini adesivi, correzioni e appunti scritti a penna…
Ho pensato a lungo che leggere il mondo, anziché osservarlo, potesse essere una malattia, qualcosa di cui preoccuparmi, poi ho deciso che non lo è, o, se lo è, non è grave. L’ho capito quando ho saputo che gli zingari, i gitani, i girovaghi, imparano a leggere attraverso i cartelli stradali. Per questo, spesso, sanno esprimersi solo in stampatello.
Questa cosa che la primula si mangia, l’avevo letta. Anche se non ricordavo dove. Così sono andato a cercare qua e là tra le pagine e ho trovato pure le ricette.
Il nonno erborista
Allora sono uscito di casa, quel poco che mi era concesso, c’era ancora qualche lingua di neve, ho cominciato a risalire un pendio verso il bosco. Il giallo delle primule è stato il segnale che anche questa volta ce l’avrei fatta.
Per due o tre giorni non ho mangiato altro. Ho fatto frittelle e insalate. Poi sono spuntate le viole. Se n’è andata la neve. Ha fatto capolino il tarassaco. Allora ho cercato un volumetto, stava nella memoria, dovevo averlo da qualche parte. Infatti c’era: Dosaggio delle erbe, si intitola. Ma non è un libro, bensì il taccuino di Domenico Tommaso Marziani, il nonno Tommaso, classe 1891, capostazione e per diletto erborista.
Sfogliare quelle pagine è stato come scoprire un destino. È stato il riaprirsi di un piccolo vaso, quasi nascosto, di ricordi fatti di capperi raccolti col nonno lungo le mura di città o la camomilla trovata in collina e messa a seccare al sole sui setacci.
Ho ordinato per posta altri libri sulle piante, mi sono arrivati, ho cominciato a leggerli. Poi a portarli con me. Nel giro di pochi giorni il mio mondo si è popolato di ortica, verzola, acetosella, piantaggine, grespigno, borsa del pastore, alliaria, lattuga selvatica, cicoria, aglio orsino, cardo asinino, ambretta, erba brusca, bardana, raponzolo, melissa, profumatissimo mentastro verde… Ho cominciato ad arricchire l’insalata con i germogli di abete; a immaginare frittate con i giovanissimi getti di rovo. E la primavera era solo agli inizi.
Girare intorno a casa armato di guanti, forbici e libro mi stava salvando per l’ennesima volta la vita. Sentivo guarire piano piano ogni ferita di lontananza. Non che venisse meno il dolore, ma quel dolore si stava trasformando. È inutile cercare di dominare l’assenza, la sofferenza, l’inadeguatezza, se non puoi intervenire e modificarli. Li avevo trasformati in raccolti: in zuppe, in frittate, in sacchetti di ortiche seccate da regalare agli amici, in grappe aromatizzate per riscaldare la sera, in vini medicati dagli effetti corroboranti. Ma anche in idee balzane come quella di fare bevande del passato, intrugli da mago e da druido. Cose che poi trovano posto pure nei libri da scrivere.
Non per caso
Sì, sì, già sento il borbottio di chi nello stesso periodo è rimasto rinchiuso nelle città. Così è facile. Cosa ci vorrà mai a cavarsela se intorno hai tanta natura, infinita bellezza, aria pulita, nessun vicino?
Allora un po’ sorrido ripensando a uno dei miei figli che nello stesso periodo in cui non si poteva uscire di casa, vivendo lui in città, il pomeriggio si vestiva di tutto punto, pure elegante, per andare sul tetto, un giorno a suonare il violino, un altro a leggere La luna e i falò di Cesare Pavese. Ma non basta, lo so. Nelle città alveare non tutti hanno il tetto, qualcuno neppure il terrazzo. Molti hanno i vicini antipatici che non abbassano la televisione. La spesa al supermercato era una processione dolente di tristezze.
Ho la brutta abitudine, di primo acchito, di sentirmi in colpa nei confronti di chi sta peggio e di provare la contemporanea sensazione che tutti abbiano diritto a star meglio di me. Credo si chiami educazione cattolica. Poi però mi riprendo, lavo il senso di colpa con una sciacquata alle mani, e cerco di andare al cuore delle cose. A sentirlo pulsare. Ad ascoltarne il ritmo, il suono, la potenza. Una profondità capace di allontanare ogni brusio o rumore di fondo.
Così penso che qui dove vivo – dove attorno a casa raccolgo le erbe – non ci sono nato. Ci sono arrivato. Non per caso. Quindi la fortuna non c’entra, se non marginalmente, nella riuscita, ma non nella scelta. Ammesso che uno debba pure sentirsi in colpa per aver avuto fortuna.
Qui non ci sono arrivato per caso, stavo dicendo. Avevo...
Indice dei contenuti
- Copertina
- L’ultima volta mi hanno salvato le piante...
- SEGNALI
- ASSENZE
- AVERE
- DIRE, FARE
- OLTRE
- CASA
- FINIRE E RICOMINCIARE
- RESISTERE
- CONSERVARE
- INSEGNARE, IMPARARE
- ARRIVARE
- MERAVIGLIARSI
- ORDINE
- Potresti anche leggere
- Indice