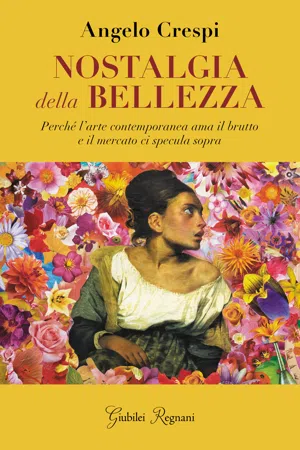![]()
Nostalgia della bellezza
“Nostalgia della bellezza” è il titolo che lei ha proposto per questa conversazione sull’arte contemporanea. Per quale motivo?
La parola “nostalgia” ha una forte carica semantica. Dal punto di vista etimologico contiene i termini greci nostos che indica il viaggio per fare ritorno a casa e algos che significa dolore: insieme stanno a significare il desiderio quasi doloroso, malinconico, di tornare in patria, considerando la bellezza una patria, la nostra patria. Elias Canetti ha scritto, in un esergo, che «la nostra patria è una lingua» e forse aveva ragione perché ci sentiamo a casa non tanto in un luogo determinato, piuttosto quando sentiamo intorno parlare la lingua materna. Ma anche la bellezza deve essere considerata patria pensando al patrimonio artistico che abbiamo ereditato dai padri e che per noi italiani è un giacimento di identità e di senso. Più latamente, la bellezza ci rassicura, ed essendo noi uomini gettati nel mondo, spaesati, abbiamo bisogno di creare spazi di senso per abitare e sopravvivere. Aggiungo che io provo soprattutto nostalgia per la bellezza futura.
Mi sembra un ossimoro, nostalgia per una cosa futura.
Sì, mi piace l’idea di provare nostalgia per il futuro. È tipico della figura retorica dell’ossimoro la frizione che si genera dall’antinomia dei due termini in contrasto e che, a sua volta, si esprime in un cortocircuito semantico perché uno dei due componenti esprime una predicazione contraria o contraddittoria rispetto al senso dell’altro: di solito si prova nostalgia per una cosa passata e perduta, non per una cosa futura. Proprio per la costituzionale paradossalità l’ossimoro produce uno stupore cognitivo che induce alla riflessione o, almeno, a una seconda attenta lettura della frase che lo contiene.
È un titolo reazionario.
Direi rivoluzionario visto che la bellezza è stata bandita dal territorio dell’arte e dunque mi sembra lecito battersi per un capovolgimento dello stato delle cose. Mi sembra giusto riconquistare la patria.
Oggi chiunque parli di bellezza viene però criticato come reazionario.
Tecnicamente io lo sono: reagisco al brutto che mi circonda e che mi duole in senso fisico. Non posso essere biasimato se reagisco a un sopruso, e quello del brutto rispetto al bello è un vero e proprio sopruso a danno dell’uomo e dell’umano. Nella contemporaneità rischiamo di dimenticare molte tracce della bellezza del passato e rischiamo di perdere la capacità di produrne di nuova e di godere di quella esistente. Perfino la bellezza minuta del paesaggio, perfetta compenetrazione tra natura e arte, che tanto ci conforta è a rischio o di distruzione o di imbalsamazione attraverso il pittoresco che è una cristallizzazione patetica e sentimentale del bello. Nelle terre del Leviatano, annotava Ernst Jünger, regna il cattivo gusto.
C’è però il tema di sembrare dei passatisti, nostalgici appunto.
La bellezza non è mai passata. Nelle metamorfosi perenni del Tempo rinasce in nuove forme che sempre percepiamo d’incanto, se le sappiamo cogliere. Io non ho nostalgia di una particolare bellezza, o della bellezza di un determinato evo, ho invece nostalgia della bellezza futura e desiderio di fare ritorno a casa, perché la bellezza è la nostra casa e dà senso e dignità alla vita.
Dunque una nuova bellezza?
Non una nuova, ma di nuovo bellezza: ogni epoca ha prodotto bellezza con la certezza che il bello fosse meglio del brutto. Gli stili e i linguaggi si modificavano o si ripetevano, ma resisteva l’idea che si potessero creare cose belle e significative e l’arte era appunto la disciplina in cui ci si adoperava per questo. Noi siamo la prima civiltà che preferisce il brutto al bello. Trovo singolare che si venga dileggiati allorché si critichi questo slittamento, etico prima che estetico.
Forse perché la bellezza in passato era intesa come un adeguarsi a regole precise e questa costrizione nella modernità è stata vissuta come un fardello insopportabile.
Può essere. Le regole proposte dai filosofi della Scolastica, l’integritas, la proportio, la claritas – cioè l’integrità dell’opera, la proporzione che deve esserci tra le parti affinché ci sia appunto integrità, e infine la visibilità che dà luce al tutto – sono uno schema troppo meccanico, ma se ci pensiamo bene quando mi approccio a un quadro, foss’anche un quadro astratto o informale, o ad una porzione di paesaggio, il mio sguardo è appagato se può coglierlo per intero in un colpo solo, cioè se le parti formano un tutto, e poi se in esso troviamo qualche proporzione tra le forme o tra i colori. La stessa cosa vale per l’architettura: mi rispecchio in un edificio classico in cui gli elementi stanno sensatamente in armonia tra loro, magari occhieggiando alla sezione aurea; resto disorientato quando invece guardo un edificio moderno del decostruttivismo, magari stortignaccolo, disassato, o piegato senza un apparente motivo.
Quindi valgono ancora le regole della proportio, dell’integritas, della claritas?
La neuroscienza ci dimostra che siamo attratti e appagati dal bello, cioè quando riconosciamo nel mondo una cosa o una persona che risponde a certi criteri inconsci, addirittura biologici. Io però preferisco parlare di “perfezione”, intendendo il termine perfetto nel suo senso etimologico, da perficio, di “portato a termine”. Quando l’opera d’arte è perfetta, cioè è portata a termine nel modo che doveva essere portata a termine, allora risplende la bellezza, perché nulla si può aggiungere o togliere senza che se ne accresca inutilmente o peggio se ne diminuisca l’insieme. Non è dunque la bellezza dell’oggetto rappresentato a fare bella l’opera, ma il modo in cui è rappresentato, cioè la forma. In questo senso l’arte visiva, attraverso la compostezza della forma e il suo risplendere, non solo in senso apollineo ma anche dionisiaco, può perfino rappresentare il brutto o il mostruoso emendandoli. E anzi credo che sia uno dei fini dell’arte, proteggerci dal brutto e farci meglio abitare il mondo.
Gli stili però cambiano e sembra cambiare anche la bellezza.
Gli stili cambiano, e in parte ogni epoca si adegua a una propria idea del bello, fermo restando che il bello è oggettivo, mentre a essere soggettivo è il nostro giudizio estetico.
Ne è sicuro?
A suo parere, le cose sono belle perché ci piacciono, o ci piacciono perché sono belle? Io risponderei che piacciono perché sono belle. Ma convengo con lei che la soggettività sembra irrimediabile, come aveva intuito già Saffo duemila cinquecento anni fa, scrivendo che la cosa più bella è ciò che si ama. Ma a pensarci bene noi amiamo una cosa appunto perché è bella, cioè per il decoro e la dignità che in essa rifulge.
Purtroppo nel contemporaneo tutto è cambiato. L’arte contemporanea esprime il brutto non per emendarlo ma per esaltarlo, il brutto che rimanda al brutto.
John Waters, un regista e artista americano molto trash, soprannominato the Prince of Puke, che non sto a tradurre, intitolò una sua retrospettiva “contemporary art hates you”.
«L’arte contemporanea ti odia» è un buon motto che chiarisce le posizioni in campo. Non siamo noi a odiare l’arte contemporanea, è l’arte contemporanea che odia noi. Anzi, l’arte contemporanea odia l’arte e talvolta odia sé stessa. Precisamente, odia l’umano. Assomiglia, in questa sua tensione apocalittica, all’ecologia radicale che intende l’uomo come un cancro della natura e vorrebbe sradicarlo. Certo, i metodi dell’arte contemporanea si proclamano meno cruenti, ma i fini simili: aborre la bellezza e il senso delle cose, predilige il brutto e l’insensato, e così facendo svilisce l’umano. Di fatto ci odia, odia le aspirazioni migliori della nostra civiltà, il nostro passato, la tradizione, l’idea di trascendenza.
L’arte contemporanea odia anche l’arte?
Odia l’arte della tradizione, sebbene se ne serva. Ma il confronto non è mai amorevole. Quando un artista contemporaneo lavora sulle persistenze iconografiche lo fa sempre in chiave dubitativa o dissacrante o ironica, oppure per ottenere un lucro di immagine: pensiamo alle numerose esposizioni in musei importanti non del contemporaneo, dove a fianco di opere celebri per la bellezza e significanza, viene esposto un pezzo brutto e insignificante. Il dialogo ingenera nel visitatore l’idea che anche la cosa orribile sia arte al pari del capolavoro. Il visitatore, benché spesso non capisca il senso di questi dialoghi tra antico e contemporaneo, si fida del museo e immagina che i conservatori siano tenuti a esporre “arte”. Uso il termine “lucro” poiché questo tipo di attività è un metodo di accreditamento per l’artista esposto e genera un vantaggio economico. Ma ci torneremo. E ancora peggio quando si tratta di arte pubblica. Qualche anno fa il confronto tra Jeff Koons e la scultura antica fu impietoso. La Pluto and Proserpina dell’americano, esposta in piazza della Signoria a Firenze, faceva l’effetto di un cartoccio, pretenziosamente dorato e buttato a caso accanto ai capolavori dell’arte di ogni tempo: non si distinguevano le forme, era sbagliato il materiale, non si coglievano i pieni e vuoti, difettava della “visibilità” di cui sono invece esempio corrusco il marmo del David e dell’Ercole, il bronzo del Perseo. E l’anno dopo, per sovrapprezzo, nella stessa fu posizionata una sorta di deiezione gigante dello svizzero Urs Fischer.
Intanto vale una precisazione, su cosa intendere con “arte contemporanea”.
Con “arte contemporanea” deve essere definita non tanto l’arte che ci è coeva, bensì uno stile che ha strettamente a che fare con l’arte concettuale, in cui si predilige il concetto all’opera, il pensiero al fare. E per questa ragione è il primo stile nella storia che tende al fatto male cioè al brutto.
L’arte contemporanea sarebbe uno stile?
Sì, uno stile legato a un tempo. O se vogliamo dire altrimenti, una categoria. Ci sono artisti vivi e dunque contemporanei che non vengono trattati come tali, anzi sono sbeffeggiati e commiserati in quanto passatisti, scontemporanei, anacronisti. Mentre ci sono artisti morti, anche da parecchi lustri, che si fatica a definire “moderni”, continuando a pensarli come “contemporanei” in quanto il loro lavoro ci sembra appartenere a quell’idea di contemporaneità ormai sedimentata in noi che, in definitiva, è uno stile preciso, con le sue regole, e come tale lo percepiamo. D’altro canto, viviamo in una sorta di “presentismo” per cui gli ultimi cento anni di arte, da Duchamp o almeno dalla fine della Seconda guerra mondiale, ci appaiono compressi nel tempo presente. Per cui la nozione di contemporaneità si dilata all’infinito, ricomprendendo anche il passato e non solo il presente e il futuro prossimo.
In che senso?
È chiaro: un artista che è stato “contemporaneo” non potrà che essere definito contemporaneo. Caravaggio, senza ombra di dubbio, fu in vita contemporaneo al proprio tempo, ma all’epoca non esisteva una teorizzazione dell’arte contemporanea. E quando a posteriori fu storicizzato, si usò una categoria temporale, definendolo un seicentesco, oppure una categoria stilistica, dicendolo un pittore del Barocco. Allo stesso modo, per esempio, Monet è un impressionista, appartiene a quella corrente, e ci parrebbe strano se qualcuno, in futuro, volesse nominarlo diversamente. Così un pittore che è stato definito o viene definito “contemporaneo”, in ossequio alla retorica dell’arte contemporanea, non potrà più essere denominato altrimenti. Resterà un contemporaneo anche quando non lo sarà più dal punto di vista cronologico.
Capisco la provocazione, ma dopo la Seconda guerra mondiale si sono alternati, precipitando, stili diversi e contrapposti… non si può non discernere.
Ha ragione, ma tra new, post, e ismi, i sotto stili ...